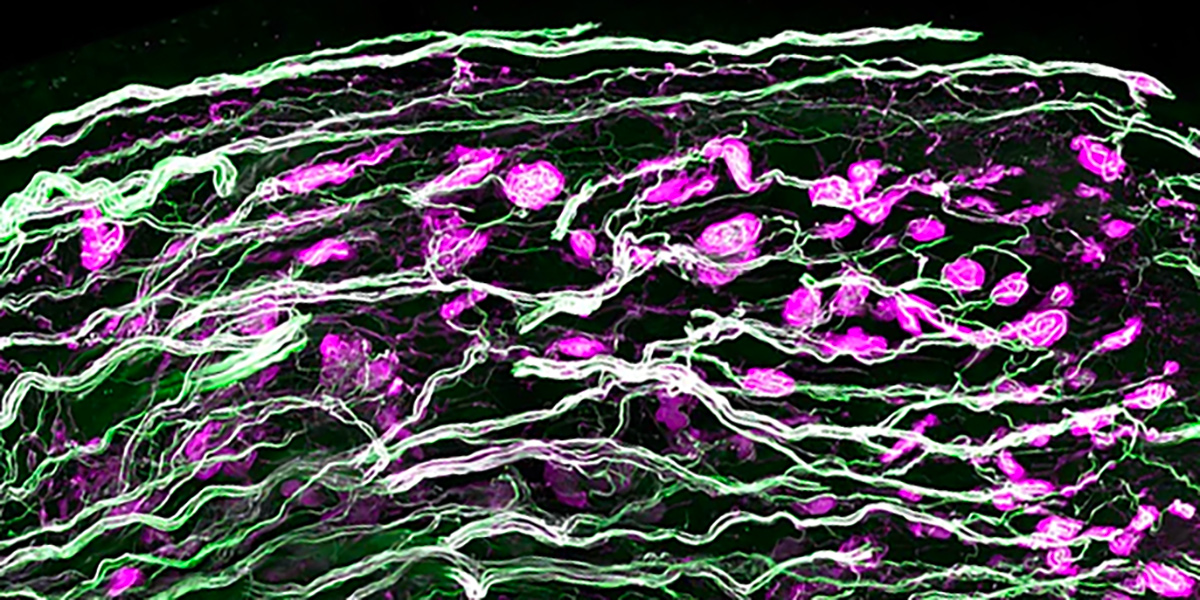Il solitario Keith Jarrett
Compie 75 anni uno dei pianisti più famosi del jazz, amato per i suoi concerti interamente improvvisati e odiato per il suo caratteraccio
di Stefano Vizio

Negli anni Settanta, una volta, Keith Jarrett si era appena seduto al grande pianoforte a coda montato sul palco di un anfiteatro all’aperto di Washington. Era solo, e rimase per diversi minuti in silenzio fissando la tastiera. A un certo punto, il religioso silenzio del pubblico fu interrotto da uno spettatore che gli gridò: «Do diesis maggiore!». «Grazie, ne avevo bisogno» rispose Jarrett, che su quell’accordo cominciò uno dei suoi celebri concerti di improvvisazione solitaria, che lo hanno reso uno dei più famosi e amati pianisti jazz di sempre.
Jarrett, che oggi compie 75 anni, ha registrato decine di dischi e suonato con alcuni dei più grandi jazzisti del Novecento, da Art Blakey a Miles Davis, e con il suo trio insieme al batterista Jack DeJohnette e al contrabbassista Gary Peacock è stato tra i più apprezzati interpreti di standard – quei classici che fanno parte del repertorio di tutti i jazzisti – degli anni Ottanta. Ma ancora oggi la sua fama è legata principalmente ai suoi concerti in cui, per decenni, ha improvvisato dalla prima all’ultima nota, producendo atmosfere e melodie diventate memorabili alla stregua di grandi canzoni pop, come quelle del suo disco più famoso e venduto, il Köln Concert del 1975.
Jarrett nacque nel 1945 ad Allentown, Pennsylvania, in una famiglia di origini europee (nonostante a lungo in molti abbiano creduto fosse afroamericano). Fu un bambino prodigio, che cominciò a suonare il piano prima dei tre anni e comparve in tv per la prima volta a cinque anni. La sua formazione musicale fu classica, una cosa che contribuì a rendere le sue composizioni sofisticate ed eclettiche, ma che lo limitò a lungo. Una volta, ha raccontato in un’intervista, stava suonando con un’orchestra e si dimenticò il momento in cui doveva iniziare a suonare, immerso nell’ascolto degli altri strumenti. Il direttore gli disse che non doveva ascoltarli, e quello lo convinse a lasciar perdere con la musica classica: «Ha distrutto il mio interesse a rimanere in quel mondo, perché il mio lavoro principale è ascoltare. Se stai improvvisando e non stai ascoltando, un secondo dopo hai finito le cose da dire». Insegnare a un musicista classico a improvvisare è quasi più difficile che insegnarlo a un contabile o a un idraulico, diceva.
La sua passione per il jazz maturò ascoltando il pianista Dave Brubeck negli anni Cinquanta, e proseguì quando negli anni Sessanta studiò alla Berklee di Boston. Si trasferì così a Manhattan, squattrinato, cominciando a suonare nei locali del Village e facendosi notare dal grande batterista Art Blakey, che lo volle nei suoi Jazz Messengers, una storica band che formò tantissimi giovani jazzisti. Fu in quel periodo che conobbe DeJohnette, che lo fece suonare con il sassofonista Charles Lloyd.
Era la fine degli anni Sessanta, e il jazz stava cominciando a fare i conti con il rock e la psichedelia, l’unica musica che interessava alle nuove generazioni. Con Lloyd, Jarrett svoltò la sua carriera, affermandosi come uno dei più talentuosi pianisti della sua generazione, quella dei musicisti che avevano cominciato dopo gli anni d’oro del jazz, a cavallo degli anni Cinquanta e Sessanta. I tempi furono particolarmente adatti, perché Miles Davis stava arruolando giovani e vulcanici musicisti per un disco visionario e pazzo, Bitches Brew, che sarebbe diventato uno dei più venduti della storia del jazz.
Jarrett si unì alla band di Davis nel tour successivo al disco, adattandosi agli strumenti elettrici che voleva Davis, suonando l’organo elettrico e il celebre Fender Rhodes, un pianoforte elettrico dal suono molto riconoscibile. Per capirsi sul livello della band che accompagnava Davis in quel periodo, Jarrett sarebbe diventato forse il più famoso dei tre pianisti, ma non di molto: gli altri erano Chick Corea e Joe Zawinul, che avrebbe poi fondato i Weather Report. Con quel disco, Davis avrebbe messo le basi della fusion, il genere che nacque dall’influenza del rock elettrico sul jazz, e che Jarrett avrebbe continuato a suonare per alcuni anni con Davis, un po’ malvolentieri.
A interessarlo infatti era soprattutto il pianoforte acustico, che riprese appena poté mettendo su il suo “quartetto americano”, composto tra gli altri dal geniale contrabbassista Charlie Haden, quello della band di Ornette Coleman. Con quella formazione Jarrett avrebbe registrato molti dischi negli anni successivi, alcuni dei quali sarebbero diventati tra i più apprezzati dischi di jazz e free jazz degli anni Settanta, come nel caso di The Survivor’s Suite del 1977. Il quartetto americano fu affiancato a un certo punto da quello “europeo”, composto da altri tre musicisti scandinavi, tra cui il sassofonista Jan Garbarek: era la prima metà degli anni Settanta, più o meno lo stesso periodo in cui Jarrett cominciò a fare quello che forse gli sarebbe venuto meglio: i concerti (e i dischi) da solo.
Il suo primo disco di questo tipo, Facing You, uscì nel 1971. Il successo inizialmente fu modesto, ma le cose cambiarono quando cominciò a fare i concerti improvvisando completamente. Era una cosa che avevano fatto in pochi, e nessuno come lui. Diventarono subito amatissimi: Jarrett aveva un senso della melodia micidiale ed era capace di creare dal nulla temi e fraseggi formidabili, che sviluppava per minuti e minuti ripetendoli, modificandoli, stravolgendoli e poi richiamandoli tra di loro nel corso del concerto.
Nella stessa sera si inventava pezzi blues, citava standard jazz, alternava il baccano del free jazz più arrabbiato a lunghi intermezzi intimisti e romantici. Tirava fuori dal nulla passaggi e temi orecchiabili, alternando passaggi virtuosi ad altri delicatissimi, accompagnamenti ossessivi e spesso volutamente grossolani ad altri che facevano ballare la gente sulle sedie. Spesso quello che suonava aveva poco di jazz, e sconfinava in mille altri generi diversi, per pochi secondi o per intere sezioni del concerto: tutti elementi che resero le sue esibizioni molto popolari anche tra i non appassionati del genere.
Come tanti altri grandi pianisti, Jarrett sfruttava al massimo le potenzialità ritmiche dello strumento, percuotendo sui tasti per tirare fuori suoni a tratti simili a quelli di una batteria. Nei suoi concerti, poi, si accovacciava, si alzava in piedi, batteva i piedi per terra e faceva continui versi e gemiti, per accompagnare la melodia o per ampliarla: e lo si sente benissimo nei tantissimi che registrò in giro per il mondo.
Uno di questi ebbe più fortuna degli altri, nonostante le premesse catastrofiche. Quando arrivò alla Opernhaus di Colonia, in Germania, il 24 gennaio del 1975, Jarrett trovò un pianoforte diverso da quello richiesto. Non solo diverso: era malconcio e scordato. Ma non si riuscì a sostituirlo, e dopo ore di accordatura fu sistemata davvero soltanto la parte centrale della tastiera: i tasti più bassi e più acuti continuavano a suonare malissimo. Jarrett era stanco e dolorante alla schiena, e non voleva neanche esibirsi. Perfino la cena in un ristorante italiano lì vicino ebbe ritardi e problemi, e quando si sedette al pianoforte erano le undici e mezza di sera.
Cominciò riproducendo al pianoforte il motivo suonato dagli altoparlanti del teatro per annunciare l’inizio dello spettacolo, e infatti si sente anche qualche risata del pubblico. Era una cosa che Jarrett faceva spesso, grazie al suo orecchio assoluto, imitando i rumori più vari come il verso di un gabbiano passato per caso sopra l’arena in cui suonava. In qualche modo, comunque, nonostante gli imprevisti e gli ostacoli in quel teatro di Colonia nel gennaio del 1975 ebbe luogo quello che ancora oggi è considerato uno dei più leggendari concerti della storia del jazz.
I concerti improvvisati di Jarrett continuarono negli anni successivi, con una lunga pausa negli anni Novanta per problemi di salute. Con l’aumentare della sua popolarità, però, emerse il suo gran caratteraccio, molto raccontato e citato tra gli appassionati di jazz. Nei decenni si sono accumulati tantissimi aneddoti, la maggior parte dei quali ruota intorno alla sua grande insofferenza per qualsiasi forma di disturbo proveniente dal pubblico. Nella sua carriera Jarrett ha interrotto concerti per qualche colpo di tosse di troppo o per qualche commento scambiato dal pubblico, ma soprattutto, a partire dagli anni Duemila, per le foto del pubblico.
In quella che è forse diventata la più famosa sbroccata da palco della storia del jazz moderno, Jarrett disse al pubblico che si era radunato a Perugia per sentirlo nell’edizione del 2007 di Umbria Jazz che «quegli stronzi con la macchina fotografica devono metterla via subito», perché il privilegio era di chi stava ascoltando lui, DeJohnette e Peacock. Se avesse visto un altro flash, disse, si sarebbe riservato il diritto di smettere di suonare e «di lasciare questa cazzo di città». Fu un episodio spiacevole a detta di tutti, e il direttore del festival Carlo Pagnotta disse che Jarrett non sarebbe tornato.
A sorpresa, invece, fu invitato di nuovo nel 2013: ci andò, ma appena salito sul palco intravide qualcuno nelle prime file scattare una foto senza flash, nonostante le accorate raccomandazioni di Pagnotta, e se ne andò via per un po’. Dovette salire il suo manager a chiedere di nuovo la collaborazione del pubblico, e Jarrett infine tornò sul palco, facendo buona parte del concerto al buio, per prevenire nuovi fotografi clandestini.
La sua produzione più apprezzata, oltre ai concerti da solo, è stata quella dei dischi di standard con DeJohnette e Peacock, cominciata nel 1983 con due dischi molto venduti, Standards Vol. 1 e Vol. 2. Sono ormai alcuni anni che Jarrett non fa più concerti, nonostante abbia fatto uscire diversi dischi dal vivo: vive in una casa ottocentesca in un minuscolo paese del New Jersey, ed esce molto poco.