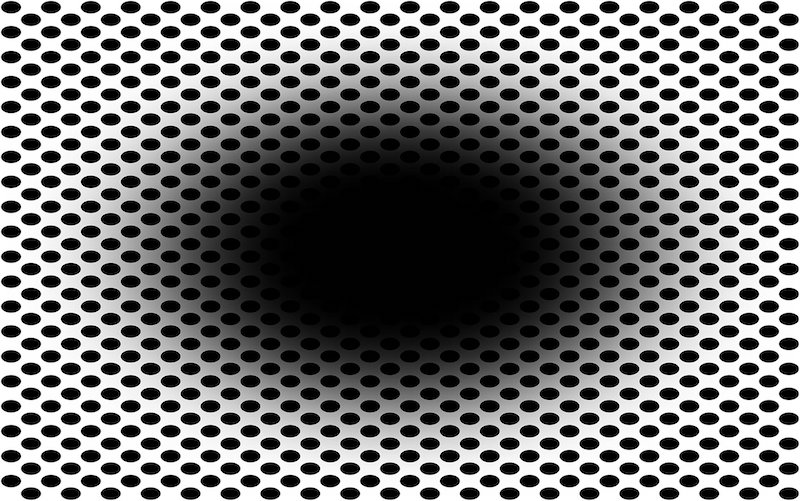Si diventa immuni al coronavirus?
È la domanda delle domande di questa pandemia: non c'è ancora una risposta definitiva, ma iniziano a esserci i primi indizi
di Emanuele Menietti – @emenietti
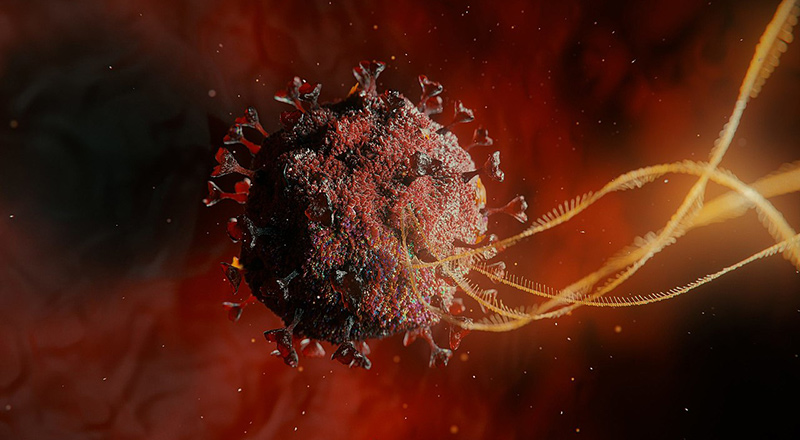
Lo scorso fine settimana l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha invitato i governi a non diffondere il concetto di “patente di immunità”, chiarendo che a oggi non ci sono prove scientifiche chiare per sostenere che si diventi immuni al coronavirus dopo avere superato l’infezione. Queste “patenti” dovrebbero consentire di identificare chi ha già avuto il virus e che potrebbe quindi tornare ad avere una vita attiva sia socialmente sia lavorativamente, senza comportare ulteriori rischi per i nuovi contagi. L’idea è stata molto promossa anche in Italia da alcuni esponenti politici, come il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, ma proprio come ha spiegato l’OMS è un messaggio rischioso che sembra ignorare la domanda più grande di questa pandemia: si diventa immuni al coronavirus?
Dalla risposta a questa domanda deriveranno moltissime decisioni e sviluppi dell’attuale emergenza sanitaria. Non solo perché la capacità di diventare immuni farà si che la malattia sia meno presente tra la popolazione, man mano che molte persone contrarranno il coronavirus, ma anche perché consentirà di capire se e quanto potremo fare affidamento sui vaccini per raggiungere un buon livello di immunizzazione.
Come si diventa immuni
Il sistema immunitario è la nostra principale difesa dagli agenti esterni (antigeni), come virus e batteri. Semplificando moltissimo, possiamo dire che comprende due livelli di difesa: uno più generalizzato e uno più specifico.
Il primo livello è l’immunità innata, una risorsa di primo intervento sempre pronta ad attivarsi quando viene identificata la presenza di una minaccia esterna che si è intrufolata nel nostro organismo. Non costituisce una risposta mirata e può essere paragonata a un bombardamento a tappeto: induce la produzione di sostanze che distruggono le cellule esposte all’infezione e stimolano l’infiammazione, con un conseguente aumento della temperatura per creare un ambiente ostile alla minaccia.
È un sistema fatto per agire punto e basta. Si rivela spesso efficace, ma è piuttosto grezzo: provvede a distruggere, senza imparare nulla dall’antigene che ha incontrato sulla sua strada o a serbarne memoria per futuri incontri.
In molti casi, questa prima risposta viene seguita da una reazione più precisa e misurata che deriva dall’immunità adattiva. In pratica, il sistema immunitario impara a riconoscere l’antigene e a produrre anticorpi specializzati, che si occuperanno dell’agente infettivo e di distruggere solamente le cellule infette, preservando le altre. È una risposta molto più sofisticata di quella di primo livello, e richiede un po’ di tempo prima che possa attivarsi e rivelarsi efficace.
Nel caso dell’attuale coronavirus, le ricerche preliminari diffuse finora (quindi da prendere con qualche cautela in più) dicono che sia necessaria una decina di giorni prima che l’organismo inizi a produrre anticorpi specifici. Anche per questo motivo buona parte degli sforzi in ospedale, per i pazienti più gravi, sono orientati a prendere tempo e a rallentare la diffusione dell’infezione, nell’attesa che l’immunità adattiva faccia il proprio dovere.
Durata dell’immunità
Con diverse malattie, la memoria immunitaria si sviluppa proprio grazie alla risposta dell’immunità adattiva e molte ricerche indicano come, più è intensa la risposta, migliore sia la durata del ricordo acquisito dal nostro sistema immunitario sulla minaccia.
Diverse malattie tipiche dell’infanzia – come il morbillo, la varicella e la parotite (gli “orecchioni”) – inducono un’immunità di solito permanente, e lo stesso si può ottenere attraverso le vaccinazioni contro queste malattie evitando i rischi che comportano, talvolta letali (meglio vaccinarsi, che ammalarsi). Altre malattie si rivelano invece più sfuggenti e non comportano un’immunizzazione definitiva: può dipendere sia dagli agenti infettivi che le causano, sia dalla loro capacità di mutare nel tempo (come avviene per esempio con l’influenza stagionale).
Coronavirus
I coronavirus che interessano gli esseri umani sono sette, compreso l’attuale (SARS-CoV-2). I quattro noti da più tempo, cioè dai primi anni Sessanta, sono responsabili di sintomi lievi alle vie aeree superiori e sono tra le cause di quello che chiamiamo raffreddore comune. Li prendiamo più volte nella vita e il nostro sistema immunitario tende a serbarne memoria per poco meno di un anno.
Gli altri due coronavirus noti – oltre all’attuale – sono quelli che causano la SARS e la MERS, due sindromi respiratorie che possono portare a sintomi piuttosto gravi, e in alcuni casi alla morte.
Le due malattie sono di recente scoperta (la SARS fu identificata nel 2003, la MERS nel 2012) e non ci sono molti studi sulla durata dell’immunità nelle persone che le hanno avute. Sembra comunque che inducano una memoria più lunga dei coronavirus del raffreddore, con una durata di qualche anno. Il coronavirus che causa la SARS ha diverse cose in comune con l’attuale virus, e questo lascia quindi ottimisti alcuni virologi sulla possibilità di sviluppare una memoria immunitaria per un tempo sufficiente da rendere utile il ricorso a un vaccino.
Se e per quanto
Basandosi sulle conoscenze degli altri coronavirus e più in generale delle malattie infettive, diversi virologi e immunologi ritengono che probabilmente il problema non sia tanto se si diventi immuni, ma per quanto si resti immuni. La possibilità di diventarlo a vita sembra esclusa, ma un vaccino o l’immunizzazione per chi si è ammalato potrebbero essere sufficienti per offrire qualche protezione in più, rendendo meno rischiosa una seconda infezione da SARS-CoV-2.
Se fossero confermate queste circostanze, un vaccino potrebbe consentire di tenere sotto controllo la malattia, riducendo la circolazione del coronavirus a livelli più che accettabili per evitare nuove epidemie su larga scala. Per i primi anni potrebbe essere necessario vaccinare periodicamente le persone più esposte al rischio di contagio o di sviluppare sintomi gravi, in attesa che il coronavirus circoli sempre meno nella comunità.
E chi si riammala?
Nelle settimane scorse sono circolate informazioni su persone che dopo essere guarite dalla COVID-19 si sarebbero ammalate nuovamente. Le segnalazioni sono state sporadiche e le cause di questi episodi potrebbero essere diverse e non strettamente legate all’immunizzazione.
Di solito una persona viene definita “guarita” quando non manifesta più i sintomi della malattia e risulta negativa a un test di controllo, eseguito tramite un prelievo con tampone. Test di questo tipo sono piuttosto affidabili, ma può accadere che in alcune circostanze non diano un esito chiaro sull’effettiva scomparsa del coronavirus. Secondo gli esperti i rari casi segnalati sono probabilmente ricadute, dovute alla carica virale che torna a crescere causando nuovamente sintomi, che comunque si rivelano di solito molto più lievi rispetto all’infezione precedente.
Per comprensibili motivi etici e di tutela della salute dei pazienti, non sono stati condotti esperimenti su individui guariti per provare a indurre una nuova infezione, esponendoli nuovamente al coronavirus. Un gruppo di ricercatori ha tentato questa strada con due macachi, infettandoli una prima volta per indurre una risposta immunitaria e una seconda volta per verificare se fosse stato mantenuto il ricordo dell’agente infettivo. I due macachi non si sono ammalati nuovamente, indicando il probabile mantenimento dell’immunità, ma lo studio ha previsto condizioni molto specifiche e l’impiego di due sole cavie animali, quindi non offre grandi spunti per ipotizzare che cosa possa accadere negli esseri umani.
Riassumendo
A oggi non ci sono evidenze scientifiche sufficienti per affermare che si diventi immuni al coronavirus, anche se ci sono indizi in questo senso, né tanto meno elementi per stabilire quanto a lungo possa durare un’eventuale immunizzazione. La malattia causata dal virus è del resto conosciuta da circa quattro mesi, un tempo molto limitato per fare analisi e valutazioni sugli ex infetti e che potrebbero avere sviluppato un’immunità. Saranno necessari mesi prima di stabilire modalità e tempo di immunizzazione, e per questo come suggerisce l’OMS non si potrà fare ancora troppo affidamento sui test sierologici.