L’effetto che ci fanno i buchi neri
Sono «macchine potentissime per creare metafore», dice Francesco Guglieri nel suo saggio dedicato al sublime contemporaneo: quello dei libri di scienza

La scienza contemporanea, in tutti i suoi campi, ha raggiunto livelli di complessità tali per cui è molto difficile – per chi nella vita si occupa d’altro – capire bene ciò che sappiamo, oggi, sulla vita, l’Universo e tutto quanto. Anche leggendo i libri di scienza rivolti a lettori non specialisti ci vuole tempo e concentrazione per farsi un’idea di cosa siano cose come i bosoni, le onde gravitazionali o le stringhe (posto che queste esistano). Leggendo questi libri, e interessandoci agli attuali confini della scienza, possiamo però sperimentare una forma contemporanea di sublime: quella sensazione che mescola fascino e paura che i romantici dell’Ottocento provavano di fronte a tempeste e paesaggi naturali.
Che oggi si possa trovare il sublime nella contemplazione dei buchi neri e delle teorie sull’origine della vita è la tesi di Leggere la terra e il cielo. Letteratura scientifica per non scienziati, un saggio pubblicato da Laterza e da oggi in libreria. Lo ha scritto Francesco Guglieri, editor della narrativa straniera da Einaudi e autore per varie riviste culturali, nonché grande appassionato di fantascienza e libri di scienza. Nel suo saggio ne passa in rassegna 19 – tra cui gli ormai classici Dal Big Bang ai buchi neri di Stephen Hawking, Il gene egoista di Richard Dawkins e L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello di Oliver Sacks, ma anche i più recenti L’ordine del tempo di Carlo Rovelli e Sapiens di Yuval Noah Harari – mettendo insieme un’agile guida alla lettura che invoglia a saperne di più, di tutto.
Pubblichiamo il capitolo di Leggere la terra e il cielo dedicato a Buchi neri e salti temporali di Kip Thorne, un saggio del 1994 che secondo Guglieri è «il più bello senza dubbio» a proposito dei buchi neri.
***
Qualcuno dovrebbe scrivere una storia culturale dei buchi neri. Non un libro sui buchi neri. Di quelli ne esistono molti: il più bello è senza dubbio Buchi neri e salti temporali, di Kip Thorne. Ma un libro sull’idea di buco nero non mi pare che qualcuno l’abbia già fatto: un testo che racconti le apparizioni di questi corpi celesti nella cultura popolare (ad esempio nei film di fantascienza), il significato che vi hanno visto, di volta in volta, artisti, scrittori e musicisti, l’uso che ne hanno fatto filosofi o giornalisti (“il buco nero del debito pubblico”).
Un libro del genere manca, ed è un peccato. Perché, se uno guarda bene, i buchi neri attraversano tutta la cultura degli ultimi cinquant’anni almeno, svolgendovi una precisa funzione: i buchi neri sono degli straordinari motori dell’immaginazione. Sono i migliori che abbiamo trovato finora.
Tutto in loro – dal modo in cui sono stati scoperti ai paradossi che provocano, dal mistero che ancora li ammanta fino al nome stesso che portano – sembra fatto per catturare l’immaginazione, per attivare la fantasia e il racconto. Sono delle macchine potentissime per creare metafore, per stabilire similitudini e paralleli con gli affanni umani: la loro trascendente impenetrabilità, la divina indifferenza che continuano a opporci, il loro appartenere di fatto a un altro universo, li rende degli oracoli perfetti da interrogare. E nei loro responsi, come nelle macchie di Rorschach, ognuno ci leggerà qualcosa di diverso.
Perché i buchi neri ci attraggono così tanto, perché ne subiamo il fascino potentissimo e inquietante, seducente e terribile?
Ogni epoca ha avuto i suoi motori dell’immaginazione. In passato questa funzione l’hanno svolta le terre inesplorate, le colonne d’Ercole, i leoni sulle mappe, le macchie bianche sugli atlanti. Questi spazi bianchi, nella seconda metà del Novecento (quando sulla terra sembravano finite le terre da esplorare), sono stati i buchi neri.
Ma cos’è esattamente un buco nero? Fondamentalmente è una regione dello spazio-tempo verso cui la materia è sospinta, con un’attrazione gravitazionale così forte che nulla può sfuggirvi, nessuna particella, nessuna informazione, nemmeno la luce. Si forma quando una stella raggiunge il termine del suo ciclo vitale: quando quasi tutto l’idrogeno che forma una stella si è trasformato in elio, si interrompono le reazioni nucleari. In questo modo la pressione “verso l’esterno” cessa di essere in equilibrio con la gravità che spinge il materiale stellare verso il suo nucleo e la stella implode. Tutta la massa che formava la stella si concentra in dimensioni sempre più piccole e dense, fino a contrarsi (se la stella di partenza aveva certe caratteristiche) alle dimensioni puntiformi della singolarità, un “luogo” privo di estensione spaziale ma di densità e massa infinite. Questa singolarità, non dissimile probabilmente da quella da cui è nato l’universo, genera, per la sua massa, una tale forza di gravità da incurvare lo spazio-tempo: ciò che cade al di là dell’orizzonte degli eventi, il confine al di là del quale la gravità diventa una forza invincibile, non può più uscirne.
Forse parte del fascino che i buchi neri esercitano su di noi va cercata anche nel modo in cui sono stati scoperti. All’inizio, infatti, un buco nero era semplicemente ciò che si otteneva portando alle estreme ma logiche conseguenze le regole della relatività generale: ben pochi però, a cominciare da Einstein, credevano che oggetti tanto bizzarri potessero esistere davvero in natura. Pure ipotesi, poco più che esercizi mentali. Solo nella seconda metà del Novecento si sono accumulate abbastanza prove sperimentali indirette da rendere la loro esistenza certa. Questa è già una cosa di una bellezza che toglie il fiato: con il ragionamento e una manciata di equazioni, gli eredi di Einstein sono arrivati a ipotizzare che nello spazio profondo ci fossero oggetti così massicci da ripiegare il tempo intorno a loro e di fatto abdicare da questo universo. Soltanto il 10 aprile 2019 l’Event Horizon Telescope, un consorzio internazionale di ricercatori, ha reso pubblica un’immagine ottenuta attraverso la sua rete di radiotelescopi diffusa su tutto il pianeta (dalle Hawaii al Cile, all’Antartide, così da trasformare la terra stessa un’unica enorme antenna). Si tratta dell’immagine del buco nero supermassiccio M87, distante 55 milioni di anni luce: per la prima volta nella storia l’umanità ha ottenuto una prova visiva dell’esistenza dei buchi neri.
***
I buchi neri sono come una cassa del tesoro che nasconde una serie quasi infinita di paradossi temporali, indizi sull’origine dell’universo e sulla sua fine, sulla natura del tempo e della materia, ipotesi per viaggi nello spazio e nel tempo, quando non – secondo alcuni – cunicoli per accedere ad altri universi. Una cassa del tesoro di cui si cerca la chiave.
Buchi neri e salti temporali di Thorne è tanto la cassa del tesoro quanto la chiave per aprirla.
È un libro importante non solo perché è il testo più esaustivo e informato sui buchi neri in circolazione (dopo averlo letto difficilmente un lettore comune può imparare qualcosa di più sull’argomento senza passare alle pubblicazioni accademiche o iscriversi a Fisica), ma anche perché fornisce una risposta alla domanda di prima: perché siamo così attratti dai buchi neri? E lo fa fin dalle primissime righe: «Di tutte le cose concepite dalla mente umana, dagli unicorni alle gargouille, fino alla bomba all’idrogeno, la più fantastica è forse il buco nero». È come se, prima di indossare i rigorosi panni dello studioso, Thorne facesse balenare per un attimo l’incantamento del mago. Come se per lui i buchi neri meritassero un posto di primo piano in un manuale di zoologia fantastica, accanto all’ippogrifo, il basilisco o l’uroboro. Poi, per le successive seicento e passa pagine dense di grafici, tabelle e formule, si atterrà strettamente alla concretezza scientifica, ma in quelle prime due righe è come se stringesse un patto con il lettore: d’ora in poi, lettore, ti muoverai sul terreno del Meraviglioso.
Dentro Buchi neri e salti temporali c’è tutto: la storia della scoperta dei buchi neri e degli uomini che l’hanno fatta (da John Wheeler, che coniò, non senza malizia, l’espressione buchi neri, a Stephen Hawking, che una volta scommise un abbonamento a «Penthouse» con Kip Thorne sulla non esistenza dei buchi neri); l’esposizione delle teorie che hanno reso possibile concepire i buchi neri (a cominciare dalla relatività generale e dalla fisica quantistica) e di tutto ciò che rappresenta lo stato dell’arte sullo studio dei buchi neri fino a metà degli anni Novanta (quando il libro uscì).
Vi viene descritto anche come Thorne con alcuni colleghi, alla fine degli anni Settanta, ideò un possibile esperimento per registrare le onde gravitazionali prodotte dallo scontro di due buchi neri. Le onde gravitazionali sono piccole increspature, simili a quelle prodotte da un sasso lanciato in un laghetto. Solo che in questo caso non è l’acqua a contrarsi e allungarsi con moto ondulatorio, ma il tessuto dello spazio-tempo. Quello che Thorne non poteva sapere mentre scriveva il suo libro è che nel 2014 quell’esperimento, che nel frattempo era stato messo in piedi con investimenti di milioni di dollari, avrebbe registrato, per la prima volta nella storia dell’uomo, il «suono» delle onde gravitazionali. Tre anni più tardi, nel 2017, Thorne e altri due colleghi saranno insigniti del premio Nobel per la fisica.
Ma non è solo per questo che Buchi neri e salti temporali è un libro prezioso: il fatto è che, insieme al suo autore, è stato anche una potente fonte di ispirazione per l’immaginario contemporaneo. Leggendolo è come se potessimo sporgere la testa nel futuro (e nel passato) delle storie legate ai buchi neri. È un deposito praticamente infinito di narrazioni potenziali.
Se, ad esempio, nel corso della lettura vi verrà in mente Interstellar, sappiate che non è certo per caso, dal momento che il regista Christopher Nolan si è ispirato proprio alle ricerche di Thorne, che gli ha fatto da consulente.
Il plot di Interstellar è complicato dai paradossi temporali resi possibili dai buchi neri, ma fondamentalmente è la storia di un astronauta che attraversa l’universo ed entra in un buco nero per comunicare nel passato con sua figlia. Nel film i buchi neri sono delle figure della nostalgia: qualcosa che, lacerando le leggi dello spazio-tempo, rende possibile un incontro mancato, il ricongiungimento del protagonista con la figlia. E alimenta la speranza, ottimista, che dalla prigione del tempo ci sia possibilità di fuggire.
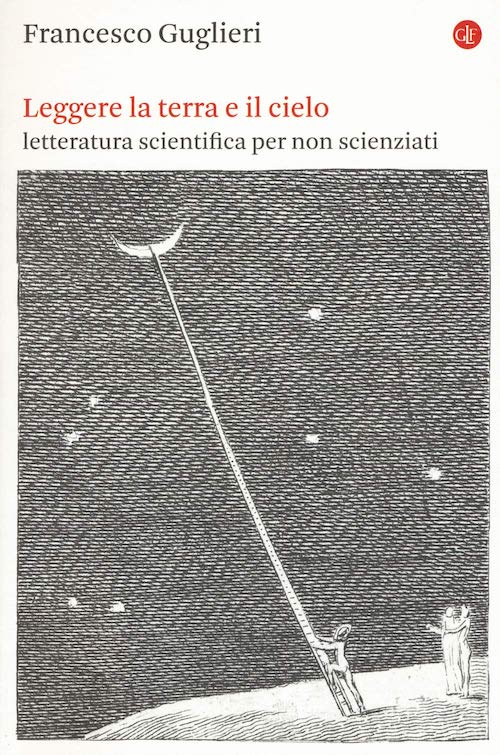
L’immagine sulla copertina di “Leggere la terra e il cielo” è un’incisione di William Blake del 1793; si intitola “I want, I want”.
Nell’aprile del 1975 la rivista «Le Scienze» pubblicò un articolo dal titolo La ricerca dei buchi neri. L’autore era un trentacinquenne Kip Thorne, già allora uno dei maggiori esperti al mondo di buchi neri, gravità e relatività generale. All’epoca «Le Scienze» era molto seguita in Italia, e tra i lettori che rimasero affascinati dall’articolo di Thorne ci furono Primo Levi e Italo Calvino. Quest’ultimo ne scrisse sul «Corriere della Sera» nella sua rubrica «Osservatorio del signor Palomar»: il testo, che poi confluirà in uno dei suoi ultimi libri, Palomar appunto, dette anche vita alla piccola polemica con Margherita Hack, che in un articolo successivo accusò Calvino – lo abbiamo già ricordato – di aver frainteso alcuni elementi del saggio di Thorne. Levi, dal canto suo, ne fu tanto colpito che, sull’onda emotiva di quella lettura, compose una delle sue poesie più belle e terribili, Le stelle nere. «Le legioni celesti sono un groviglio di mostri, / L’universo ci assedia cieco, violento e strano. / Il sereno è cosparso d’orribili soli morti, / Sedimenti densissimi d’atomi stritolati»: i versi di Levi sembrano provenire essi stessi da qualche lontana stella morta e portare con sé l’idea di una memoria, quella della Shoah, che continua a incombere col suo distruttivo potere attrattivo. Il buco nero qui è quello della storia, il trauma da cui non si riesce a fuggire, quella massa così pesante e oscura che continua a tenerci avvinti con la sua gravità. Schiacciati a terra.
Sei anni dopo, l’immagine dei buchi neri, per Levi, cambia leggermente. Nel 1981 l’autore di Se questo è un uomo inserì l’articolo di Thorne in La ricerca delle radici, una sorta di “antologia personale” in cui raccolse i testi e gli autori che l’avevano formato e influenzato. Quello di Thorne è l’ultimo brano della raccolta: è come se Levi lo usasse con l’intento preciso di suonare in chiusura una nota profonda e cupa, trascendente e maestosa, ma in cui allo stesso tempo risuonasse una vena argentata di speranza. Il testo è preceduto, come gli altri, da un breve cappello introduttivo di Levi dal titolo Siamo soli. Per merito degli astrofisici, scrive Levi, è in corso una grande rivoluzione culturale: le loro scoperte hanno spalancato lo sguardo degli uomini su un cielo popolato di mostri indicibili e oscuri, di fronte ai quali il profano può solo «reprimere brividi inediti, tacere e pensarci su». L’esplorazione del sistema solare, poi, ha confermato l’assenza di altre forme di vita, almeno nelle immediate vicinanze. «Siamo soli», fragili, abbandonati sotto un cielo sterile e minaccioso, indifferente e lontano. Eppure, conclude Levi smarcandosi dalla disperazione senza redenzione di Le stelle nere, siamo anche l’intelligenza in grado di immaginare i buchi neri: «la mente umana ha concepito i buchi neri, ed osa sillogizzare quanto è avvenuto nei primi attimi della creazione, perché non dovrebbe saper debellare la paura, il bisogno e il dolore?».
Levi ha apposto in apertura al libro un grafico su cui dispone gli autori antologizzati lungo un asse che va da Giobbe ai buchi neri: come a dire che dalla domanda sul perché esiste il male, perché siamo gettati in un mondo di «paura, bisogno e dolore», si arrivasse al sublime cosmico dei buchi neri. Stelle nere, indifferenti e ostili, ma allo stesso tempo penetrabili dall’intelligenza umana. Alla fine, in Levi, al pessimismo radicale si oppone un cauto, illuminista ottimismo: «il cielo non è semplice, ma neppure impermeabile alla nostra mente, ed attende di essere decifrato. La miseria dell’uomo ha un’altra faccia, che è di nobiltà».
© 2020, Gius. Laterza & Figli



