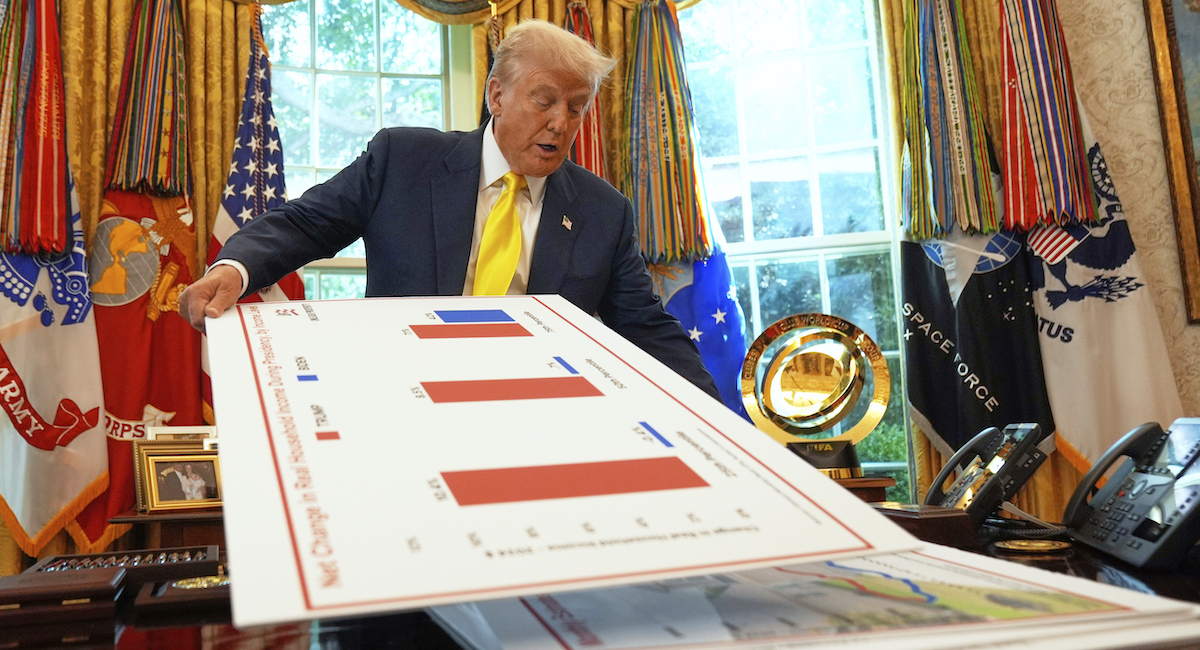Non è vero che la moda è la seconda industria più inquinante al mondo
La moda ha sicuramente un forte impatto ambientale: il problema è che i dati che circolano su questo tema sono infondati

Alden Wicker è un’esperta di moda sostenibile, di cui ha scritto per giornali e riviste come Vox, Vogue Business, Glamour e The Cut, ed è la fondatrice di EcoCult, un blog dedicato all’argomento. Wicker ha raccontato spesso che le statistiche più citate sull’inquinamento dell’industria della moda sono infondate, e questo non per sostenere che la moda non abbia un importante impatto sull’ambiente – ce l’ha – ma per invitare a farne di più serie e attendibili, e a non far circolare notizie false nemmeno se si è benintenzionati (molti di quelli che fanno circolare notizie false, infatti, si sentono spesso benitenzionati). Nel 2017, per esempio, Wicker fu la prima a raccontare che non era vero, o perlomeno non era mai stato dimostrato, che la moda è la seconda industria più inquinante al mondo, come si legge spesso. Di recente ha raccolto su Vox alcuni dei dati infondati riportati più spesso: per esempio che la moda è responsabile dell’8-10 per cento delle emissioni di gas serra mondiali, che produce tra gli 80 e i 150 miliardi di indumenti all’anno e che quasi tre quinti di tutti i vestiti finiscono nelle discariche o vengono distrutti entro un anno dalla produzione.
Il problema, spiega, è che questi dati sono condivisi da fonti autorevoli come le Nazioni Unite, la Banca Mondiale, l’autorevole società di consulenza McKinsey, molti sindacati internazionali e giornali come il Wall Street Journal e il New York Times. Nessuno però si basa sulla ricerca, su dati o sulla scienza ma soltanto su «sensazioni, link rotti, marketing e qualcosa che qualcuno disse nel 2003». Di base funziona così: un’organizzazione o un giornale riporta un dato senza citarne la fonte o renderlo verificabile, e questo dato viene ripreso e condiviso da altre organizzazioni che lo diffondono acriticamente all’infinito.
Un esempio è la storia di come si è diffuso il dato per cui la moda sarebbe la seconda industria al mondo per emissioni di gas serra, dopo quella petrolifera. Probabilmente la fonte è un dato utilizzato una volta da Linda Greer, una ex scienziata del Natural Resources Defense Council, un’associazione ambientalista statunitense e ora collaboratrice di una ONG ambientalista cinese. Anni fa Greer aveva scoperto che nella provincia cinese molto industrializzata di Jiangsu l’industria tessile era la seconda industria responsabile dell’inquinamento dell’acqua, dopo quella chimica. Si servì di questo dato per fondare un programma che migliorò l’uso dell’acqua e l’efficenza energetica nelle fabbriche cinesi, ma nel frattempo l’informazione – infondata – iniziò a circolare e prese una strada autonoma, cambiando completamente. Nonostante il debunking che ne fece Wicker nel 2017, il dato è ancora in circolazione.
Wicker fa un altro esempio di come si diffondano informazioni simili. Un rapporto della Fondazione ambientalista Ellen MacArthur sostiene che il 20 per cento dell’inquinamento industriale dell’acqua derivi dall’industria della moda; lo stesso dato è presente anche nella rivista di moda EcoTextile News, che lo fa risalire a uno studio del 2012 della Banca Mondiale; contattata da Wicker, però, la Banca Mondiale ha negato di essere l’origine dell’informazione. Circola molto anche un altro dato attribuito alla Banca Mondiale, cioè che l’80 per cento della manodopera delle fabbriche di vestiti di tutto il mondo è costituita da donne; il dato diffuso dall’istituzione però era riferito soltanto al Bangladesh ed era in contrasto con un’altra percentuale, che parlava del 54 per cento della manodopera del paese anziché dell’80 per cento.
La statistica per cui gli americani gettino una media di 35 chili di vestiti all’anno viene dalla Environmental Protection Agency, ma contrariamente a quanto riportato di solito comprende anche tappeti, materassi e in generale qualsiasi oggetto tessile. Un altro dato molto citato riguarda la quantità di emissioni di gas serra di cui è responsabile l’industria dell’abbigliamento. Secondo le Nazioni Unite sarebbe il 10 per cento, secondo un rapporto della società di consulenza Quantis, l’8 per cento. Greer ha raccontato di aver chiesto a Quantis su cosa si basassero i suoi calcoli ma di non aver mai ricevuto risposta. Il rapporto venne eliminato dal sito per qualche mese e poi ripubblicato con un nuovo nome e continua a essere citato spesso.
Wicker non è l’unica che sta cercando di fermare il diffondersi di notizie false sull’inquinamento dovuto alla moda. Maxine Bédat è la co-fondactrice di Zady, che produceva e vendeva online vestiti interamente sostenibili. Dopo la chiusura di Zady, nel 2017, Bédat fondò New Standard Institute, un’organizzazione che ha l’obiettivo di raccogliere informazioni attendibili sull’impatto ambientale della moda e di fare pressione sulle aziende perché lo limitino. Bédat ha scoperto dopo lunghe ricerche che le statistiche più citate non si appoggiano a niente e, parlando con Wicker, ha detto di non considerare affidabile nessuno dei dati finora analizzati.
La mancanza di dati affidabili inficia ogni tentativo di fare qualcosa di buono e rischia di sprecare gli investimenti di chi vuole migliorare le cose. Per esempio i governi di alcuni paesi nordeuropei stanno investendo per migliorare il riciclaggio dei tessuti usati, anche a partire da un dato mai verificato, cioè che il 99 per cento degli abiti vecchi e abbandonati finisce nelle discariche o negli inceneritori. Un altro esempio è l’accordo firmato nel 2019 da 150 aziende che si impegnavano a raggiungere obiettivi basati sui dati scientifici e riguardanti le emissioni, la biodiversità, la riduzione della plastica, entro il 2050. Spesso però le aziende non sono in grado di seguire dall’inizio la filiera produttiva e di sapere quindi dove tagliare le emissioni (secondo Greer, Nike è l’unica azienda che chiede regolarmente dati sulle emissioni alle fabbriche in Cina con cui collabora).
«È ovvio», spiega Wicker, «che prima di fare qualsiasi altra cosa – chiedere una legge, inventare nuovi tessuti, avere nuovi obiettivi – dobbiamo capire che tipo di ricerca ci serve e poi chiedere al governo e alle grandi aziende di finanziarlo». Insomma, il sistema industriale della moda sicuramente inquina il pianeta, e sicuramente – come il resto delle attività umane – avrebbe molto bisogno di essere reso sostenibile: ma si può sostenerlo senza diffondere dati privi di fondamento, e anzi si può farlo con più forza se non si corre il rischio di essere smentiti da chi non abbia interesse a cambiare le cose.