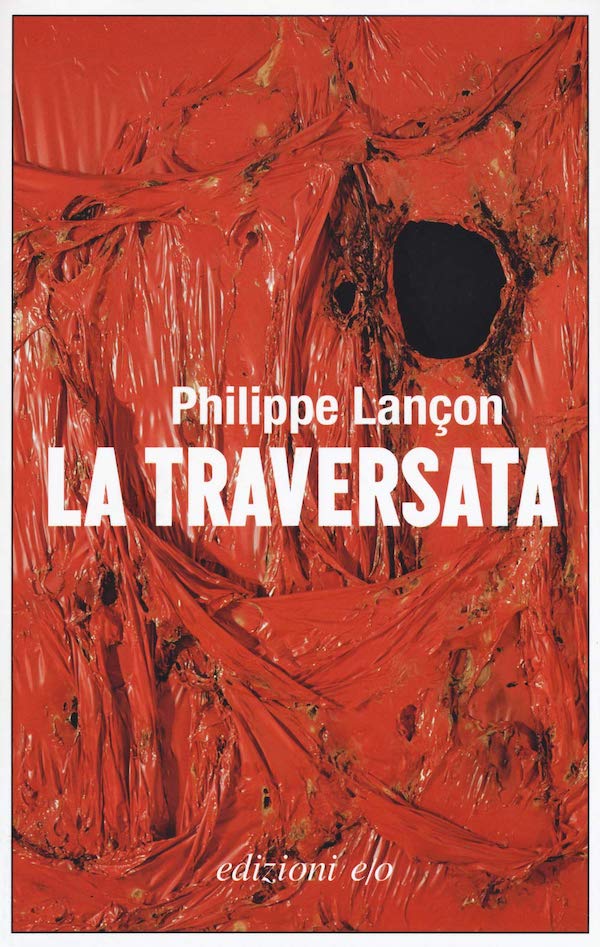La riunione di redazione di Charlie Hebdo, prima dell’attentato del 2015
Raccontata nel libro di Philippe Lançon, un giornalista del settimanale che fu ferito al viso

Philippe Lançon è un giornalista e scrittore francese che da anni lavora sia per il quotidiano Libération che per il settimanale satirico Charlie Hebdo. Ci lavorava anche nel 2015 ed era una delle persone presenti alla riunione di redazione del 7 gennaio, il giorno dell’attentato in cui morirono 12 persone e 11 furono ferite. Lançon fu colpito al viso da una pallottola, che gli distrusse parte della mandibola. Per questo per nove mesi è stato ricoverato in ospedale e ha subito 15 diverse operazioni chirurgiche. Due settimane fa è uscito anche in Italia il libro in cui ha raccontato l’attentato e, soprattutto, come è cambiata la sua vita.
Il libro si intitola La traversata ed è piuttosto lungo, 460 pagine. Lançon inizialmente racconta la sera prima dell’attentato e, facendo una serie di digressioni, tutta la sua vita di giornalista prima, soffermandosi sul suo rapporto con i paesi a maggioranza musulmana. Poi arriva il racconto della riunione di redazione, quello dell’attentato e dei momenti subito successivi, quando Lançon si trovò ferito nella redazione di Charlie Hebdo e, in uno stato ancora confuso, cercò di avvisare i suoi familiari di essere vivo ma «sfigurato».
Le successive 360 pagine sono dedicate al periodo di permanenza di Lançon in ospedale, che ha tenuto il giornalista isolato dal mondo per molti mesi: in questo periodo ha dovuto adattarsi a essere diventato una persona diversa, ad avere nuovi rapporti di dipendenza dai suoi familiari e amici, ma anche dal personale medico. Il libro parla molto delle vicissitudini chirurgiche affrontate da Lançon (tra i personaggi principali c’è la sua chirurga), dei libri che ha letto nel periodo di degenza in ospedale (parti della Ricerca del tempo perduto di Marcel Proust, La montagna magica di Thomas Mann e le lettere di Franz Kafka, soprattutto) e di alcune delle lettere ricevute da conoscenti e sconosciuti dopo l’attentato.
In Francia La traversata è piaciuto molto e ha vinto due premi letterari, mentre negli Stati Uniti, come raccontato da Lançon in un’intervista a Il Venerdì di Repubblica, è piaciuto meno perché, a sua detta, «nei paesi anglosassoni si accettano poco le digressioni» che per lui «sono l’essenza della letteratura».
Pubblichiamo un estratto del terzo e del quarto capitolo, dove Lançon racconta di cosa si parlò durante la riunione di redazione del 7 gennaio 2015, fino a quando non fu interrotta.
***
Charlie ha avuto la sua importanza fino alla faccenda delle caricature di Maometto, nel 2006. È stato un momento cruciale: la maggior parte dei giornali, e anche certi notabili del disegno, si sono dissociati dal settimanale satirico che pubblicava quelle caricature in nome della libertà d’espressione. Gli uni ostentatamente preoccupati del buon gusto, gli altri perché non volevano far disperare il Billancourt musulmano. A volte sembrava di essere in una sala da tè, altre volte nella copia di una cella staliniana. Quell’assenza di solidarietà non era soltanto una vergogna professionale e morale, ma isolando e additando Charlie ha contribuito a farne il bersaglio degli islamisti. Lo scandalo che ne è seguito ha allontanato dal giornale buona parte dei lettori di estrema sinistra, ma anche i gerarchi della cultura e i trend setter, che per qualche anno ne avevano fatto un giornale alla moda. In seguito il suo declino è stato contrassegnato da una successione di sedi diverse, spesso brutte e lontane, che sembravano destinate solo a farci rimpiangere la vecchia sede di rue de Turbigo, nel cuore di Parigi, con la grande sala a vetrate. La più lugubre è stata quella sulla circonvallazione, incendiata dal tiro di una bottiglia Molotov in una notte di novembre del 2011. In una mattinata fredda e grigia ci eravamo ritrovati davanti a quel che ne restava dopo che l’acqua dei pompieri aveva finito di distruggere ciò che il fuoco aveva cominciato. L’archivio era diventato una pasta nera. Qualcuno piangeva. Eravamo oppressi da una violenza che non capivamo del tutto e che la società nel suo insieme, eccettuata l’estrema destra le cui ragioni e obiettivi non potevano essere i nostri, rifiutava di constatare. Non sapevamo chi fossero gli autori del gesto, ma non avevamo dubbi sulle loro motivazioni.
Verso le dieci e mezzo del 7 gennaio 2015 non erano molti in Francia a voler essere Charlie. L’epoca era cambiata e non potevamo farci niente. Il giornale aveva ormai importanza solo per pochi fedelissimi, per gli islamisti e per ogni genere di nemici più o meno civili che andavano dai ragazzi di periferia, che non lo leggevano, agli amici perenni dei dannati della terra, che lo tacciavano volentieri di razzismo. L’avevamo sentita salire, quella rabbia gretta che trasformava la lotta sociale in bigottismo. L’odio era un’ebbrezza; le minacce di morte, abituali; le mail di ingiurie, numerose. Mi capitava di imbattermi in edicolanti, di solito arabi, che sostenevano di non aver ricevuto il giornale con un’aria cattiva che sembrava rivendicare la bugia.
Impercettibilmente, il clima stava cambiando. È arrivato un momento, probabilmente dopo l’incendio doloso del 2011, in cui pur vergognandomi ho smesso di sfogliare Charlie sulla metro. Attiravamo sentimenti malevoli come fossimo un parafulmine, il che, devo dire, non ci rendeva né meno aggressivi né più intelligenti: non eravamo santi, e non potevamo imputare agli altri la responsabilità del fatto che lo spirito di Charlie fosse superato. Almeno lo sapevamo e continuavamo a riderci sopra. Una sera, in un ristorante alverniate che amava frequentare, Charb mi aveva detto: «Se ci mettiamo a rispettare quelli che non ci rispettano tanto vale chiudere bottega». Poi abbiamo continuato a bere vino rosso e mangiare carne con tanti saluti alle religioni e alla grande paura dei benpensanti che sentivamo montare. D’altronde, da quando non avevamo più bisogno di dimostrare qualcosa a qualcuno la riunione del mercoledì era tornata a essere quel momento libero e conviviale che aveva smesso di essere alla fine degli anni di Val e durante la crisi seguita alla sua uscita di scena. In occasione di quella crisi avevo sentito una volta di più quanto il mondo dell’estrema sinistra possedesse la dote del disprezzo, del furore, della malafede, dell’assenza di sfumature e dell’invettiva degradante. Almeno su quel piano, non aveva niente da invidiare al mondo dell’estrema destra. Continuo a chiedermi se in quel processo di distorsione fossero le convinzioni a distorcere il carattere o il carattere a distorcere le convinzioni.
Bernard Maris ha cominciato a dire tutto il bene possibile di Sottomissione. Houellebecq era diventato un amico, ed era chiaro che all’ammirazione che provava per lui si aggiungeva l’affetto. A un certo punto volevo andare in bagno, ma mi sono trattenuto perché la conversazione si stava animando. «Houellebecq è un reazionario» ha protestato Cabu. Non conoscevo ancora il brutto testo che lo scrittore gli aveva dedicato molti anni prima, e tuttora mi chiedo se Cabu l’avesse letto e se ne ricordasse. So però che non aveva letto Sottomissione. Gli unici ad averlo letto eravamo io e Bernard, e siamo stati gli unici a difenderlo. Quasi tutti gli altri stavano zitti o lo attaccavano.
Mi è tornato il malumore. Anche lì, dove tutto era permesso e addirittura preteso, detestavo discutere di libri che avevo letto con persone che non li avevano letti. Per inciso, detestavo ancora di più la lezione di letteratura che mi accingevo a dare. Era una lezione inutile, perché ciò che accendeva il dibattito non era il libro, ma le opinioni e le provocazioni dell’autore, in un certo senso il suo pedigree. E quel pedigree non dava adito a dubbi: ciò che Houellebecq attaccava quasi sistematicamente era tutto quello per cui Charlie si era battuto negli anni Settanta: la società libertaria, permissiva, egualitaria, femminista e antirazzista. A riguardo il suo romanzo era chiaro: l’islamismo senza violenza, in fondo, non era poi così malvagio. Rimetteva uomini e donne al proprio posto e, sebbene non ci liberasse dal male, ci sbarazzava almeno dall’angoscia di essere liberi. Naturalmente, come Houellebecq stesso aveva detto su France Inter, si trattava di un romanzo in cui venivano espressi tutti i punti di vista senza che nessuno di essi potesse essere ricollegato al punto di vista dell’autore. Tuttavia emanava un pro- fumo che corrispondeva all’epoca. Era Houellebecq, l’icona pop, a diffonderlo col suo talento di narratore e la sua efficace ambiguità. Houellebecq aveva saputo dare forma al panico contemporaneo. Charlie è uno dei miei due giornali, ho pensato, ma il bravo romanziere ha sempre ragione, perché è lui che leggiamo o che leggeremo. Mi pare proprio di aver fatto, insieme a Bernard Maris, quella spiegazione del testo, quella difesa e illustrazione di Houellebecq sotto lo sguardo luminoso e amorevole di Sigolène Vinson, la cui benevolenza mi tranquillizzava. Mi sono chiesto se, più leggera di un cerbiatto, quella mattina fosse venuta con la sua grossa Harley-Davidson. Non avevo visto la moto quando avevo legato la bicicletta per strada. Bernard parlava, io parlavo, Cabu mugugnava, Wolinski disegnava sorridendo. Mi domandavo se non sarei finito nel suo taccuino di fronte a una donnina nuda che mi avrebbe detto più o meno: «Zitto!» in una forma che non ero in grado di concepire. Più probabilmente stava disegnando un nuovo nudo ispirato da Sigolène, di cui apprezzava il fascino e la figura. Inventava creature abbastanza belle e sexy per far dire loro liberamente e con insolenza tutto ciò che lui avrebbe voluto dire o sentire. La bellezza ha di questi privilegi.
Non so più come e perché la discussione sia passata dal romanzo di Houellebecq allo stato delle periferie, ma immagino che i musulmani ci abbiano fornito una transizione naturale. «Come siamo arrivati a questo punto?» ha chiesto qualcuno. «Come abbiamo potuto lasciar andare alla deriva popolazioni intere?». Mi pare che Tignous se la sia presa con la sinistra e con la politica che portava avanti da trent’anni. Bernard Maris è saltato su: «Ma no! Non è colpa dello Stato! È stato investito denaro a palate sulle periferie. Hanno tentato di tutto, ma niente ha funzionato!». Tignous ha alzato la voce. Ha parlato della periferia da cui veniva lui, Montreuil, e dei suoi amici d’infanzia. Molti di loro erano morti, finiti in prigione o devastati da qualcosa. «Io ne sono uscito» ha tuonato, «ma loro? Che hanno fatto per loro, perché avessero un’opportunità? Niente! Non hanno fatto niente. E continuano a non fare niente per quelli che vengono dopo, per tutti quelli che non hanno un lavoro né un’occupazione, che ciondolano per strada e sono condannati a diventare ciò che ne abbiamo fatto noi, degli islamisti, dei pazzi furiosi, e non venirmi a dire che lo Stato ha fatto tutto per loro. Non ha fatto proprio niente, lo Stato. Li lascia crepare. È un pezzo che se ne frega!». Sto ricostituendo, riassumendolo, un discorso molto più perentorio, arrabbiato, limpido, un discorso che sgorgava dal cuore, brandendo la matita, che l’accento popolare del disegnatore aveva trasformato in un grido di rabbia in favore dei poveri delle periferie, dei disoccupati, dei violenti, degli arabi, dei musulmani, dei terroristi. Bernard non ha replicato e io ho pensato che era arrivato il momento di andarmene.
Erano le 11.25, forse le 11.28. Il tempo sparisce nel momento in cui vorrei ricordarmelo con precisione, come un arazzo filato da una parca di nome Penelope il cui insieme dipende da ogni singolo punto. Tutto si regge, ma tutto si disfa.
Mi sono alzato e ho infilato il giaccone. Era arrivato il momento di andare a Libération e scrivere sulla Dodicesima notte, e prima ancora su Blue Note, il librone di jazz che stava nello zainetto che mi ero portato cinque anni prima da Medellín, in Colombia. Era uno zainetto di tela nera molto leggero su cui erano riprodotte alcune caricature di celebrità nazionali. Me ne separavo di rado. È scomparso.
Me l’aveva regalato lo scrittore Héctor Abad, autore di un libro sulla vita e la morte del padre e sulla storia tragica del suo paese, L’oblio che saremo. Eravamo nel negozio di libri usati che Héctor aveva aperto a Medellín con qualche amico. Ho saputo in seguito che per mancanza di soldi si era trasferito. Mi sono sempre piaciute le piccole librerie invase da vecchi volumi che sembrano rubare il posto all’aria. Sono capanne in fondo alle città, in fondo ai boschi, mi danno la sensazione che niente di male potrà mai succedervi: labirinti senza angoscia né minaccia. La sua era piccola e si chiamava Palinuro.
Palinuro è il nocchiero di Enea. Apollo gli manda il sonno mentre lui sta navigando nella notte. Cade in acqua con tutto il timone e approda su una costa dove viene trucidato da gente crudele. La sua anima erra nell’Ade, dove Enea, che lo credeva semplicemente affogato, lo ritrova, e l’ombra di Palinuro gli racconta della sua vera fine. Bisogna raggiungere i morti per sapere dove sono andati, ma quel giorno, alle 11.25 o forse 11.28, con lo zainetto di tela nera in spalla, ancora non lo sapevo. Nettuno aveva promesso a Venere che Enea e i suoi sarebbero arrivati sani e salvi alle soglie dell’Averno, ma quell’immunità aveva un prezzo: «Un solo uomo andrà perduto e sarà cercato nell’abisso. Una sola testa cadrà in cambio di quella degli altri».
Il padre di Héctor, militante democratico, viene ucciso nel 1987 da assassini paramilitari su un marciapiede di Medellín. Il figlio arriva quasi subito. In una tasca del vestito del padre trova una poesia attribuita a Borges che comincia con il verso da cui ha origine il titolo del suo libro: “Siamo già l’oblio che saremo”. È il talismano e l’ultima traccia, l’ultimo mistero del morto. Siccome non fa parte delle opere repertoriate, la sua autenticità è contestata. Héctor ne cerca l’origine incerta da un capo all’altro del mondo, e quella ricerca diventa l’argomento di un secondo libro, Traiciones de la memoria. Verificare se è un falso oppure no diventa per lui una questione fondamentale. È il messaggio che il padre gli ha lasciato suo malgrado. L’indagine sulle tracce di una vita brutalmente interrotta è ciò che resta quando la morte si porta via quelli che ci mancano lasciandoci in qualche modo soli al mondo. A questo tipo di investigatore viene rimproverata spesso la sua ossessione, perché comunque non è possibile rimproverargli il suo dolore e il suo sgomento, almeno non subito. Quelli che non hanno l’ossessione, gli eleganti e gli indifferenti che passano ad altro, non fanno parte del mondo in cui deve vivere lui. Ci sono sicuramente vari modi di correggere più e più volte la brutta copia dei propri lutti, ma, come a scuola una volta che si è consegnato il compito, nessuno ha una gomma per cancellare ciò che è stato.
Quello zainetto mi ricordava sempre Héctor, il suo libro, la morte del padre, la vita e la morte del narcotrafficante Pablo Escobar, le poesie di Borges e la bellezza della valle di Medellín. Con quello zainetto mi sentivo qui e altrove, aperto a tutta l’umanità, e avevo la sensazione di poter tornare in ogni momento in Colombia, paese in cui sono state commesse le peggiori nefandezze nel cuore della più estrema bellezza. Stavo per andarmene quando, scorgendo Cabu, ho tirato fuori il libro di jazz per farglielo vedere, in particolare per mostrargli una foto del batterista Elvin Jones.
Nel 2004, dopo aver saputo che era morto, ho scritto un articolo su di lui per Charlie. Cabu, dal canto suo, si ricorda di quando ha visto il batterista al festival all’aperto di Châteauvallon. Me lo racconta, e io inserisco il suo ricordo nell’articolo: “All’improvviso scoppia il temporale, violento. I musicisti e gran parte del pubblico scompaiono poco a poco, come nella Sinfonia degli addii. Tutti se ne vanno tranne Jones. Scatenato, immenso, battendo il tempo dall’oltretomba, il gigante dalle mani d’acciaio anima tamburi e piatti in mezzo ai lampi, solo come un dio dimenticato, un dio orientale dalle mille braccia. Il temporale sembra creato da lui, per lui. Ci si fonde dentro. Ha cinquant’anni, il tuono rimane”. Succedeva nel 1977. Ventisette anni dopo Cabu ne fa un disegno che, messo accanto al mio articolo, gli dà un valore che non ha, o che comunque non avrebbe avuto senza quel disegno: essere “illustrato” da Cabu, in particolare sul jazz, o meglio corredare con un testo una delle sue vignette mi fa tornare all’adolescenza felice, quella in cui oltre a Céline scoprivo Cavanna, Coltrane e Cabu. È un po’ come se, scrivendo nel 1905 un romanzo che si svolge nell’ambiente delle ballerine, le illustrazioni fossero di Degas.
Se Elvin Jones non fosse morto non avrei scritto quell’articolo. Se non avessi scritto quell’articolo Cabu non avrebbe disegnato la vignetta. Se Cabu non avesse disegnato la vignetta, quella mattina non mi sarei fermato per fargli vedere il libro di jazz che me l’aveva fatta venire in mente. Se non mi fossi fermato a mostrargli il libro sarei uscito due minuti prima e mi sarei imbattuto negli assassini all’ingresso o sulle scale, ho rifatto cento volte il calcolo. Probabilmente mi avrebbero spedito qualche pallottola in testa e avrei raggiunto gli altri Palinuro, i miei compagni, sulla costa della gente crudele e nel solo inferno che esiste: quello in cui non si vive più.
Ho posato il libro sul tavolo da riunione e ho detto a Cabu: «Aspetta, ti faccio vedere una cosa…». Ci ho messo un po’ a trovare la foto che cercavo. Dato che avevo fretta, ho rimpianto di non aver segnato la pagina. Ma come avrei potuto farlo se un attimo prima non sapevo che gliel’avrei mostrata? Non sapevo che quel giorno sarebbe stato presente, anche se saltava raramente la riunione del mercoledì: Cabu aveva disegnato un sacco di somari, ma era un bravo scolaro.
La foto di Elvin Jones è del 1964 e sta alle pagine 152-153. È un primo piano. Il batterista si accende una sigaretta con la mano destra, enorme e al tempo stesso affusolata, che tiene le bacchette a croce. Indossa un’elegante camicia a quadratini leggermente aperta. Le maniche non sono rimboccate. Aspira dalla sigaretta con gli occhi chiusi. Metà del viso, potente e spigoloso, è catturata nel triangolo superiore disegnato dalle due bacchette, come nelle forme di un quadro cubista. La foto è stata scattata durante la registrazione di un disco di Wayne Shorter, Night Dreamer. Cabu l’ha apprezzata quanto l’avevo apprezzata io. Ero felice di fargliela vedere. Alla fine, il jazz era la cosa che mi avvicinava di più a lui. Quanto al libro, lo conosceva già.
L’abbiamo sfogliato. L’ho chiuso quando Bernard si è avvicinato e mi ha detto: «Non vuoi scrivere un pezzo su Houellebecq?». Ero sensibile al suo entusiasmo, sempre annunciato da un ampio sorriso da coniglio benevolo. Ero sensibile a quel particolare candore non privo di malizia che nasceva dai suoi slanci di simpatia e dalla sua perpetua curiosità, tuttavia ho risposto più o meno: «Ah no! Ho appena scritto su Libération quello che ne penso, non mi va di fare una minestra riscaldata». Dall’altro capo del tavolo Charb ha detto: «Oh sì, ti prego, facci la minestrina riscaldata…». C’è stato qualche sorriso e in quel momento, appena detta la battuta, un rumore secco come un petardo e le prime grida all’ingresso hanno interrotto il flusso dei nostri lazzi e delle nostre vite. Non ho avuto il tempo di rimettere il libro di jazz nello zainetto nero. Non ho neanche avuto il tempo di pensarlo, e tutto il consueto è scomparso.
Copyright © 2018 by Editions Gallimard, Paris
Copyright © 2018 by Edizioni e/o
Traduzione di Alberto Bracci Testasecca