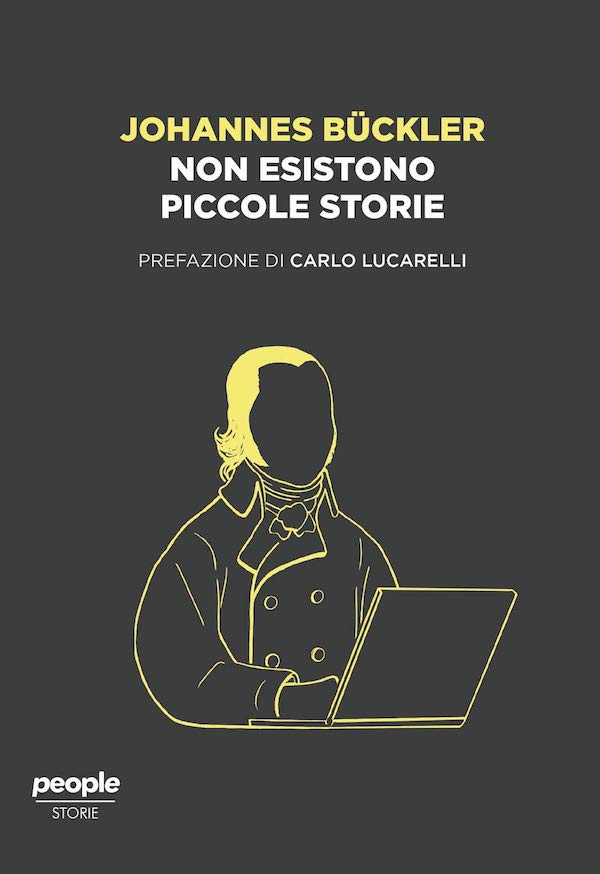Tre storie raccontate da @JohannesBuckler
È uscito un libro della persona che – dietro uno pseudonimo – racconta storie su un profilo Twitter molto popolare

Chi frequenta molto Twitter potrebbe essersi imbattuto in uno dei thread di Johannes Bückler: sequenze di tweet collegati tra loro che raccontano storie di persone poco note ma realmente esistite che per qualche ragione vale la pena ricordare. Le storie di Bückler sono raccontate generalmente in prima persona e sono costruite in modo da commuovere: alcune sono storie di partigiani antifascisti, altre di ebrei morti nei campi di concentramento; alcune hanno per protagoniste persone uccise dalla mafia o dal terrorismo dei cosiddetti “anni di piombo”, oppure di persone che in tempi più o meno remoti hanno subito gravi atti razzisti.
Johannes Bückler (è uno pseudonimo, ispirato al nome di una specie di Robin Hood tedesco vissuto a fine Settecento) le racconta da alcuni anni e nel tempo ha accumulato quasi 50mila follower. Ora alcune di queste storie sono state raccolte in un libro, pubblicato dalla casa editrice People e il cui ricavato sarà donato all’Associazione Amici di Adwa. Il libro si intitola Non esistono piccole storie. Nella prefazione lo scrittore Carlo Lucarelli definisce Johannes Bückler «un narratore, e uno di quelli bravi», per due ragioni. La prima è che quando racconta una storia, la storia funziona: «Quando la finisco, un po’ mi dispiace perché non ce n’è più, ma sono contento di averla letta e, da lettore, ne aspetto un’altra». La seconda sono le «emozioni che quella storia produce»:
Perché può essere breve, può essere sconosciuta o conosciutissima, marginale e di nicchia, può sembrare inutile o piccola piccola, ma se ha fatto scattare la scintilla nel narratore allora è sempre una storia importante, che per quanto breve, marginale e piccola, è una storia che al lettore parla.
Non solo, insegna. Accende una luce sul presente, mette in scena un meccanismo, fa arrabbiare, ma anche sorridere o piangere, e per quanto credevi di conoscerlo, quel fatto o quella persona lì, ti accorgi che no, così non li conoscevi, ed ecco che arriva uno spunto di riflessione, un collegamento, un pensiero, che, soprattutto in questi tempi, magari sempre ma soprattutto adesso, è un dono di Dio.
Di queste storie ne pubblichiamo tre.
***
Sopravvissuta alla fucilazione
«Il fascismo sta cercando di rialzare la testa. Posso dirlo con cognizione di causa perché io il fascismo l’ho visto in faccia. E lo abbiamo sconfitto. Ci foste stati voi, politici e non, capaci solo di litigare, a quest’ora ci sarebbe ancora la dittatura.»
E vi dirò di più. La Resistenza di noi donne non fu marginale. Eravamo crocerossine certo, staffette, assistenti, ma abbiamo subito arresti, torture, violenze, deportazioni e fucilazioni.
35mila le donne partigiane. 4.653 quelle arrestate e torturate. 2.750 deportate, 2.900 uccise. E poi c’ero io.
Ricordate i vostri diciotto anni? Immagino di sì, e spero siano stati sereni. Un’età importante. L’affetto dei vostri genitori, gli amici, le giornate in biblioteca a studiare, le serate in discoteca. O una passeggiata a cavallo. Un momento della vita particolare, indimenticabile.
I miei diciott’anni? Un ricordo nitido. Un giorno esatto. L’11 agosto 1944. Il luogo? Villa San Prospero. Un salone, la bandiera della Repubblica di Salò e alle pareti i ritratti di Mussolini e Hitler. Non era una festa, ma un interrogatorio.
Violento, perché io stavo zitta. E lui che mi picchiava.
“Lui” era il camerata Raffaele Raffaeli, un fascista caratterizzato da un estremo fanatismo ideologico, come suo padre.
Mi avevano arrestato alle dieci del mattino.
Ero in bicicletta nei pressi di Marzeno quando i fascisti mi avevano riconosciuto.
«È Annunziata Verità, l’amica dei partigiani, di quel bastardo comunista di Marx Emiliani che abbiamo fucilato alla schiena il 30 dicembre del 1943.»
Già. E in tre mi avevano tirata giù dalla bicicletta e picchiata. E portata con altri contadini a Villa San Prospero.
E poi la scelta. Per la fucilazione. Io, Annunziata Verità, 18 anni; Carlo Casalini, 50 anni, celibe; Emilio Nanni, 35 anni, sposato, con un figlio di 7 anni; Luigi Sangiorgi, 33 anni, celibe; Giuseppe Savini, 36 anni, sposato e padre di due bambini.
«Condannata a morte.»
Quelle parole mi risuonarono nella testa tutta la notte.
Fino alle quattro del mattino, quando ci caricarono su un camion. Con noi una decina di fascisti con mitra e moschetti e alcuni tedeschi. Direzione: cimitero di Rivalta. Ci legarono tutti insieme e ci misero davanti al muro del cimitero. Girati di schiena come si fa con i traditori. Le braccia sollevate in alto contro il muro. Non riuscivo nemmeno a piangere. E poi l’ordine di Raffaeli: «Plotone, attenti. Caricare. Puntare. Fuoco!».
Oggi è il 25 aprile del 2019.
E come ogni anno, io, Annunziata Verità, sono qui davanti alla lapide che ricorda i miei quattro compagni morti fucilati quel giorno. Eppure, dopo i primi colpi, ero stata proprio io, Nunziatina, a cadere.
Non so se fu voluto, ma la scarica mi colpì tutte e due le braccia che tenevo in alto. Sentii un gran bruciore e mi lasciai cadere. Ho ancora le cicatrici dei proiettili che mi trapassarono le braccia. Mi finsi morta.
Raffaeli diede il colpo di grazia in testa a tutti. Ma la mia testa era finita sotto i corpi e il proiettile la prese di striscio.
Non credo ai miracoli. So soltanto che sono sopravvissuta. Mi slegai da sola dalle corde, con i denti. Quando i fascisti scoprirono che non ero tra i cadaveri, ero già in fuga verso i monti.
Ricordate Raffaele Raffaeli che mi aveva picchiata durante l’interrogatorio e che aveva esploso i colpi di grazia sui miei compagni? È morto tranquillamente nel suo letto nel 1981. Mai condannato, come gli altri otto fascisti responsabili.
O meglio: furono condannati a pene pesanti in primo grado, poi arrivò l’amnistia di Togliatti, poi la Cassazione ribaltò le condanne e alla fine degli anni Cinquanta erano tutti liberi.
Raffaelli a Roma aveva agganci in campo ecclesiastico. Non era laureato, ma un prete gli offrì la cattedra di insegnante di italiano al Liceo Classico del Cristo Re. Con una nuova identità: Antonio Petani.
È difficile oggi raccontare l’orrore, il terrore e la paura di quella notte. Condannata a morte, a soli diciotto anni. Sopravvissuta due volte.
Oggi sono tornata al cimitero di Rivalta. A fianco del cancello di ingresso, c’è una lapide con le foto e i nomi dei miei compagni. «Qui caddero fucilati il 12 agosto 1944».
Il soldato tedesco ideale
Mi chiamo Werner e oggi sono stato scelto come immagine per un manifesto di reclutamento nella Wehrmacht.
Siamo nel 1939 e indosso la divisa tedesca, pronto a partire per l’invasione della Polonia.
Sono stato scelto come “il soldato tedesco ideale puro ariano”. Vi state forse chiedendo com’è fatto un perfetto soldato tedesco, ariano puro? Come me.
Occhi azzurri, zigomi alti, mento cesellato, scatola cranica stretta e allungata. E uno sguardo glaciale.
Niente a che vedere con quelli di razza inferiore, riconoscibili dal naso adunco, la bocca larga, i capelli ricci e rossi, le labbra carnose e il corpo villoso.
Almeno così sono identificati i tedeschi non ariani, di razza impura. Gli ebrei, per esempio.
Se noi siamo sul gradino più alto, gli ebrei occupano quello più basso della razza umana. Esseri animaleschi e abbietti. Dei primitivi. Però in Germania si dice che quelli siano furbi, capaci di assoggettare il mondo, come provato dai Protocolli di Sion. Quindi…
Quando la mia Germania ha cercato di identificare gli ebrei sono però cominciati i primi problemi. Per esempio con i matrimoni misti tra ariani ed ebrei e la loro discendenza. Si sono chiesti: quale matrice genetica avrà prevalso? L’ariana o l’ebraica?
Come distinguere con precisione quel tipo di ebreo?
Allora hanno iniziato a chiamarle “Mischling”, le persone che avevano antenati sia ariani che ebraici. Mezzosangue, ibridi insomma. Erano state le leggi di Norimberga a stabilirlo.
Così si sono inventati il “mezzo ebreo”, ibrido di primo grado che ha due nonni su quattro ebrei. Poi c’era l’ibrido di secondo grado che ha un nonno su quattro ebreo. Ebreo per un quarto, insomma. Poi c’era quello per tre quarti. E poi quello per…
Un bel guazzabuglio.
Fu una tragedia pure per molti “ibridi”. Nemmeno sapevano di essere ebrei e non avevano più contatti con le comunità ebraiche. La maggior parte era cristiana e battezzata. Loro si sentivano tedeschi e molti pure antisemiti.
Che fecero allora? Be’. I modi per “ripulirsi” del sangue ebraico erano diversi. Circa duemila ebrei ridiventarono ariani tramite raccomandazioni presso lo stesso Hitler. Altro modo fu quello utilizzato per esempio dal Feldmaresciallo della Luftwaffe, Milch.
Di padre ebreo e madre ariana, quest’ultima firmò una dichiarazione dove affermava di aver generato il figlio con lo zio e non con il marito. Poi c’era il classico modo. Le sorelle di Wittgenstein diventarono “ariane” dopo aver pagato una fortuna ai nazisti.
Nel 1939 il censimento del Reich stabilì l’esistenza di 72mila “ibridi” di primo grado e 39mila di secondo grado. Lo storico Rigg afferma che furono almeno 160mila i soldati (ebrei per un quarto e spesso anche di più) che combatterono nelle file dell’esercito tedesco.
Ma torniamo a noi, anzi a me, Werner Goldberg.
Come vi ho detto il mio volto è stato usato sui poster destinati al reclutamento dei soldati tedeschi prima di partire per l’invasione della Polonia.
Non rimasi molto nell’esercito tedesco. Preferii essere assunto in un’azienda di uniformi per l’esercito.
Sono morto a Berlino il 28 settembre 2004, all’età di 84 anni con un sorriso stampato in volto.
Perché quel sorriso? E che dovevo fare? Ero stato scelto per gli occhi azzurri, gli zigomi alti, il mento cesellato, la scatola cranica stretta e allungata. Uno sguardo glaciale. Ed ero ebreo.
Di più. Ebreo per le leggi tedesche – in quanto mio padre era ebreo anche se convertito al protestantesimo e mia madre ariana – ma non per gli ebrei, in quanto il Talmud prevede che è ebreo solo chi è nato da madre ebrea. E così ero ebreo per i tedeschi e non lo ero per gli ebrei. E questa è la mia storia.
Adesso sapete quanto è assurdo considerare le persone per il sangue, per gli zigomi alti, il mento cesellato, il naso adunco, la bocca larga, i capelli ricci rossi e il corpo villoso, il colore della pelle, la razza, eccetera.
Anno 2015. A Tobolsk, in Russia, hanno utilizzato di nuovo la mia immagine per un monumento. Un monumento dedicato al perfetto soldato russo dell’Armata Rossa.
Occhi azzurri, zigomi alti, mento cesellato, scatola cranica… Vabbe’, ma allora ditelo.
***
Un sogno in fondo al mare
Uno sparo. Poi avevo sentito solo l’urlo della folla.
Non avevo nemmeno lasciato i blocchi che le altre erano già lontane. Ed ero ancora in curva quando loro già riposavano dopo il traguardo. Ultima. Anzi, ultimissima.
Eppure negli ultimi 50 metri era accaduto qualcosa. La gente sugli spalti aveva iniziato a incitarmi, a gridare il mio nome. Sinceramente avrei preferito diversamente. Non è che mi vergognavo, anzi. Stavo rappresentando il mio Paese, la Somalia, alle Olimpiadi di Pechino del 2008.
Avevo 17 anni, e un paio di scarpe regalatemi dalla squadra sudanese. Ultima con il tempo di 32”16, record personale. Dieci secondi dopo la prima, Veronica Campbell-Brown. Un abisso nei 200 metri piani.
Feci comunque il giro di campo con la bandiera del mio Paese al collo e poi rientrai negli spogliatoi. Pensando fosse finita. Mi sbagliavo. I giornalisti di tutto il mondo mi volevano. Per loro ero una notizia. La ragazzina venuta da un Paese in guerra, senza soldi, senza un campo per allenarsi e senza neppure un allenatore, pronta a sfidare il mondo intero. Avrei preferito essere intervistata per essere arrivata prima, non ultima.
Ero arrabbiata. Giurai che sarei ritornata per le Olimpiadi di Londra del 2012 pronta e allenata per vincere. Una promessa.
Che ci faccio qui, in mezzo al mare? Per quella promessa.
Ho poco tempo, quindi vi racconterò la mia storia. Dall’inizio.
Dimenticavo. Mi chiamo Saamia Yusuf Omar. Sono nata nel 1991 a Mogadiscio in piena guerra civile. Ultima di sei figli di una famiglia povera.
Fin da piccola amavo correre. Con mio fratello.
Be’, Alì non era proprio mio fratello. Fu lui a chiedermi di diventare sua sorella.
«Solo se riesci a prendermi» avevo risposto.
Mi aveva preso subito.
Era sopra di me e gli dissi: «Mi devi dare un bacio se vuoi essere mio fratello. Lo sai, sono le regole». «Abaayo, sorella.»
«Aboowe» ho risposto io «fratello».
Quel bacio sulla mia guancia non fu un granché. Troppo umidiccio.
Quando al mercato di Bakara uccisero papà con un colpo di rivoltella, tutto cambiò. Dovetti lasciare la scuola per occuparmi dei miei fratelli mentre mamma vendeva la frutta al mercato.
Cosa facevo nel poco tempo libero? Correvo. Sempre.
Io e Alì vivevamo nella stessa casa. Due famiglie di etnie diverse. Le strade tra i quartieri di Mogadiscio diventarono il mio campo di allenamento personale. A me e ad Alì non importava niente della guerra. Quel che contava era il nostro bel rapporto. E poter correre.
Sono cresciuta correndo. Il mio idolo? Mo Farah, mezzofondista britannico di origine somala. Avevo il suo poster in camera. Come sono arrivata a Pechino? Dopo aver vinto alcune gare per dilettanti avevo iniziato a partecipare a quelle per professionisti nel centro olimpico somalo.
Poco prima delle Olimpiadi avevo partecipato ai 100 metri piani ai campionati africani di atletica leggera del 2008. Ero arrivata ultima, ma ero stata selezionata per le Olimpiadi di Pechino del 2008 nei 200 metri.
Sapete già com’è andata.
Che accadde dopo? Perché sono in mezzo al mare?
Nel 2008, i gruppi di Al-Shabaab hanno iniziato a seminare il terrore nella mia terra. Ma io avevo quella promessa da mantenere. Il governo non poteva aiutare noi atleti e le strutture sportive erano danneggiate. Ma per andare alle Olimpiadi di Londra avevo bisogno di un allenatore.
Avevo deciso di venire in Europa a cercarlo, perché io, a quella promessa, non volevo rinunciare. Vincere le Olimpiadi di Londra era il mio sogno. E i sogni non si devono mai abbandonare.
Passando dall’Etiopia, avevo attraversato il Sudan e il deserto del Sahara, e poi ero arrivata in Libia.
2 aprile 2012. Ora sono qui, in mezzo al mare. In acqua. So che tra poco finirà tutto. Le forze cominciano a mancarmi. Però morire in mare non è giusto.
Per me che amo la terraferma e quella splendida sensazione di libertà quando corro in pista. Ma Lampedusa è troppo lontana.
Sono su una bagnarola con altre trecento persone. Poi il motore che borbotta e si spegne. La nave italiana in lontananza.
Il tuffo in mare. Io, che non so nuotare. Che a casa il mare lo sentivo dalla finestra, vicino, ma ci ero potuta andare solo una volta a bagnarmi i piedi.
Non so degli altri trecento. Alcuni li ho visti annaspare come me. Trecento persone, trecento esseri umani. Uomini, donne, bambini. Provenivano da Paesi diversi, con storie diverse, ma avevano tutti una cosa in comune: inseguivamo un sogno.
Un sogno finito in fondo al mare.