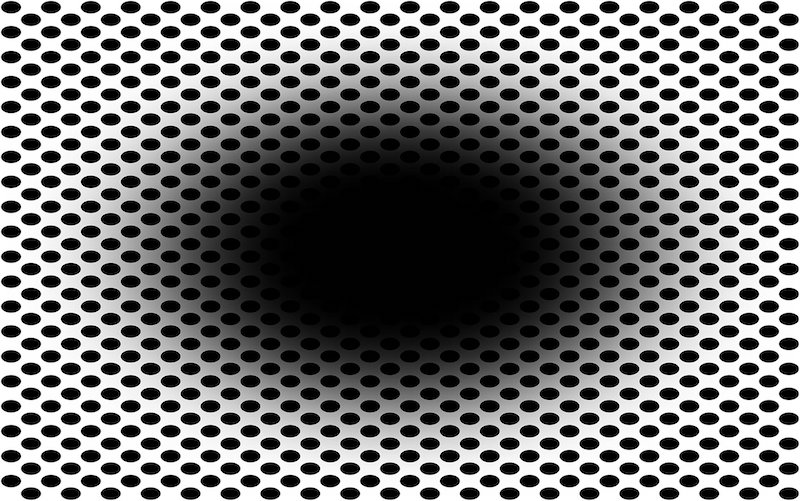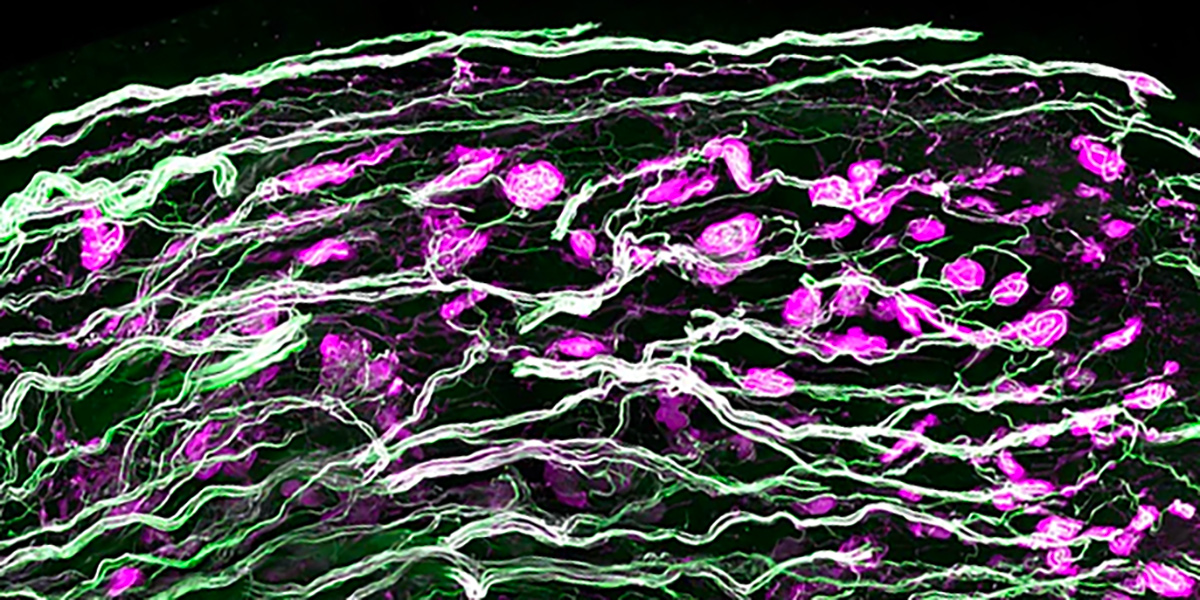Cos’è il curry?
La risposta è meno semplice di quanto sembri: non è la polverina che trovate al supermercato e nemmeno un tipico condimento indiano

Il pollo e il riso al curry sono piatti etnici mangiati abitualmente anche in Italia: si trovano al ristorante o già pronti in gastronomia, e molti li cucinano a casa aggiungendo alla carne o al riso basmati una polverina ocra e piccante chiamata “curry” che si trova al supermercato. In realtà però il curry non è né quel mix speziato né una tipica pietanza indiana: è un’invenzione britannica che dal Regno Unito – o meglio dall’Impero britannico – si è poi diffusa in varie forme in tutto il mondo, dall’Africa al Giappone.
Per prima cosa, in India non esiste nessun cibo chiamato curry: è un termine che venne inventato dagli europei della Compagnia delle Indie orientali nel Cinquecento probabilmente a partire dalle parole tamil khari o caril, che indicavano un particolare mix di spezie e il piatto cucinato con quel mix. Oggi, ha spiegato all’Atlantic Raghavan Iyer, autore del ricettario 660 Curries, per curry si intende «qualsiasi cosa abbia una salsa o un sugo, che sia speziato o meno»; in particolare in Regno Unito si usa per riferirsi al cibo indiano indiscriminatamente, anche se si parla quasi sempre di pietanze nate per compiacere i ricchi mercanti ai tempi del Colonialismo. In India, un paese dalle molteplici e diversissime cucine regionali, non esiste nemmeno il mix che in Italia chiamiamo curry e che in Regno Unito viene indicato come curry powder: venne inventato nel Settecento dai mercanti per il mercato britannico. La cosa più simile che esista in India è la garam masala, un miscuglio di spezie piccante e saporito che varia da regione a regione e da famiglia a famiglia. Comunemente prevede semi di cumino, cannella, cardamomo, pepe nero e chiodi di garofano, mentre l’abbondanza di curcuma è una variante britannica.
Anche il cibo che i britannici conobbero in India è il risultato di un sincretismo nato da invasioni e scambi commerciali. Come ha raccontato sempre all’Atlantic Lizzie Collingham – storica del cibo e autrice di Curry: A Tale of Cooks and Conquerors – la cucina dell’India del Nord venne profondamente influenzata dall’invasione dei Moghul, una dinastia che discendeva dal conquistatore turco-mongolo Tamerlano e che dominò il paese dal 1526 fino all’imporsi dell’Impero britannico nel 1858. I Moghul introdussero la cucina persiana, con il suo riso basmati molto aromatico e la carne marinata a lungo. Le salse cremose, il kebab (cioè carne a pezzettini infilzata su uno spiedo e grigliata) accompagnata dal riso, gli ingredienti costosi come zafferano, mandorle e pistacchi, sono tutti elementi di origine persiana portati dai Moghul. È così che nacque per esempio il biryani, uno dei più famosi piatti indiani, fatto di carne marinata (manzo, pollo o agnello) nello yogurt, quindi cotta e servita con riso speziato.
Per il curry che conosciamo fu fondamentale anche l’arrivo dei portoghesi a Goa, nel 1510. Furono loro a introdurre il peperoncino dalle Americhe che aggiunse la tipica piccantezza a quella data, fino a quel momento, dal pepe nero del Kerala. Sono responsabili di un’altra popolare pietanza indiana, il vindaloo. È la versione asiatica della carne de vinha d’alhos portoghese, preparata dai marinai macerando in aglio e vino rosso la carne di maiale essiccata; la versione indiana sostituisce il vino con l’aceto di cocco e aggiunge peperoncini essiccati. L’attuale ricetta anglo-indiana prevede che la carne venga marinata in aceto, zucchero, zenzero e altre spezie per tutta la notte e poi cotta in un ulteriore mix di spezie. Spesso nei ristoranti anglo-indiani di oggi è il piatto più piccante del menu: un po’ perché nel Cinquecento la cucina inglese era molto speziata, un po’ perché mangiare cibo pieno di peperoncino era una prova di virilità.
I britannici entrano in scena nella storia del curry proprio per il desiderio di spezie dei più ricchi, che portò alla nascita della Compagnia delle Indie orientali. I mercanti e i funzionari della Compagnia vivevano a lungo in India e non disdegnavano la cucina del posto; avevano a servizio cuochi indiani che preparavano i piatti costosi e prelibati della cucina moghul, come per esempio il biryani, con molte spezie e ingredienti raffinati. Gli inglesi adattavano questi piatti e mescolavano gli ingredienti che preferivano senza rispettare gli abbinamenti tradizionali e la provenienza regionale. Questa anarchia edonista era incentivata dai frequenti trasferimenti dei funzionari della Compagnia, che portavano con sé le salse e le spezie che preferivano finendo per accostare i piatti del nord con il chutney al mango (una specie di composta di spezie, verdura e frutta, dolce o agrodolce da accompagnare a piatti salati) o il cocco disidratato, entrambi tipici del sud. Fu così che il curry, un piatto staccato dalla tradizione e dalla cultura locale, inventato dagli stranieri mescolando ingredienti a caso, si diffuse in tutta l’India diventando una sorta di piatto nazionale consumato da un’élite.
Il curry fu portato in Regno Unito nel XVII secolo dai mercanti e dai ricchi funzionari della Compagnia in pensione che tornavano dall’India e che volevano replicare a casa quei piatti elaborati, sofisticati ed esotici. Il primo ricettario in cui si nomina il «curry alla maniera indiana» è The Art of Cookery di Hannah Glasse, del 1758: prevedeva due polletti o conigli da friggere nel burro con cipolle, riso e pepe in grani, e da stufare poi con semi di coriandolo pestati; prima di servire in tavola si aggiungeva un po’ di burro e un goccio d’acqua se la salsa era troppo densa.
Reperire le spezie giuste non era facilissimo e per questo i mercanti inventarono il curry powder, un mix già pronto che bastava aggiungere durante la cottura (solitamente uno stufato). In questo modo il Regno Unito inventò una versione standard e facilmente replicabile del curry, contrariamente a quanto accade in India dove ogni famiglia ha una sua versione (o più versioni), che prescrive non solo il tipo e la quantità di spezie ma anche l’ordine di cottura. Il curry inglese inoltre si contraddistingue per la grande quantità di curcuma, apprezzata per il colore aranciato che conferisce ai piatti. Nell’Ottocento tutti i ricettari che suggerivano un piatto indiano consigliavano di prepararlo aggiungendo un cucchiaio di polvere di curry che – elenca il popolare Modern Cookery for Private Families di Eliza Acton, del 1845 – era fatta di curcuma, semi di cumino, peperoncino e fieno greco.
Nel Settecento il curry era proposto in alcuni ristoranti di Londra come piatto esotico e raffinato, mentre la prima “curry house”, dove veniva servito o venduto d’asporto, fu la Hindoostane Coffee House, aperta nel 1810 da Sake Dean Mahomed. Divenne un piatto popolare solo dagli anni Settanta dell’Ottocento sotto il governo del conservatore Benjamin Disraeli, che perseguì una politica nazionalista di celebrazione dell’Impero: per questo costruì la replica di un paesino indiano in piena Londra e favorì spettacoli e fiere folkloristiche (o meglio, razziste). Il divertimento si concludeva con una cena economica al curry cafè allestito nella fiera, che contribuì a far conoscere quei piatti e sapori indiani anche alle famiglie più modeste. Funzionò anche perché nel frattempo il cibo inglese, influenzato dalla cucina europea, era diventato insipido, e per dare un po’ di sapore si affidava a limone, vino e poco altro. Contemporaneamente le aziende alimentari si misero a inscatolare e imbottigliare polveri e salse mentre chi non se le poteva permettere sostituiva il mango e la guava con mele verdi, rabarbaro e pomodori e il succo di tamarindo con quello di limone: il curry delle case inglesi era quanto di più lontano da un piatto indiano.
Le prime curry house furono aperte dagli immigrati indiani negli anni Venti e Trenta, ma l’abitudine di frequentarle iniziò dopo la Seconda guerra mondiale: un po’ perché le persone erano più ricche, un po’ perché era aumentata l’immigrazione dal Sud Est asiatico. La maggior parte dei futuri chef di curry britannico arrivava dal Sylhet, una piccola provincia islamica dell’attuale Bangladesh abitata soprattutto da pescatori: andavano a Calcutta in cerca di lavoro e si arruolavano come macchinisti sulle grandi navi ma era un mestiere talmente faticoso, rischioso e sottopagato che quasi sempre, una volta arrivati a destinazione, decidevano di restare. Molti trovavano impiego come lavapiatti o aiuto-cuochi nelle cucine dei ristoranti e degli hotel di Londra e quando mettevano da parte un po’ di soldi aprivano un loro fish & chips in cui servivano anche curry per i connazionali. La cucina del Sylhet non era esattamente la più rinomata del subcontinente, spiega Collingham, ma era sempre meglio del cibo inglese; in più questi locali restavano aperti fino a tardi e nacque così l’abitudine di uscire dalla partita o dal pub e prendersi un piatto di patatine con salsa al curry. Negli anni Sessanta in Regno Unito c’erano 300 ristoranti di curry, tra gli anni Settanta e Ottanta – l’epoca d’oro delle curry house – diventarono 3.000; nel 2011 erano ormai 12 mila.
Nel 2001 in un discorso diventato famoso l’allora ministro degli Esteri laburista Robin Cook definì il «Chicken Tikka Massala il vero piatto nazionale britannico, non solo perché è il più popolare ma perché illustra perfettamente il modo in cui il Regno Unito assorbe e adatta le influenze dall’esterno». Il piatto è simile a quello che in Italia chiamiamo pollo al curry, anche se esiste in decine di varianti: di base si tratta di bocconcini di pollo marinati in spezie e yogurt, serviti con una salsa speziata fatta con pomodoro e coriandolo, crema di cocco e spezie; ha spesso un colore aranciato per l’uso di paprika o curcuma e pare venne inventato in Regno Unito da un cuoco pakistano.
Il curry però non è soltanto britannico: è ormai un grande classico della cucina internazionale e allo stesso tempo presente in innumerevoli varianti regionali. È presente in quasi tutto il subcontinente asiatico; nell’Ottocento venne portato nei Caraibi dagli operai che lavoravano nell’industria dello zucchero britannica; in Sudafrica arrivò con gli immigrati indiani e con quelli britannici e da lì si diffuse in altri paesi africani; in Giappone è considerato un piatto tradizionale, una sorta di comfort food. Qui il karē, come viene chiamato, fu introdotto dal Regno Unito come piatto esotico durante il periodo Meiji (1868-1912), quando il Paese mise fine allo storico isolamento e si aprì all’Occidente. Fu favorito dalla decisione dell’Impero di revocare il divieto, per motivi religiosi, di mangiare carne: uno degli obiettivi era avere una popolazione più sana, alta e robusta e si credeva che mangiare carne, come facevano gli occidentali, avrebbe aiutato. L’esercito, su modello di quello britannico, iniziò a servire frequentemente manzo e maiale al curry, perché era facile da preparare (bastava stufare la carne nell’acqua con il preparato in polvere) e perché i giapponesi non erano abituati alle bistecche al sangue: così bastava tagliare la carne a pezzetti, stracuocerla e nasconderla in una salsa densa a base di cipolle, patate e carote. Per lo stesso motivo divenne un piatto diffuso nelle scuole e ancora oggi viene spesso consumato come un ricordo dell’infanzia, mangiato non con le bacchette ma a cucchiaiate. Ora il Giappone sta cercando di esportare il suo karē – denso, sostanzioso e marrone – in Cina.