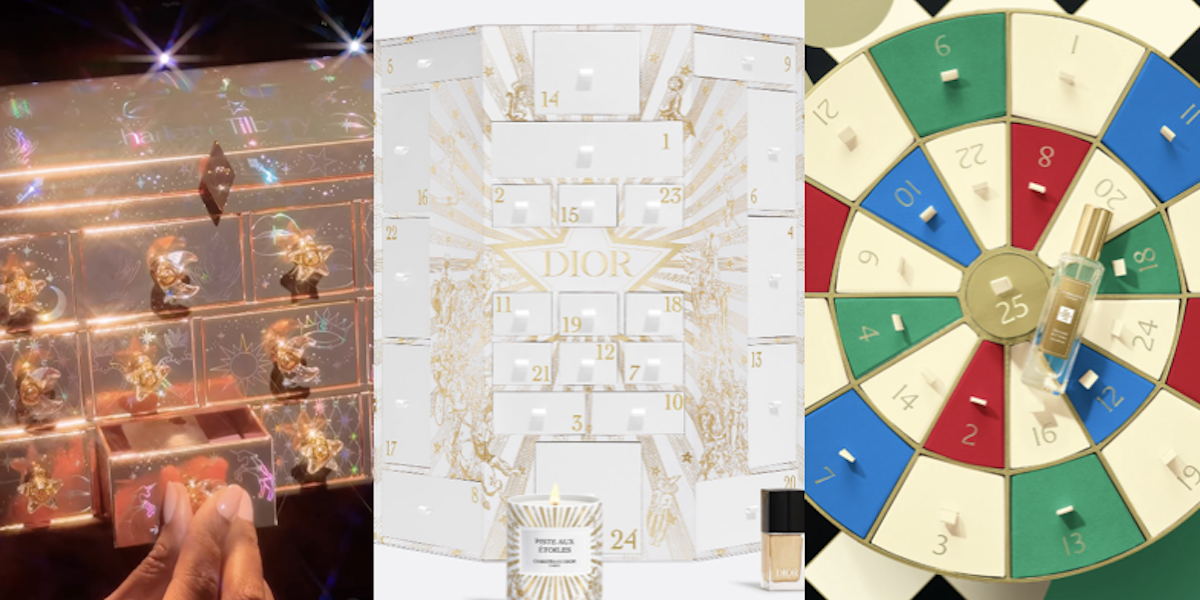Le migliori tredici canzoni dei Cure
Da riascoltare oggi che Robert Smith compie 60 anni

Oggi è il sessantesimo compleanno di Robert Smith: fondatore, cantante e chitarrista dei Cure, famoso anche per lo stile e l’aspetto riconoscibilissimo con cui si presenta da sempre sul palco (i capelli cotonati, il trucco su occhi e labbra), che viene dalle sottoculture goth. È il principale autore delle canzoni dei Cure nonché unico membro della band a non averla mai lasciata. Per festeggiarlo, qui ci sono le tredici migliori canzoni dei Cure a insindacabile giudizio del peraltro direttore del Post, che le aveva scelte per il suo libro Playlist, la musica è cambiata.
The Cure
(1976, Crawley, Inghilterra)
«Mi piacciono i Cure, ma i primi Cure…» è diventata la battuta che identifica quelle noiose macchiette umane che attribuiscono a qualsiasi cosa una deprecabile involuzione commerciale (ci giocò anche Woody Allen, con la battuta su se stesso «mi piacciono i suoi vecchi film, quelli comici»). I primi Cure in realtà somigliavano più agli ultimi Cure rispetto ai Cure di mezzo, quelli dissonanti e tenebrosi, che definirono il dark e il cosiddetto gothic rock. Associati alla faccia di Robert Smith e alla sua criniera leonina, furono l’aspetto “strano” e mi-si-nota-di-più degli anni Ottanta, la cosa migliore a cui rivolgersi per sopire l’indignazione contro la Milano da bere e i degenerati Duran Duran.
Boys don’t cry
(Boys don’t cry, 1980)
Qui, appunto, erano ancora piuttosto sgarzolini. Crisi sentimentale adolescenziale, giro di chitarra killer, e se la sente uno che non sa niente dei Cure, col cavolo che lo convincete che furono l’anima dark degli anni Ottanta.
Charlotte sometimes
(Concert. The Cure live, 1984)
Viene da un libro per bambini di Penelope Farmer, Charlotte viaggia nel tempo. Ha una grande melodia, eppure diventano finalmente prevalenti basso e tastiere da brividi. Uscì solo come singolo.
The caterpillar
(The top, 1984)
Era quella del video con le farfalle nella serra, e con i violini.
In between days
(Head on the door, 1985)
“Questa c’ha un tiro…” dice Matteo Bordone. E ce l’ha eccome: canzonetta di chitarre sfrenate, che eliminava dalla pista schiere di dilettanti, in quelle serate alternative del giovedì.
«È una canzone per gente a cui piace l’amaro assieme al dolce, gente capace di ballare, emozionarsi, pensare, e cantare allo stesso tempo» sostiene Bill Janovitz dei Buffalo Tom.
“Yesterday I got so old I felt like I could die. Yesterday I got so old it made me want to cry. Go on, go on, just walk away. Go on, go on, your choice is made. Go on, go on, and disappear. Go on, go on, away from here”.
Close to me
(Head on the door, 1985)
Di nuovo una canzonetta pop, questa volta senza le chitarre e persino con dei fiati. «Come quei giorni in cui senti di non aver combinato niente, e non vedi l’ora di chiudere la giornata e cominciarne un’altra. E ti dici che farai un sacco di cose, domani. Ma il giorno dopo è come il precedente, e a volte va avanti per settimane» disse Robert Smith.
Lullaby
(Disintegration, 1989)
Di nuovo una cosa di insetti, e di nuovo una cosa inquietante e ansiogena alla vecchia maniera. Un incubo infantile di Robert Smith, “the spiderman is having you for dinner tonight”. «Creepy song» dicono gli americani.
Pictures of you
(Disintegration, 1989)
“Ho guardato così a lungo queste tue fotografie, che quasi ho creduto fossero reali”. Lei non c’è più, e restano queste foto, e una canzone sentimentale e tempestosa. Piuttosto bella.
Love song
(Disintegration, 1989)
La quadratura del cerchio. Una canzone col più perfetto suono Cure, che pare uscita da un avanzo di “Charlotte sometimes”, con gli archi e il ritmo incessante, ballabile e il cui verso centrale è “I will always love you”, neanche fossero Whitney Houston. La canzone era per Mary, che Robert Smith stava per sposare, e che a un certo punto sussurra “fly me to the moon”, in omaggio a un classico standard romantico. (Non si è mai capito se sia “Love Song” o “Lovesong”: sui dischi è scritto in entrambi i modi).
Friday I’m in love
(Wish, 1992)
Dodici anni dopo, e sapevano ancora fare “Boys don’t cry”. E gli era anche passata la depressione (anche troppo, per molti fans e critici): il testo pare un pezzo di Barry White sulla discoteca scacciapensieri: “it’s such a gorgeous sight to see you in the middle of the night. You can never get enough, enough of this stuff”.
Why can’t I be you
(Kiss me, kiss me, kiss me, 1987)
Fu l’album – doppio – dei singoli pop da classifica, che andarono bene soprattutto negli Stati Uniti (dove era stato preceduto dal successo di una raccolta di singoli). “You make me, make me, make me, make me hungry for you!”.
Just like heaven
(Kiss me, kiss me, kiss me, 1987)
“Show me show me show me…”. Altra canzonetta, ancora più allegra, romantica e solare, non fosse per l’escamotage piuttosto facile di rivelare che si trattava solo di un sogno: non c’è nessuna ragazza con cui fuggire.
One more time
(Kiss me, kiss me, kiss me, 1987)
Nessun altro potrebbe mettere in un testo tante frasi fatte, e passare per originale e alternativo. Nessuno fuorché i Cure.
Take me in your arms
Never let me go
Take me in your arms tonight
Hold me
Just one more time
A letter to Elise
(Wish, 1992)
“Appena la raccolgo mi sfugge tra le dita, come sabbia”: vecchia immagine ungarettiana, che funziona sempre. E anche a scrivere una canzone per una ragazza che si chiamasse Elisa ci aveva pensato un altro, duecento anni prima: ma non gli era venuta così bella.