Parola di pezzettino
Carlo Verdelli, direttore di Repubblica, racconta in un libro come andò il suo tentativo di riformare il sistema dell'informazione Rai
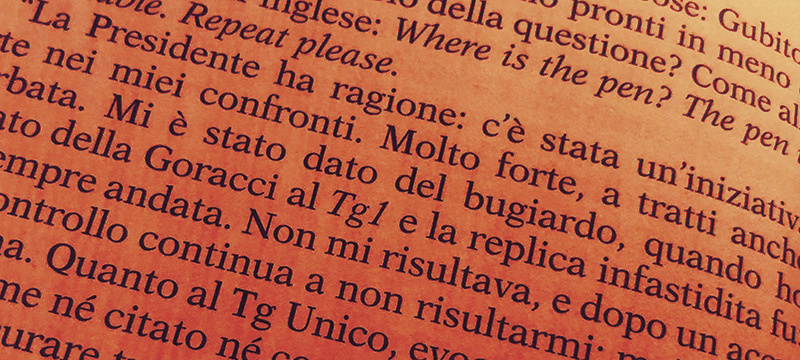
È uscito per Feltrinelli Roma non perdona, il libro in cui Carlo Verdelli racconta la sua spericolata esperienza in Rai tra il 2015 e il 2017, durante la direzione di Antonio Campo Dall’Orto: esperienza di riforma del sistema delle news che finì con una schiacciante sconfitta, inflitta dalle combinate resistenze del Consiglio di amministrazione, del sindacato dei giornalisti Rai, della Commissione di Vigilanza, e dello stesso PD al governo che l’aveva dapprima incentivata, a introdurre elementi di innovazione e cambiamento nel servizio pubblico, e in particolare a renderlo più indipendente dal potere politico. Verdelli racconta della condizione di “marziani a Roma” in cui si trovò a lavorare il gruppo Campo Dall’Orto e della propria “incoscienza, supponenza e colpevole ingenuità” nell’aver pensato di poter emendare le logiche della Rai romana: tutto il gruppo di dirigenti si dimise anzitempo nel giro di due anni, malgrado i successi acclarati sia sul piano degli ascolti che dei ricavi.
Verdelli è diventato da poco direttore di Repubblica – mentre concludeva il libro – dopo essere stato vicedirettore del Corriere della Sera, direttore di Vanity Fair e direttore della Gazzetta dello Sport. In uno dei primi capitoli del libro – che elenca critiche e aneddoti molto severi nei confronti di molti dei coinvolti nelle cose Rai – è spiegata la situazione iniziale con cui si trovò a lavorare il gruppo di Campo Dell’Orto.
*****
Il villaggio globale, immaginato cinquant’anni fa dal canadese Marshall McLuhan, è diventato una metropoli grande quanto la Terra. La storia del giovane, infelice e sconosciuto Carlos Duarte ne è una delle infinite conferme.
Carlos è argentino, ha ventun anni ed è molto disoccupato. Si ferma in un bar di Córdoba e chiede se c’è del lavoro per lui, di qualsiasi tipo. La ragazza del bancone gli risponde che sono al completo ma “lasciami il curriculum, non si sa mai”. Il problema è che Carlos non ce l’ha, il curriculum. Ma non si perde d’animo: lo scrive a matita su un foglietto e allega una sua foto che teneva nel portafoglio. Qualche ora dopo, la ragazza posta il tutto su WhatsApp e per qualche misteriosa ragione la faccenda diventa virale. Due milioni di condivisioni. Carlos travolto di offerte. Oggi lavora in una fabbrica di vetri. Ieri sarebbe ancora in giro a cercare.
Secondo un rapporto Ericsson, nel mondo ci sono più sim (schede telefoniche) che persone: 7 miliardi e 800 milioni contro 7 miliardi e mezzo. In Italia, 65 milioni di telefonini su 60 milioni di abitanti. In apertura del suo piano industriale, Antonio Campo Dall’Orto parlava di “quattro troni”: Google, Facebook, Amazon, Apple. Sono loro i padroni della nuova era digitale. Dove sta la televisione in questo universo trasformato? E dove sta la Rai? Ecco, la Rai è come uno smartphone usato soltanto per telefonare. E le altre funzioni? Domani, magari. Il problema è che il domani è adesso.
Nel 2007 arriva il digitale terrestre, aumenta l’offerta televisiva gratuita, spuntano più di 500 canali tematici. In dieci anni, i dispositivi connessi alla rete (personal computer, tablet, telefonini intelligenti, smart tv) raggiungono quota 75 milioni, quasi il doppio degli schermi tv. E là dentro, nel magma digitale, dominano offerte come Netflix o YouTube, dove puoi vedere quello che vuoi, quando e dove vuoi.
Sempre nel 2007, le sette reti principali (tre Rai, tre Mediaset più La7) raccolgono l’86 per cento del pubblico. Adesso sono sotto il 60, e nella fascia pregiata della prima serata si restringono ancora, poco più del 50 per cento, inseguite ormai a breve distanza dalla galassia dei canali gratuiti più competitivi e degli oltre 300 a pagamento, con Sky nella parte del leone.
Di fronte a questa impetuosa corrente della modernità, e della concorrenza, la Rai sta rispondendo come il gigante Polifemo, chiuso nella sua grotta, e con un occhio solo, quello con cui è nato. Per allungargli l’aspettativa di vita, ce ne vorrebbe un altro di occhio, possibilmente bionico, ovvero digitale. L’unico tentativo serio in questa direzione è stato la nascita di RaiPlay (gestione Campo Dall’Orto, realizzazione di Gian Paolo Tagliavia), una piattaforma digitale che offre di tutto e di più in modalità contemporanea, cioè con visione a piacere dell’utente. Era allo studio una versione analoga, centrata sull’informazione (Rai24), ma deve essere rimasta nel piano di riforma delle news scomparso dai radar.
Un’assenza non compensata dall’abisso del sito “RaiNews.it”: trentatreesimo posto nella classifica riservata ai media, 170mila utenti giornalieri contro i 2 milioni e 900mila del leader, “la Repubblica”, e il milione e 900mila di Tgcom24 di Mediaset. Ancora peggio la situazione sui social: il marchio Rai è sfuocato su Instagram, muto su Snapchat, defilato su Facebook, penultimo su Twitter. In Gran Bretagna, la Bbc è il primo sito di news per utenti unici, davanti a “Mail”, “Guardian” e “Telegraph”, tre quotidiani di carta.
“Quando cambiano i fatti, io cambio idea,” confidava il formidabile Winston Churchill, statista, eroe militare, storico da premio Nobel (1953), pittore notevole, allevatore di farfalle e curioso di Ufo. Il Polifemo che abita la Rai è meno elastico. Lui non cambia.
E comunque, anche con un occhio solo, pur assediato da rivali molto più piccoli ma molto più attrezzati ai nuovi bisogni del pubblico, il colosso vanta una grotta di tutto rispetto, in grado di ospitare:
- 13mila dipendenti (con un fatturato maggiore, per quasi un miliardo di euro, Mediaset ne ha cinquemila), tra i quali il fasto armonioso di 118 orchestrali;
- 1729 giornalisti, età media cinquantun anni (a RaiSport, su 120, solo 4 hanno meno di quarant’anni);
- 10 testate giornalistiche;
- 13 canali televisivi;
- 10 canali radio;
- 9 centri per le produzioni tv e 5 per quelle radiofo niche;
- 11 sedi di corrispondenza all’estero.
Tanta roba, troppa roba, accatastata senza criterio e con disprezzo dei conti (la Rai ha un debito superiore ai 400 milioni di euro). Solo di personale, il costo è di un miliardo di euro, più di un terzo dei ricavi. Il numero di edizioni dei tg oscilla tra 25 e 27: record mondiale (e senza contare RaiNews, che è un tg ventiquattr’ore su ventiquattro). Nei due canali pubblici francesi le edizioni sono 7, nei due spagnoli 6, come in Germania e alla Bbc inglese. Le tre reti di Berlusconi ne fanno 9 in tutto. Dov’è l’errore? Chi sta sbagliando, e perché?
La terza edizione della TgR, cioè il tg regionale, va in onda su RaiTre da mezzanotte e 10 a mezzanotte e 14. Quattro minuti, ascolto marginale, ma con una spesa pazza da 3 milioni di euro l’anno. Possibile? Eccome. Le sedi regionali chiudono alle 22, quindi il personale impegnato nella messa in onda (giornalisti, operatori, montatori) è in straordinario notturno. Cancellarlo? Impossibile. L’Usigrai, onnipotente sindacato dei giornalisti Rai, ha come primo comandamento “non si tagliano le edizioni”, perché farlo sarebbe un vulnus alla completezza del Servizio pubblico, ma anche, più sommessamente, perché le redazioni regionali rappresentano il bacino di consenso più cospicuo del sindacato stesso. Con un organico di 663 giornalisti, la TgR è la redazione più grande d’Europa. Letto bene: la redazione più grande d’Europa. Guai a prenderla in contropelo. Oltretutto, è il terzo tg più visto dell’arena, dopo Tg1 e Tg5, e con ascolti doppi rispetto al Tg La7 di Enrico Mentana.
Quella delle sedi regionali è un’altra delle peculiarità del gigantismo Rai. Ci sono 24 redazioni, anche se le regioni d’Italia sono 20 (duplicazioni in Sicilia, perché è lunga, e in Trentino-Alto Adige, per geopolitica), più altre 2 sedi distaccate (Udine in Friuli e Sassari in Sardegna). In Gran Bretagna e Francia sono rispettivamente 15 e 13.
Ogni sede è un presidio rilevante sul territorio, non proprio immune dalle influenze della politica che governa in loco, e con standard di efficienza rivedibili. Ci sono stabili con interi piani deserti, camion per le riprese che vanno benone per la trasmissione di grandi eventi e parate, un po’ meno per la cronaca quotidiana o le emergenze. I mezzi satellitari leggeri, detti “zainetti”, sono da poco in dotazione quasi ovunque ma capita che occorrano quattro firme diverse per poterne utilizzare uno. Inoltre, le strutture portanti (gestionali, operative, giornalistiche) sono concentrate nella sede regionale designata, con il paradosso di avere 25 redattori e tutti i mezzi tecnici a Campobasso (Molise, meno di 50mila abitanti), ma niente e nessuno a Caserta (Campania, più di 75mila). È così, anche se non pare molto logico. Ma nella grande grotta di Polifemo la legge che tutto governa è proprio questa: “È così”.
Il che spiega parecchie cose inspiegabili. Qualche esempio: il ritardo biblico del passaggio dall’analogico al digitale. L’ora X è scattata nel 2007, ma solo teoricamente. Nel settore Sport, anno 2017, il salto non era neanche cominciato, e allora avanti con le preistoriche cassette. Ancora, i tre tg principali viaggiano con un sistema comune, RaiNews24 con lo stesso ma in versione aggiornata, la TgR con un sistema differente da tutti gli altri, il che implica laboriose acrobazie per il trasferimento dei materiali. Quanto alle radio, specie quando ci sono dirette multiple come nei casi sportivi, rischiano il collasso perché poggiano su una piattaforma inadeguata. Prospettive? È così, ma ci stiamo attrezzando. Dirà Campo Dall’Orto, compiuto il suo primo tratto da capo Rai: “Stiamo cercando di recuperare dieci anni in dieci mesi”.
Niente di personale, ma ai suoi predecessori saranno fischiate le orecchie. Quei dieci anni perduti portano le firme di Mauro Masi (2009-2011), Lorenza Lei (2011-2012), Luigi Gubitosi (2012-2015), tutti direttori generali che stavano al timone mentre cambiava un’epoca ma che si sono un po’ distratti, ciascuno con le sue brave ragioni. Ma a forza di distrarsi il solco con la concorrenza internazionale è diventato un abisso.
Prendiamo i migliori, la Bbc inglese. Richard Porter, direttore delle Global News: “I nostri reporter sono in grado di fare un servizio di tre minuti per il tg, uno breve con lo smartphone per il sito, e poi continuare a trattare il tema sui vari social media”. Ancora più lancinante, se possibile, il confronto tra “noi e loro” firmato dall’economista Roberto Perotti: “Il costo medio del lavoro in Rai è del 20 per cento più alto che in Bbc, dove si producono programmi e documentari di altissima qualità, acquistati in tutto il mondo. Il personale Rai è quasi identico a quello del 2002, mentre da allora quello della Bbc è sceso del 35 per cento. La Rai ha la metà del bilancio ma una volta e mezzo il numero di dirigenti della Bbc. Ancora, in Rai un giornalista su cinque è dirigente, percentuale ineguagliata”.
Nell’elenco burocratico dell’Istat, la gonfia e rallentata Rai di Polifemo, essendo soggetto pubblico che concorre all’indebitamento dello Stato, è collocata tra una bocciofila e una Asl. In assoluto, però, sta tra le prime 60 società italiane, di poco dietro Armani, Ferrari, Grimaldi Lines, e davanti a Barilla, Fincantieri e Cofide (De Benedetti).
Vanta eccellenze indiscutibili, come il Tg1, che è di molte lunghezze il primo organo d’informazione italiano, con 4 milioni di spettatori alle 13.30 e più di 5 nell’edizione clou delle 20. Durante la direzione di Mario Orfeo, poi passato al vertice dell’azienda al posto di Campo Dall’Orto, questa testata storica ha raggiunto l’apice del 30 per cento di share, con un distacco ripetuto di 10 punti sul concorrente Tg5. Un giornale solo al comando, per numeri e prestigio, al cui confronto impallidiscono icone come il “Corriere della Sera” o “la Repubblica”. Certo, il tasto 1 del telecomando aiuta, ma il Tg1 esalta il vantaggio: con il complesso degli spazi quotidiani che gestisce, è il programma più visto dell’intero palinsesto.
“La Rai è come la nazionale, se ti convoca non puoi tirarti indietro.” Me lo ha detto una volta e per sempre Antonio Marano, uomo-azienda come pochi, leghista con Bossi (un po’ meno con Salvini), responsabile a turno di palinsesti, reti, pubblicità. Un nordico, come usa definirsi, non senza macchie (la sospensione di Michele Santoro all’epoca di Sciuscià) ma certamente senza paure, capace di convivere con Roma senza farsi stregare e con una passione inestinguibile per la sua “nazionale radiotelevisiva”.
Passione condivisa da un esercito di fedeli alla ditta, in plancia di comando come nelle stanze più periferiche, comprese quelle sindacali, gente che fa funzionare la Rai a prescindere, che la ama quanto si può amare una cosa, una casa. È questo il vero capitale su cui investire per contrastare il rischio di una fine senza fine, o piuttosto di una fine violenta come quella capitata a Polifemo, il colosso d’argilla raggirato dalla mente agile del minuscolo Ulisse.
Gli ultimi che sono entrati nella grotta romana di Polifemo per curargli la vista non ne sono usciti benissimo. Il gigante se li è mangiati e poi li ha sputati a pezzettini. Parola di pezzettino.
© Giangiacomo Feltrinelli Editore Milano
Carlo Verdelli presenterà Roma non perdona con Luca Sofri a Pensavo Peccioli, sabato 16 marzo.



