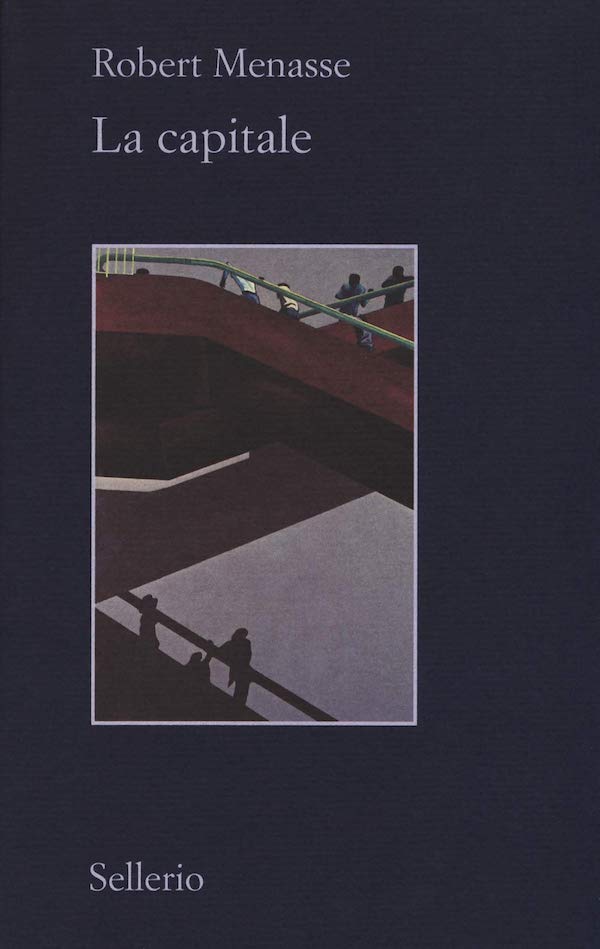L’Unione Europea descritta con un romanzo
Si chiama "La capitale", lo ha scritto l'austriaco Robert Menasse, e inizia con un maiale inarrestabile nel centro di Bruxelles

Qualche giorno fa è stato pubblicato in Italia quello che Politico ha definito «il primo grande romanzo sull’Unione Europea»: è dello scrittore austriaco Robert Menasse, si intitola La capitale (è ambientato a Bruxelles) e nel 2017 ha vinto il Deutscher Buchpreis, il più importante premio letterario per gli autori di lingua tedesca. Menasse ha cominciato a scrivere di questioni europee nel 2005 e ha passato un certo periodo alla Commissione Europea come osservatore, vivendo a Bruxelles. La capitale è un po’ un romanzo, un po’ un giallo, un po’ un libro su Bruxelles, un po’ un ritratto delle istituzioni europee che le rende più umane pur descrivendone i proverbiali grigiori e bizzarrie di funzionamento.
La capitale ha tanti protagonisti di diverse nazionalità che vivono tutti a Bruxelles ma si occupano di cose diverse; i loro percorsi si incrociano solo a momenti e casualmente. Ed è divertente, oltre ad aiutare a farsi un quadro meno astratto delle istituzioni europee. Tra le principali trame che mette insieme c’è quella di un funzionario che si occupa di istruzione e cultura che deve organizzare una celebrazione per i 50 anni della nascita della Commissione, quella di un commissario (nel senso della polizia) che indaga su un omicidio e quella di un professore di economia in pensione che in un discorso controverso propone di spostare la capitale dell’Unione Europea ad Auschwitz. E ci sono ricorrenti maiali.
Menasse presenterà La capitale al Festivaletteratura di Mantova insieme al peraltro direttore del Post Luca Sofri domenica 9 settembre, alle ore 14.45. Questo è il vivace prologo con cui inizia il romanzo.
***
Un maiale che corre! David de Vriend lo vide mentre apriva una finestra del soggiorno per far scivolare un’ultima volta lo sguardo sulla piazza prima di lasciare l’appartamento per sempre. Non era un tipo sentimentale, lui. Aveva abitato lì per sessant’anni, per sessant’anni aveva guardato quella piazza, e adesso era venuta l’ora di voltare pagina. Tutto qui. Era la sua espressione preferita – quando gli chiedevano di raccontare, riferire, riportare qualcosa, metteva insieme due o tre frasi e poi: «Tutto qui». Quell’espressione costituiva per lui la sola sintesi legittima di ogni momento e di ogni capitolo della sua vita. La ditta di traslochi aveva preso le poche carabattole da portare al nuovo indirizzo. Carabattole – parola strana che a lui, però, non faceva nessun effetto. Poi erano arrivati gli uomini dell’impresa di sgomberi per prendersi il resto, avevano staccato, smontato, rimosso tutto, anche i chiodi dai muri, finché l’appartamento non era stato, come si suol dire, «ripulito». Dato che i fornelli e la caffettiera erano ancora lì, de Vriend si era preparato un caffè ed era rimasto a guardare quegli uomini badando solo a non stargli fra i piedi, la tazza ormai vuota da un pezzo sempre in mano, finché non l’aveva lasciata cadere in un sacco della spazzatura. Poi gli uomini se n’erano andati, l’appartamento era vuoto. Ripulito. Tutto qui. Un ultimo sguardo fuori dalla finestra. Di sotto, niente che non conoscesse, e ormai era venuta l’ora di sloggiare, i tempi erano cambiati – e fu a quel punto che vide… incredibile ma vero: per strada c’era un maiale! In Sainte-Catherine, nel cuore di Bruxelles. Veniva probabilmente da Rue de la Brai e ora correva lungo la recinzione del cantiere davanti a casa, de Vriend si sporse dalla finestra e lo vide mentre all’angolo con Rue du Vieux Marché aux Grains svoltava a destra e, dopo aver schivato alcuni passanti, stava per infilarsi sotto un taxi.
Catapultato in avanti dall’inchiodata, Kai-Uwe Frigge ricadde indietro sul sedile, la faccia contratta in una smorfia. Stava facendo tardi. Era esasperato. E adesso ci mancava solo questa. In realtà non era affatto in ritardo, solo che quando aveva un appuntamento, specie se pioveva, ci teneva ad arrivare una decina di minuti prima dell’orario concordato, così aveva il tempo di andare in bagno e darsi una rapida sistemata – i capelli fradici di pioggia, gli occhiali appannati – prima che l’altra persona arrivasse.
Un maiale! L’ha visto, monsieur?, gridò il tassista. Tra un po’ lo mettevo sotto! Si chinò sul volante: Eccolo! Eccolo là! Lo vede?
Sì, adesso lo vedeva. Kai-Uwe Frigge spannò il vetro del finestrino con il dorso della mano, il maiale fece una brusca virata, nella luce dei lampioni il corpo bagnato dell’animale risplendeva di un rosa sporco.
Siamo arrivati, monsieur! Più di così non posso avvicinarmi. Ma roba da matti! Un maiale che per un pelo non si fa mettere sotto! Miseria porca, di nome e di fatto!
Fenia Xenopoulou era seduta al primo tavolo del ristorante Menelas, accanto alla grande vetrata con vista sulla piazza. Era seccata perché era troppo in anticipo. E farsi trovare già seduta ad aspettare non era un gran segno di autorevole superiorità. Era nervosa. Temendo di trovare traffico per via della pioggia, aveva esagerato a calcolare il tempo che avrebbe impiegato per arrivare. E adesso eccola lì, davanti al secondo ouzo. Il cameriere le ronzava intorno più fastidioso di una mosca. Fenia teneva gli occhi fissi sul bicchiere, imponendosi di non toccarlo. Il cameriere le portò una caraffa di acqua fresca. Poi un piattino di olive – e disse: Un maiale!
Come, scusi? Fenia alzò gli occhi, notò che l’altro guardava la piazza come ipnotizzato, e fu a quel punto che lo vide anche lei: il maiale stava galoppando verso il ristorante, un galoppo ridicolo, con quelle zampette corte che si dimenavano avanti e indietro sotto il corpo tondo e pesante. All’inizio lo scambiò per un cane, una di quelle bestiacce ripugnanti messe all’ingrasso dalla solita vedova, e invece no, era proprio un maiale! Il grugno e le orecchie avevano le stesse linee, gli stessi contorni di un disegno per bambini, neanche fosse spuntato fuori da un libro illustrato, anzi no, piuttosto da un horror per ragazzi. Non era un cinghiale, era un maiale domestico sporco e pur sempre rosa, non c’è che dire, un maiale con un che di folle, di pericoloso. Le gocce di pioggia colavano sulla vetrata, Fenia Xenopoulou vide l’immagine confusa del maiale che, allungando le zampette irrigidite, frenava di colpo davanti a un drappello di passanti, poi scivolava, scartava, virava, riguadagnava terreno e galoppava in direzione opposta, verso l’Hotel Atlas. Proprio in quel momento Ryszard Oswiecki lasciava l’albergo.
Appena fuori dall’ascensore, mentre attraversava la hall, si era tirato su il cappuccio del giubbotto, e adesso si avviava sotto la pioggia camminando in fretta ma non troppo, doveva evitare di dare nell’occhio. Quella pioggia era una fortuna: cappuccio, passo svelto, date le circostanze tutte cose assolutamente normali che nessuno avrebbe notato. Nessuno sarebbe stato in grado di affermare, poi, di aver visto un uomo fuggire, un uomo all’incirca di questa età, a occhio e croce di quest’altezza, e il colore del giubbotto – certo, quello sì che l’avrebbero saputo indicare… Con uno scatto svoltò a destra, poi sentì delle voci allarmate, un grido e un gemito bizzarro, stridulo. Si fermò un attimo, si girò. E si accorse del maiale. Non credeva ai suoi occhi. Fra due paletti in ferro battuto che delimitavano lo spiazzo davanti all’albergo, c’era un maiale, la testa bassa come un toro pronto alla carica, e un’aria ridicola e minacciosa insieme. Un bel mistero: da dove spuntava fuori quel maiale, e perché era lì? Ryszard Oswiecki ebbe l’impressione che tutta la vita in quella piazza, o almeno fin dove arrivava il suo sguardo, fosse impietrita, raggelata, i piccoli occhi dell’animale riflettevano in un bagliore la luce al neon dell’insegna sulla facciata dell’albergo – e fu allora che Ryszard Oswiecki si mise a correre! Curvò a destra, si guardò ancora una volta alle spalle, il maiale alzò la testa ansimando, fece qualche passetto indietro, si girò e attraversò di corsa la piazza verso gli alberi allineati davanti al De Markten, il centro culturale fiammingo. I passanti che avevano osservato la scena seguivano con lo sguardo il maiale invece dell’uomo incappucciato – e fu a quel punto che Martin Susman vide l’animale.
Abitava nella casa di fianco all’Hotel Atlas, proprio in quel momento stava aprendo la finestra per cambiare l’aria e trasecolò: un maiale! Aveva appena concluso una riflessione sulla sua vita, sulle circostanze fortuite che avevano spinto uno come lui, figlio di contadini austriaci, a vivere e lavorare a Bruxelles, nello stato d’animo in cui si trovava gli sembrava tutto assurdo ed estraneo, ma un maiale che correva all’impazzata per la piazza superava ogni limite, era di certo uno scherzo della sua fantasia, una proiezione dei suoi ricordi! Lo cercò con lo sguardo, ma il maiale era sparito.
Raggiunta la chiesa di Sainte-Catherine, il maiale attraversò Rue Sainte-Catherine e, tenendo la sinistra, scansò i turisti che uscivano dalla chiesa, proseguì in direzione di Quai aux Briques mentre i turisti ridevano, pensavano che quell’animale sfinito, quasi sul punto di collassare, fosse una nota di folclore, una specie di fenomeno locale. Qualcuno, poi, andò a cercare una spiegazione sulla guida turistica. Nella spagnola Pamplona, per esempio, in occasione di certe festività, i tori venivano sguinzagliati per le strade. Magari a Bruxelles facevano la stessa cosa con i maiali. Vivere l’inconcepibile dove non ci si aspetta di capire tutto – questa sì che è vita.
Intanto Gouda Mustafa aveva appena girato l’angolo e per poco non andò a sbattere contro il maiale. Per poco? E quindi l’aveva toccato sì o no? Gli aveva o no sfiorato la gamba? Un maiale! Preso dal panico, con un salto Gouda Mustafa si fece da parte, perse l’equilibrio e cadde. Finì in mezzo a una pozzanghera, ci si rotolò dentro, cosa che peggiorò la situazione, anche se a farlo sentire sporco non era tanto il fango della strada, ma il contatto, sempre che ce ne fosse stato uno, con l’animale impuro.
Fu allora che vide una mano allungarsi verso di lui, e la faccia di un anziano signore, una faccia triste, preoccupata, rigata di pioggia, come se il vecchio piangesse. Era il professor Alois Erhart. Gouda Mustafa non capiva cosa gli stesse dicendo, capiva solo la parola «okay».
Okay! Okay!, rispose.
Il professor Erhart continuava a parlare, parlava in inglese, diceva che anche lui quel giorno era caduto, ma era così confuso che disse failed invece di fell. Gouda Mustafa non lo capiva, ripeté un’altra volta: okay!
Poi arrivarono le sirene. La salvezza. La polizia. Tutta la piazza girava come una trottola, guizzava, palpitava nella luce azzurra. Le volanti corsero ululando verso l’Hotel Atlas. Il cielo sopra Bruxelles stava facendo il suo dovere: pioveva. Adesso sembrava piovessero gocce di luce blu. E poi una raffica di vento che strappò e rigirò l’ombrello di qualche passante. Gouda Mustafa afferrò la mano del professor Erhart e si lasciò aiutare a tirarsi su. Il padre l’aveva messo in guardia: mai fidarsi dell’Europa.
2017 © Suhrkamp Verlag Berlin
2018 © Sellerio editore