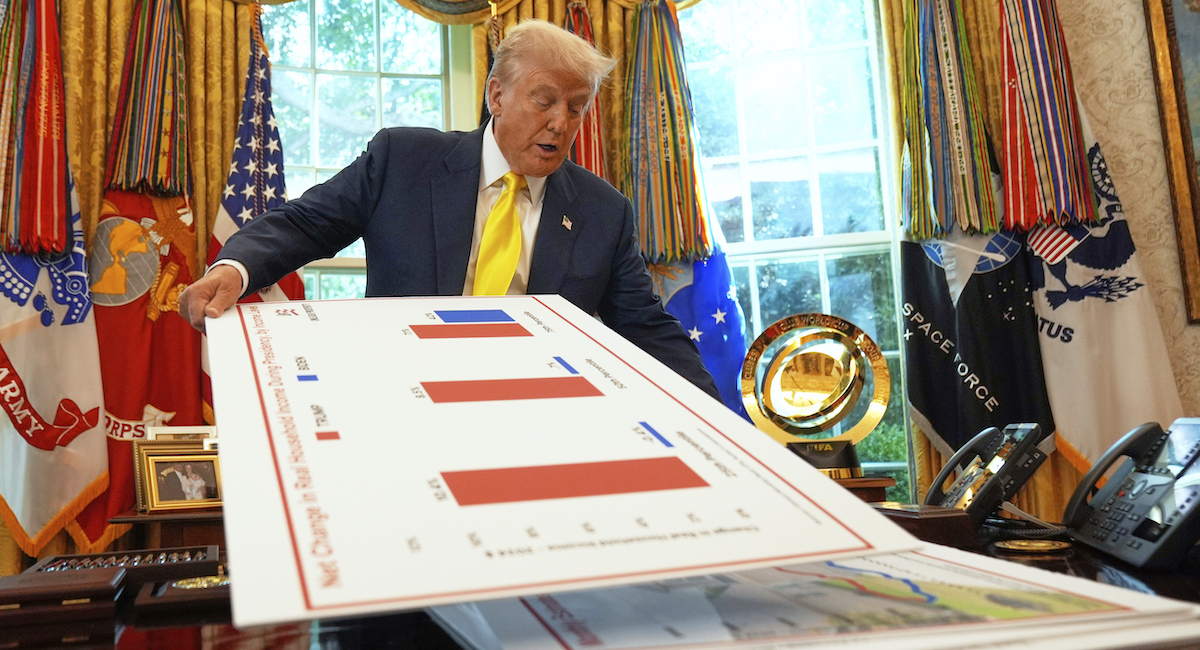Che cosa c’è nel “decreto dignità”
È stato approvato ieri dal governo: i contratti precari sono stati resi più complicati e costosi, ma non c'è niente per rendere più convenienti quelli a tempo indeterminato

Lunedì sera il governo ha approvato il cosiddetto “decreto dignità”, un decreto legge che contiene una serie di interventi in particolare sul lavoro. «È la Waterloo del precariato», ha detto ai giornalisti il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, riferendosi alla parte del decreto che rende più complicati e costosi i contratti a tempo determinato, quelli che spesso sono definiti “precari”. Secondo gli esperti il decreto contiene parti buone e parti meno buone, ma non è comunque riuscito a sollevare particolari entusiasmi, nemmeno da parte dei sindacati che rappresentano i lavoratori.
I commentatori dei principali quotidiani ne criticano soprattutto la rapidità di approvazione e il fatto che sia avvenuta senza una vera e propria consultazione con sindacati e associazioni di imprese. Un decreto legge come quello approvato ieri dal governo è uno strumento legislativo che serve a intervenire su un tema per ragioni di urgenza: entra immediatamente in vigore, ma deve essere confermato dal Parlamento, ed eventualmente modificato, entro 60 giorni.
Ci sono molti dubbi sul fatto che il decreto riuscirà nel suo obiettivo dichiarato: aumentare il numero di lavoratori a tempo indeterminato a scapito dei precari. Le novità principali del decreto (qui trovate il testo completo) riguardano i contratti a tempo determinato. Il decreto ne diminuisce la durata massima da 36 a 24 mesi e rimette l’obbligo di fornire la causale se il contratto a tempo supera i 12 mesi. Significa che per i contratti più lunghi il datore di lavoro dovrà giustificare l’assunzione di un lavoratore a tempo determinato, specificando per esempio se c’è stato un aumento imprevisto e temporaneo della produzione oppure se ha la necessità di sostituire altri dipendenti assenti.
Mentre la riduzione della durata massima del contratto a tempo determinato è apprezzata o per lo meno compresa da tutte le parti, la reintroduzione delle causali è molto controversa. Le causali, infatti, sono problematiche perché, soprattutto per le imprese più grandi, è praticamente impossibile dimostrare in maniera incontrovertibile la reale presenza di una ragione oggettiva che giustifichi la necessità di assumere un lavoratore a tempo determinato. In passato, prima che le causali venissero abolite dal Jobs Act, era molto comune per i lavoratori minacciare una causa contro i propri datori di lavoro, sapendo che se il giudice non avesse ritenuto legittima la causale, l’azienda sarebbe stata costretta ad assumerli a tempo indeterminato (di solito questi casi venivano risolti con un accordo extragiudiziale e il pagamento di una somma al lavoratore per rinunciare alla causa). Dopo l’introduzione del Jobs Act il numero di cause da lavoro in Italia si era praticamente dimezzato e ora diversi esperti temono che possa tornare a crescere.
Il decreto alza anche il costo del licenziamento, aumentando del 50 per cento l’indennizzo minimo e quello massimo per chi viene licenziato senza giusta causa (visto che l’indennizzo è proporzionale al tempo trascorso al lavoro, questa disposizione favorisce in particolare i più anziani). Secondo diversi esperti, questo è uno dei punti più delicati del decreto. La combinazione delle due norme, che rendono più costosi i licenziamenti e più convenienti i contratti di breve durata (quelli di 12 mesi che non richiedono di specificare una causale), rischia di spingere i datori di lavoro ad accelerare l’avvicendamento dei lavoratori, nella speranza che la breve durata dei contratti permetta di evitare il ricorso al licenziamento divenuto più costoso e la possibilità di essere portati in tribunale per via delle causali.
Un altro problema del decreto è che mentre i contratti a tempo determinato vengono resi più costosi, non viene introdotto alcun tipo di incentivo alla loro trasformazione in contratti a tempo indeterminato. Per farlo il governo avrebbe dovuto stanziare delle risorse, per esempio per ridurre il carico fiscale su questo tipo di contratti, ma a quanto risulta il provvedimento è stato disegnato a costo zero o quasi, a causa della mancanza di denaro da investire.
Infine il decreto aumenta i vincoli che devono essere rispettati dalle agenzie interinali, quelle che offrono il cosiddetto “lavoro a somministrazione” (in cui un’impresa si rivolge all’agenzia affinché le venga fornito un lavoratore in genere per periodi di tempo molto brevi che però resta formalmente dipendente dell’agenzia). Su quest’ultimo punto si sono concentrate molte critiche, poiché sembra che il governo abbia intenzione di applicare a questo tipo di agenzie tutte le regole dei contratti a tempo determinato, il che rischia di paralizzarne o comprometterne l’operato. Il testo comunque è scritto in una maniera che diversi esperti consultati da Post hanno definito “poco chiara”.
Il decreto è particolarmente osteggiato dalle associazioni di imprenditori, che chiedono un costo del lavoro più basso e maggior flessibilità, cioè la possibilità di assumere o licenziare personale con più facilità. In un’intervista al Corriere della Sera il presidente di Confindustria Vicenza, Luciano Vescovi, ha detto: «Ci troviamo di fronte a un approccio dirigista che ricorda gli anni Ottanta e Novanta. Il lavoro non si crea per decreto».
Un’altra disposizione che non piace molto alle imprese è una norma che dovrebbe servire a scoraggiare le delocalizzazioni all’estero. La norma prevede che se un’impresa si trasferisce fuori dall’Italia entro cinque anni dal momento in cui ha ricevuto un qualunque tipo sostegno pubblico dovrà restituire l’importo ricevuto maggiorato dagli interessi. Con ogni probabilità questa disposizione si potrà applicare soltanto alle imprese che provano a trasferirsi fuori dall’Unione Europea (le delocalizzazioni all’interno dell’Unione sono protette dal diritto europeo, in base alle norme sul mercato unico).
Anche se non c’è stato un confronto ufficiale e pubblico con le parti sociali, le bozze del decreto erano circolate comunque tra gli addetti ai lavori che avevano notato numerosi gravi errori o mancanze nel testo del decreto, la maggior parte delle quali sono state corrette nella versione approvata dal Consiglio dei ministri (diverse fonti hanno riferito al Post che è insolito che un governo faccia circolare la versione completa di un decreto sul lavoro, e non soltanto i temi principali dei quali si occupa). Il decreto appare comunque scritto relativamente in fretta e di getto, oltre ad avere al suo interno una serie di disposizioni aggiuntive che non c’entrano nulla con il lavoro (una vecchia abitudine del modo di scrivere i decreti in Italia).
Il più importante è probabilmente il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo, fatti salvi i contratti pubblicitari già in essere e le pubblicità della Lotteria Italia. Di Maio ha spiegato questa decisione con la necessità di ridurre la ludopatia, la dipendenza da gioco d’azzardo (l’Italia è uno dei paesi che spendono di più al mondo per il gioco: a ridurla ci aveva già provato il governo Renzi, ma senza successo). A protestare contro questa decisione ci sono, oltre ai concessionari dei giochi, anche editori e società di calcio che beneficiavano delle sponsorizzazioni del settore.
Infine il decreto introduce una serie di semplificazioni per le imprese che sono state spinte in particolare dalla Lega, e che da molti sono considerate il “prezzo” che il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha chiesto in cambio del suo via libera. Anche qui però non è stato fatto nulla di rivoluzionario: il decreto rimanda a febbraio 2019 la scadenza per la presentazione dello “spesometro” (in sostanza, l’obbligo da parte di imprese e lavoratori autonomi di comunicare ogni tre mesi le fatture emesse sopra un certo importo, per ridurre l’evasione fiscale). Viene anche abolito lo “split-payment”, ma solo per i professionisti: è una norma per combattere l’evasione fiscale che prevede che le pubbliche amministrazioni che acquistano servizi versino l’IVA direttamente allo Stato e non al fornitore, che poi dovrebbe procedere in un secondo momento a pagarla allo Stato, come avviene normalmente.