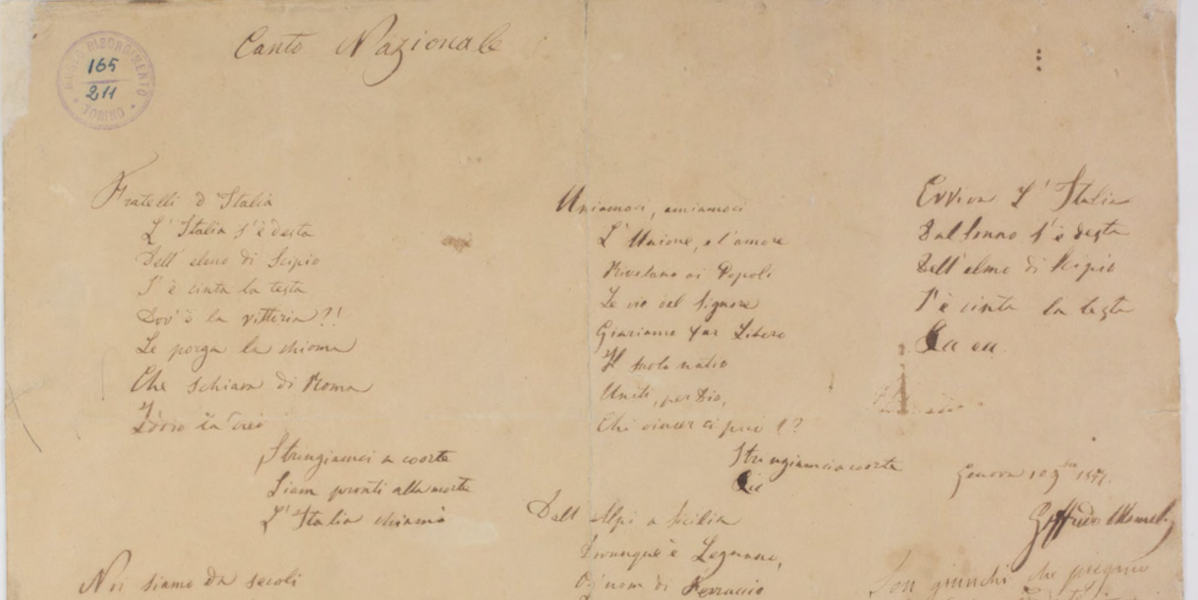La cosiddetta “trattativa Stato-mafia”, spiegata
Cosa sappiamo e cosa no della teoria – giudiziaria, giornalistica, politica – che prova a interpretare e ricostruire la storia italiana degli ultimi vent'anni
di Davide Maria De Luca – @DM_Deluca

Venerdì 20 aprile, dopo cinque giorni di camera di consiglio, i giudici del tribunale di Palermo hanno emesso la sentenza di primo grado per il processo sulla presunta cosiddetta “trattativa Stato-mafia”. La tesi dell’accusa, portata avanti soprattutto dal pubblico ministero Nino Di Matteo, è stata sostanzialmente accettata dalla giuria, in parte composta da giudici togati e in parte da giudici popolari: un politico, alti funzionari dello stato e boss mafiosi sono stati condannati. Secondo i giudici, tre importanti ufficiali dei carabinieri e Marcello Dell’Utri, per anni noto amico e collaboratore di Silvio Berlusconi, hanno “minacciato” gli organi dello Stato per conto della mafia, con l’obiettivo di costringere i governi ad adottare un atteggiamento più morbido nei confronti della criminalità organizzata siciliana.
La teoria – giudiziaria, giornalistica, politica – alla base della “trattativa Stato-mafia” è però molto più ampia del processo di primo grado che si è concluso venerdì. Riguarda non solo molti altri processi, che sono finiti con delle assoluzioni, ma costituisce un vero e proprio tentativo di ricostruzione storica degli ultimi 25 anni di storia del nostro paese. Tra i pochi che si sono approcciati al caso con una prospettiva “storica” e non soltanto giudiziaria ci sono il giurista Giovanni Fiandaca e lo storico Salvatore Lupo, che del caso hanno parlato nel libro La mafia non ha vinto.
Il processo
Visto che il processo di Palermo riguarda solo una parte dell’intera vicenda, per comprendere la “trattativa” è bene separare la storia dagli esiti processuali. Cominciamo da questi ultimi e in particolare da quello al termine del quale, venerdì scorso, sono state emesse numerose condanne. Le più interessanti sono quelle che hanno riguardato l’ex generale Mario Mori, l’ex generale Antonio Subranni e l’ex colonnello Giuseppe De Donno, tutti e tre appartenenti ai ROS, i carabinieri incaricati di indagini speciali come quelle per reati di mafia. Secondo i giudici, questi tre alti ufficiali avrebbero condotto la trattativa con la mafia in Sicilia, e, riportando le richieste dei boss mafiosi ai politici, avrebbero così commesso un reato.
Il problema è che non esiste il reato di “trattativa”: e fino a che non vengono commessi reati, le autorità hanno tutto il diritto di trattare anche con criminali incalliti. Si tratta con i criminali che hanno preso degli ostaggi, per esempio, allo scopo di salvarli, ma anche in casi molto più eclatanti: lo Stato italiano ha notoriamente trattato tra gli anni Sessanta e Settanta con i terroristi palestinesi, a cui veniva permesso il trasporto di armi e personale sul territorio italiano purché il nostro paese non fosse teatro di attacchi terroristici. Si trattò spesso e in molte occasioni anche con i terroristi italiani, tra cui persino il più pericoloso e organizzato tra tutti i gruppi, quello delle Brigate Rosse (nel caso del sequestro del giudice Mario Sossi furono proprio i magistrati a condurre la trattativa, e altri magistrati a bloccarla all’ultimo minuto). Durante il rapimento di Aldo Moro ci furono trattative tra il leader socialista Bettino Craxi e i brigatisti, e persino tra il Vaticano e alcuni supposti emissari delle Brigate Rosse.
Oggi è cambiata la sensibilità dell’opinione pubblica e anche quella di alcune parti della magistratura, e secondo l’accusa trattare con i criminali costituisce di per sé sempre un reato, poiché comporta che un organo pubblico subisca delle minacce (se la trattativa non va in porto, accadranno cose spiacevoli). Chi tratta, secondo questa lettura, commette il reato di “minaccia e violenza contro organi politici dello Stato”. In altre parole, secondo i giudici del processo terminato venerdì scorso, Mori, Subranni e De Donno avrebbero parlato con i boss della criminalità organizzata, ascoltato cosa chiedevano per far terminare la cosiddetta “stagione delle stragi” e quindi riferito alle autorità politiche i risultati dei colloqui. Così facendo avrebbero “minacciato” il governo, prospettando una continuazione delle stragi se non si fosse ammorbidita la lotta alla mafia.
I giudici non hanno considerato i tre ufficiali dei semplici “tramite”, che avrebbero svolto una trattativa con la criminalità su ordine delle autorità politiche, ma li hanno accusati di essere – sostanzialmente – complici della criminalità organizzata. In questo contesto, l’espressione “trattativa Stato-mafia” rischia di diventare fuorviante, poiché anche negli argomenti dell’accusa lo Stato risulta essere la parte lesa e minacciata. È stato condannato anche il boss mafioso Leoluca Bagarella, che avrebbe formulato almeno parte delle richieste della criminalità organizzata, così come Marcello Dell’Utri, che secondo l’accusa sarebbe stato ambasciatore di una seconda trattativa che si sarebbe svolta durante il primo governo Berlusconi. In questo scenario anche Berlusconi, in quanto capo del governo, è considerato dai giudici la vittima delle minacce agli organi dello Stato portate avanti da Dell’Utri: non suo complice, come ha correttamente notato il giornalista Luciano Capone. È stato invece assolto il ministro dell’Interno della “prima fase” della trattativa, Nicola Mancino, accusato di falsa testimonianza in un filone laterale di questa complicata vicenda.
Conosceremo probabilmente tra diverse settimane maggiori dettagli su quali sono le responsabilità dei vari protagonisti secondo i giudici, quando saranno pubblicate le motivazioni della sentenza. Sentenza che peraltro è stata molto criticata, per la fragilità degli elementi su cui si basa e per come ignora le sentenze di diversi precedenti processi: sono parecchi a ritenere che sarà rovesciata in appello.
La storia
Analizzare la vicenda prendendo in esame uno solo dei numerosi rami processuali di cui è composta rischia di produrre un racconto parziale. La teoria della “trattativa” è molto più complessa e sfaccettata ed è stata esaminata in numerosi processi, articoli e libri di inchiesta. Accanto al processo di Palermo esistono ricostruzioni più ampie, portate avanti da giornalisti, da politici e dagli stessi magistrati dell’accusa nei loro libri, nelle loro interviste e negli altri processi di cui si sono occupati. Di Matteo, il principale pm dell’accusa, è stato uno dei più importanti propugnatori della teoria più estesa e in questo è stato spesso appoggiato da giornali, come il Fatto Quotidiano, e da partiti politici, come il Movimento 5 Stelle, alle cui iniziative ha partecipato in più di un’occasione.
La “teoria della trattativa”, nel senso più ampio del termine, è più o meno quella che segue.
Di fronte ai successi nella lotta alla mafia della fine degli anni Ottanta e dei primi anni Novanta – si pensi per esempio al “maxiprocesso” – l’ala più violenta di Cosa Nostra, guidata da Totò Riina, avrebbe deciso di intraprendere una strategia stragista per costringere lo Stato a trattare e moderare così il suo atteggiamento, tornando al precedente stato di “pacifica convivenza”. Le stragi portarono alla morte dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i giudici più attivi nella lotta alla mafia, ma anche ad attacchi contro obiettivi civili e monumenti a Milano, Firenze e Roma.
In questo periodo – sul momento esatto esistono versioni discordanti – alcuni funzionari dello Stato avrebbero iniziato ad avvicinarsi alla mafia siciliana per trattare, esattamente come aveva previsto Riina. Il principale protagonista di questa trattativa sarebbe stato il generale Mori, ma esistono ricostruzioni che attribuiscono importanti ruoli a personaggi misteriosi e probabilmente mai esistiti. Il più celebre è il misterioso “signor Franco”, un agente dei servizi segreti di cui ha parlato Massimo Ciancimino, figlio del sindaco di Palermo legato alla mafia Vito Ciancimino e diventato uno dei principali testimoni della “trattativa” (è stato però ampiamente squalificato, accusato di aver mentito, calunniato e falsificato documenti: e condannato per calunnia nello stesso processo di Palermo che, anche sulla base delle sue testimonianze, ha portato alle condanne per la presunta “trattativa”). Nessun altro, a parte Massimo Ciancimino, ha mai parlato del “signor Franco”, di cui non si conosce il nome né esiste alcuna traccia documentale.
I contatti tra Vito Ciancimino e i capi del ROS sono stati ammessi dallo stesso Mori e dai suoi colleghi, che però sostengono che non fu altro che un trucco investigativo, un modo per scoprire se fosse possibile agganciare qualche boss, spingerlo ad arrendersi, a collaborare oppure farlo cadere in trappola. Quali che fossero queste ragioni, secondo il figlio di Vito Ciancimino nel corso di queste trattative sarebbe emerso un vero e proprio elenco di richieste da parte della mafia siciliana, il famoso “papello”. Il “papello” sarebbe stato poi portato a non meglio precisate autorità governative che avrebbero dovuto scegliere tra l’accettarne le richieste oppure subire nuove stragi (e per questo, quindi, chi lo presentò divenne responsabile di “minaccia” nei confronti di organi dello Stato). Del “papello” non esistono tracce che non provengano dallo screditato Ciancimino o da ambienti mafiosi.
Nessuna delle richieste presenti nell’eventuale “papello” però venne accettata. La teoria della “trattativa” quindi individua tutta un’altra serie di azioni, diverse da quelle che la mafia avrebbe suggerito, che il governo avrebbe intrapreso per soddisfare i criminali. La principale sarebbe stata la decisione dell’allora ministro della Giustizia Giovanni Conso di non rinnovare il regime di carcere duro 41bis a centinaia di condannati per mafia. A questo proposito, però, va sottolineato che Conso non era un politicante compromesso con ambienti oscuri, ma un giurista importante, ex presidente del CSM e della Corte Costituzionale, ministro tecnico nel governo di Carlo Azeglio Ciampi. L’attenuazione del 41bis – regime carcerario peraltro criticato come inumano, oggi come allora – fu concessa soltanto a mafiosi di secondo piano e, spiegò Conso, come atto umanitario di distensione del clima di quegli anni. Fu inoltre un legittimo atto politico condiviso dai partiti dell’epoca, che può essere apprezzato o no ma che non costituisce un reato. Conso – che è stato indagato per false dichiarazioni ma di cui fu respinta persino la richiesta di rinvio a giudizio – ha rifiutato nettamente l’idea che quel gesto possa essergli stato suggerito dalla mafia o che gli sia stato prospettato come parte di uno “scambio” con la criminalità organizzata.
Bisogna aggiungere, appunto, che il 41bis non è una misura che ha sempre goduto di unanime approvazione. È una misura di carcere estremamente duro, criticata sulla base di considerazioni umanitarie anche da organizzazioni internazionali, e che altri paesi hanno equiparato alla tortura. Alcuni magistrati che hanno studiato questa misura, come Sebastiano Ardita, sostengono che il 41bis all’iniziò fu controproducente perché contribuì ad alimentare lo stragismo invece che fermarlo, poiché i mafiosi provarono «ad aprirsi con le bombe la strada che portava fuori dal 41bis».
Un discorso simile si potrebbe fare per altri dei presunti vantaggi ottenuti dalla mafia grazie alla presunta trattativa, come la chiusura delle “supercarceri” di Pianosa e l’Asinara. In realtà queste due strutture erano già state chiuse durante la stagione del terrorismo (e, curiosamente, nel caso dell’Asinara, in risposta alle richieste delle BR che avevano rapito un magistrato, Giovanni D’Urso). La chiusura delle carceri non aveva suscitato particolari polemiche perché l’Asinara, come Pianosa, era un carcere fatiscente dove i detenuti erano sottoposti a condizioni ritenute disumane da numerose organizzazioni umanitarie nazionali e internazionali. L’Asinara e Pianosa furono riaperte dopo la strage di Capaci e vi furono trasferiti in massa i detenuti mafiosi, nel giro di una sola notte, come misura di immediata e brutale rappresaglia alla strage da parte dello Stato.
Le altre conseguenze della presunta trattativa vengono indicate di volta in volta nella cattura di Totò Riina, che sarebbe arrivata grazie a una soffiata dell’area “moderata” di Cosa Nostra, guidata da Bernardo Provenzano; nella mancata perquisizione del covo di Riina, che sarebbe stata ritardata per permettere all’area “moderata” di ripulirlo; e infine nella mancata cattura di Provenzano nel 1995, frutto dell’accordo segreto che il boss avrebbe raggiunto come parte della trattativa. Mori e altri carabinieri sono stati processati per questi due fatti e in entrambi i casi sono stati assolti.
Questo per quanta riguarda il troncone principale della trattativa. Accanto a questo esistono però numerosi altri filoni che, nelle loro versioni più estreme, ascrivono alla presunta trattativa praticamente tutto ciò che è accaduto nel nostro paese negli ultimi 25 anni. Tra le teorie che hanno trovato almeno una parte di conferma giudiziaria c’è per esempio quella secondo cui la “stagione della trattativa” sarebbe continuata anche durante il primo governo Berlusconi, che avrebbe ricevuto pressioni e minacce da parte di Marcello Dell’Utri (è per questa ragione che venerdì scorso Dell’Utri è stato condannato).
Secondo i magistrati che hanno portato avanti l’accusa – oltre a Di Matteo il più celebre è Antonio Ingroia, che partecipò alle indagini e alla prima fase del processo prima di candidarsi in politica e abbandonare la magistratura – Forza Italia sarebbe un “partito della mafia”, nato sotto le pressioni dell’ala “moderata” di Cosa Nostra, guidata da Provenzano, dopo che era stato abbandonato il progetto di fondare una “Lega del Sud” speculare a quella del Nord che proprio in quegli anni stava iniziando a raccogliere grossi successi elettorali. Questa parte della vicenda, però, è fatta in gran parte di testimonianze di seconda o terza mano rese da persone che raramente affermano di aver assistito in prima persona agli eventi che raccontano.
Questa parte della teoria della trattativa, che vede Forza Italia come “figlia” dell’accordo tra governo e mafia, rimane da confermare non solo dal punto di vista storico ma anche da quello giudiziario: e per stare in piedi ha bisogno di ascrivere alla criminalità organizzata un controllo capillare dei voti in Sicilia. Il principale problema di questa teoria è che sembra difficile dimostrare questo controllo. Nel 1987, quando si verificò la rottura dei rapporti tra i vertici di Cosa Nostra e la Democrazia Cristiana regionale, la mafia decise di spostare i “suoi” voti dalla DC ai socialisti e ai radicali. Era un modo per punire la DC per non aver protetto i boss dal maxi-processo, che si era svolto alla fine degli anni Ottanta ed era stato devastante per l’organizzazione criminale. Ma la rottura produsse scarsi risultati elettorali. Nel 1987 la DC prese gli stessi voti che aveva raccolto alle elezioni del 1983, mentre socialisti e radicali videro i loro consensi crescere di poche decina di migliaia di voti. Per tutto il resto del decennio e fino al suo scioglimento, la DC continuò a dominare la politica siciliana, raccogliendo persino più voti di quelli che otteneva all’inizio degli anni Ottanta.
Per quanto rimangano responsabilità da accertare in fase processuale, secondo storici come Salvatore Lupo è abbastanza chiaro qual è il problema della “teoria della trattativa” nella sua accezione più ampia: questa riscrittura finisce con l’ascrivere una pluralità di fenomeni complessi, di scelte politiche di portata storica e con conseguenze decennali, a un’unica causa: l’inconfessabile trattativa tra uno Stato impotente e una criminalità organizzata capace di ottenere qualsiasi risultato. Il limite della “teoria della trattativa”, nel senso più esteso, è – secondo i critici – cercare di semplificare qualcosa che è per sua natura molto complesso. Così come le teorie del complotto sugli “anni di piombo” cercano di spiegare quel convulso periodo della storia repubblicana con le macchinazioni della CIA o di un misterioso Grande Vecchio nascosto nella sua stanza dei bottoni, così la teoria della “trattativa” nella sua versione grandiosa pretende di spiegare l’intera storia del passaggio tra Prima e Seconda Repubblica con gli eventuali accordi segreti fatti da alcuni carabinieri con i boss della mafia siciliana.