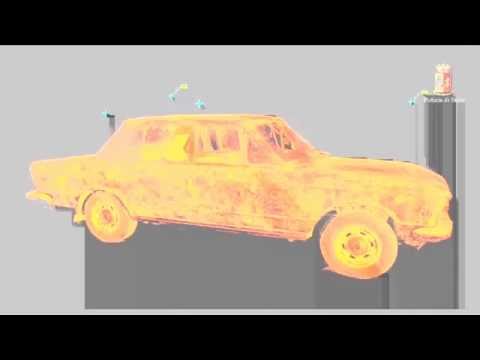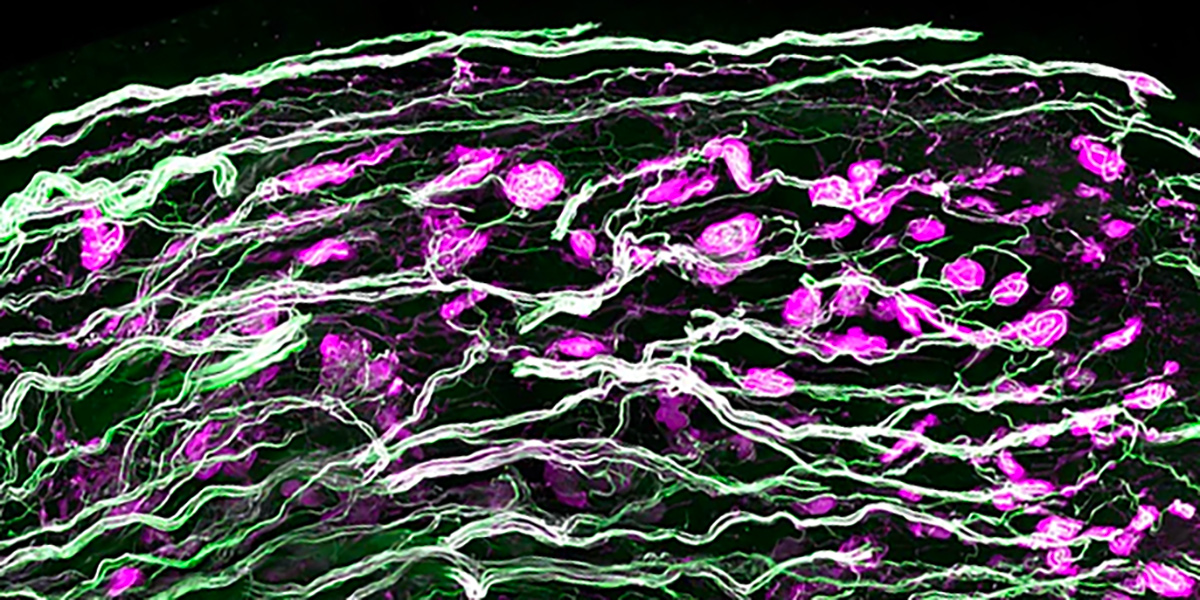Via Fani, Roma, 16 marzo 1978, ore 9
La storia dell'agguato in cui 40 anni fa fu rapito il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro

altre
foto
A 40 anni dal rapimento e dall’assassinio di Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana, la vicenda è ancora difficile da raccontare. In parte per le naturali reticenze dei protagonisti, che operarono in un’epoca convulsa e turbolenta nella storia della Repubblica; in parte per via delle innumerevoli dietrologie e teorie del complotto che hanno alimentato una serie quasi infinita di libri, articoli e documentari. Una cosa, però, almeno la sappiamo. Il 16 marzo del 1978, in via Fani, cinque uomini della scorta di Aldo Moro furono uccisi nel corso di un’operazione del gruppo terroristico Brigate Rosse.
La strage di via Fani è solo l’inizio di una storia enorme: lo scorso 16 dicembre una nuova commissione parlamentare di indagine sul rapimento e l’uccisione di Aldo Moro ha pubblicato la sua terza relazione in cinque anni di lavoro, che si può leggere qui per intero. Nonostante sia stata la quinta commissione parlamentare a essersi occupata del caso, il suo lavoro è stato definito dagli stessi autori “non esaustivo”. I commissari hanno tratteggiato almeno una decina di piste inesplorate, filoni trascurati e tentativi di depistaggio che, scrivono, meriterebbero ulteriori approfondimenti.
Attenzione, la galleria contiene immagini molto forti
Nella relazione vengono sospettati, tra gli altri, il coinvolgimento dei servizi segreti italiani, deviati e non deviati, l’influenza della mafia siciliana e della ‘ndrangheta calabrese. Si ipotizzano legami con il Vaticano, i servizi segreti americani e quelli sovietici. Si fanno accenni a possibili depistaggi della P2, al coinvolgimento di milizie palestinesi e libanesi e al ruolo di estremisti tedeschi, oltre alla presenza di trattative occulte tra brigatisti e Democrazia Cristiana. Secondo alcuni la commissione non ha avuto il coraggio di andare al fondo di queste questioni, limitandosi ad accenni sommari ed enigmatici, senza chiarire una volta per tutti gli inconfessabili misteri che aleggiano dietro il caso Moro. Secondo altri, come il giornalista Massimo Bordin, il lavoro della Commissione è stato viziato dal desiderio dei suoi componenti di trovare prove di oscuri complotti.
Questa, comunque, è la storia di quello che avvenne quel giorno: quarant’anni fa oggi.
Ore 8.45 – ore 9
La mattina del 16 marzo, poco prima delle 9, cinque agenti della scorta di Aldo Moro, il presidente del partito che governava l’Italia dalla fine della Seconda guerra mondiale, erano in attesa davanti al numero 79 di via del Forte Trionfale, nella zona Nord Ovest di Roma. Erano il capo scorta, maresciallo dei carabinieri Oreste Leonardi, l’appuntato Domenico Ricci e tre agenti di polizia: Francesco Zizzi, Giulio Rivera e Raffaele Iozzino.
Moro uscì dalla sua abitazione pochi minuti prima delle 9 e si sedette sul sedile posteriore della prima automobile, una FIAT 130. Di fronte a lui si sedettero l’autista e il maresciallo Leonardi, da anni nella scorta di Moro. Altri tre agenti li seguivano in una seconda automobile. Nessuno di loro pensava di essere in pericolo. Leonardi teneva la sua pistola d’ordinanza in un borsello sotto il sedile, l’autista la teneva all’interno del cruscotto. L’unico mitra in dotazione alla scorta era chiuso nel portabagagli della seconda auto. I brigatisti lo presero dopo il sequestro e dissero che era arrugginito al punto da essere inservibile. All’epoca il ministero dell’Interno aveva a disposizione in tutto 28 auto blindate: né la scorta di Moro né quella di altri importanti personaggi della DC, come il presidente del Consiglio Andreotti e quello del Senato Fanfani, ne avevano una a disposizione.
Poco prima che Moro entrasse in macchina, di fronte alla sua abitazione era passato un giovane ex operaio di 31 anni, Mario Moretti, che con la coda dell’occhio aveva verificato che le auto della scorta fossero dove se le aspettava. Moretti era uno dei quattro membri del Comitato esecutivo delle Brigate Rosse, l’organo di comando del gruppo terroristico di estrema sinistra fondato otto anni prima. Moretti era un “regolare”, cioè un miliziano a tempo pieno delle BR. Da sei anni viveva in clandestinità, con documenti falsi e uno stipendio pagato dell’organizzazione pari a quello di un operaio metalmeccanico. Tra il 1976 e il 1977 gli era stato affidato il compito di guidare la cellula di brigatisti romani nel più importante attacco mai tentato dall’organizzazione: rapire il presidente della Democrazia Cristiana, il partito che, secondo le BR, controllava in segreto la macchina dello Stato italiano.
Dopo aver verificato che la scorta fosse effettivamente al suo posto e che Moro sarebbe presto salito in macchina, Moretti raggiunse a piedi tutti i componenti del commando che in quel momento stavano prendendo posizione. A ciascuno disse che l’operazione si sarebbe fatta quella mattina. Chi e quante persone esattamente abbiano partecipato all’operazione rimane ancora oggi poco chiaro. Sappiamo per certo che parteciparono 11 brigatisti, tra cui almeno due donne. Sappiamo anche che tutti avevano tra i 23 e i 31 anni. Ma non è impossibile che all’attacco abbiano partecipato fino ad altre due persone, mai scoperte e che i loro compagni hanno poi voluto proteggere. Quello che sappiamo è che dopo aver avvertito i compagni che l’operazione si sarebbe fatta, Moretti prese il suo posto e attese.
La prima brigatista ad avvistare Moro dopo la ricognizione di Moretti fu Rita Algranati, nome di battaglia “Marzia”, ferma a un incrocio con un mazzo di fiori in mano. Quando vide le due auto di Moro svoltare di fronte a sé fece un segnale convenuto e si allontanò sul suo motorino. Moro e la sua scorta avevano appena imboccato via Fani.
Ore 9 – ore 9.05
Via Fani si trova in un quartiere tranquillo e residenziale di Roma Nord, dove le strade sono larghe e poco trafficate. È leggermente in salita: le macchine che arrivano da via Trionfale sono costrette a rallentare un po’ prima di arrivare allo stop che si trova all’incrocio con via Stresa. Intorno alle 9 di mattina Moretti era a bordo di una FIAT 128 familiare parcheggiata circa 200 metri prima dello stop. Il segnale di Algranati era destinato a lui. Non appena lo vide uscì rapidamente dal parcheggio, sbucando subito davanti all’auto di Moro che precedeva quella della scorta. Il compito di Moretti era il più delicato di tutta l’azione: doveva anticipare le auto di Moro, “guidarle” fino al punto dell’agguato e poi fermarsi. La sua automobile avrebbe così costituito il blocco che avrebbe impedito a Moro di scappare, bloccando l’auto in via Fani.
Il piano dell’agguato colpisce ancora oggi per la sua minuziosa pianificazione. Per esempio, per assicurarsi che gli agenti non sospettassero nulla, l’auto di Moretti aveva una targa del corpo diplomatico che le BR avevano rubato cinque anni prima a un funzionario dell’ambasciata venezuelana. Moretti, con le auto di Moro al seguito, percorse lentamente via Fani; dopo circa un centinaio di metri una seconda auto con due brigatisti a bordo uscì dal suo parcheggio, come aveva fatto Moretti, e si mise in coda al convoglio. Entro pochi secondi avrebbe bloccato l’unica altra via di fuga di Moro, impedendo alle sue auto di fare retromarcia. I due occupanti erano armati, ma soltanto per minacciare gli eventuali passanti e curiosi. Il gruppo che aveva il compito di uccidere la scorta si trovava nascosto un centinaio di metri più avanti.
Moretti guidò probabilmente per circa trenta secondi, prima di arrivare allo stop che segna l’incrocio tra via Fani e via Stresa. Al processo racconto che appena fermò la macchina guardò nello specchietto retrovisore. Nell’auto dietro di lui Moro stava leggendo il giornale. Ricci, il carabiniere che guidava l’automobile, lo guardò negli occhi e con la mano gli fece cenno di ripartire. In quel momento cominciarono a sparare.
Il gruppo di fuoco era formato da altre quattro persone. Erano tutti arrivati all’incrocio un quarto d’ora prima e si erano sistemati dietro le siepi che delimitavano il patio del bar Olivetti, chiuso dall’anno prima. Organizzare questa parte del piano non era stato facile. Nell’Italia del 1978, quattro giovani fermi all’angolo di una strada rischiavano di destare sospetti. Se poi l’attacco fosse stato rimandato, avrebbe significato che per più giorni di seguito il gruppo sarebbe dovuto rimanere fermo nello stesso posto, rischiando di attirare l’attenzione. I brigatisti decisero di travestirsi. Quella mattina tutti e quattro indossavano divise dell’Alitalia: oltre a dargli una ragione plausibile per rimanere lì – sembravano piloti in attesa del pulmino per l’aeroporto – consentivano anche un altro beneficio: i lunghi impermeabili e i borsoni da viaggio permettevano di nascondere facilmente mitra e giubbotti antiproiettile.
Le armi e l’addestramento dei brigatisti erano il punto più debole di tutto il piano. Dei quattro mitra, tre erano residuati bellici della Seconda guerra mondiale appartenuti a partigiani comunisti. Due si sarebbero inceppati durante l’azione. I brigatisti inoltre non erano tiratori scelti. Al processo raccontarono che allenarsi a sparare vivendo in clandestinità non era affatto facile. Quasi nessuno nel gruppo di fuoco aveva sparato più di un paio di volte in vita sua, di solito durante frettolose sessioni di allenamento sul litorale romano.
A quella distanza, però, non c’era bisogno di grande addestramento. Via Fani è larga una decina di metri. Quando il gruppo di fuoco vide le auto fermarsi, uscì da dietro le siepi e non iniziò a sparare prima di essere arrivato a metà della carreggiata: probabilmente meno di cinque metri dalle auto di Moro. Secondo le perizie balistiche, alcuni colpi furono sparati così vicino che i brigatisti avrebbero potuto toccare l’auto di Moro. «A quella distanza era quasi impossibile sbagliare», raccontò una di loro.
La ricostruzione della polizia scientifica della sparatoria
L’azione durò pochi secondi. L’autista di Moro fu centrato da otto colpi; il capo della scorta, il maresciallo Leonardi, da nove. Morirono entrambi senza avere il tempo di prendere le armi. A quella distanza, e con Moro seduto sui sedili posteriori dell’auto, non c’era rischio di sbagliare bersaglio. Altri colpi centrarono l’auto della scorta, uccidendo due agenti. Le armi dei due brigatisti che avevano il compito di neutralizzare la scorta nella seconda auto si incepparono. Uno degli agenti a bordo, Iozzino, riuscì a uscire, a tirare fuori la sua pistola d’ordinanza e sparare due colpi. Tutti e quattro i brigatisti a quel punto si voltarono su di lui e iniziarono a sparare, chi con i mitra chi con le pistole. Iozzino fu colpito 17 volte e morì sul colpo. In tutto furono esplosi 91 colpi, di cui 45, il 49 per cento del totale, raggiunsero gli agenti.
Una delle scene della fiction “Aldo Moro – Il presidente” ripresa da un balcone di via Fani
Ore 9:05 – 9:35
Iozzino fu l’ultimo a essere ucciso. Subito dopo i brigatisti si avvicinarono all’auto di Moro, aprirono la portiera e lo portarono fuori. Al processo chiesero loro se Moro avesse detto qualcosa. I brigatisti risposero di no: «Eravamo sotto shock noi, figuriamoci lui». Per l’operazione e la fuga i brigatisti avevano previsto di usare quasi una decina di auto (ma anche su questi numeri ci sono dei dubbi), tutte rubate da fiancheggiatori delle BR nelle settimane precedenti. Intorno a via Fani in quel momento ce n’erano già altre tre, oltre a quella di Moretti, che fu abbandonata sul posto, e a quella che bloccò da dietro il convoglio. Un’altra automobile si trovava nel mezzo dell’incrocio, con il compito di tenere lontani curiosi ed eventuali auto della polizia. Un’altra ancora entrò nella via in retromarcia per caricare a bordo Moro, che fu nascosto sotto una coperta. La terza, infine, era parcheggiata poco lontano e servì al resto del gruppo di fuoco per allontanarsi.
La prima chiamata fatta al 113 in cui una voce anonima disse che c’era stata una sparatoria in via Fani è delle 9:03, quindi è probabile che proprio in quei minuti la colonna dei brigatisti a bordo delle quattro auto stesse percorrendo a gran velocità le strade del quartiere Monte Mario per allontanarsi dal luogo della strage. Anche sulla fuga esistono versioni discordanti, ma sembra abbastanza chiaro che il piano fosse stato studiato in maniera minuziosa. Tra gli altri accorgimenti, i brigatisti avevano previsto l’attraversamento di una strada privata di campagna per far perdere le proprie tracce. La strada era sbarrata da una catena che avrebbe dovuto essere tagliata. Per sicurezza, tutte le auto avevano a bordo almeno un paio di tronchesi. Come ulteriore misura di sicurezza, un’altra auto ancora, con a bordo un autista, era parcheggiata lungo il percorso di fuga, in caso qualcosa fosse andato storto. Non ci fu bisogno di utilizzarla.
Moro fu trasbordato due volte. La prima, probabilmente, in piazza Madonna del Cenacolo. L’auto che lo trasportava fu parcheggiata vicino a un furgone, con le altre macchine intorno che facevano da muro, per impedire la vista a chi passava. Moro, ancora sotto shock, fu portato dentro il furgone e chiuso in una cassa. Il gruppo a quel punto si sciolse. Moro fu portato a bordo del furgone fino al parcheggio sotterraneo della Standa di Colli Portuensi, dove il trasbordo di una cassa non avrebbe destato sospetti. A quel punto fu caricato a bordo di una Citroën Ami 8, un’auto regolarmente detenuta da una dei fiancheggiatori dell’organizzazione, la stessa che aveva regolarmente acquistato l’appartamento dove si trovava la cosiddetta “prigione del popolo” dove sarebbe stato custodito Moro.
Pochi minuti dopo l’ultimo trasbordo, l’automobile guidata da Moretti, accompagnato da Prospero Gallinari, l’unico altro brigatista che conosceva l’ubicazione della “prigione del popolo”, entrò nel parcheggio sotterraneo di via Montalcini 8, da dove un ascensore li avrebbe portati quasi direttamente all’appartamento dove Moretti e Gallinari, entrambi operai, avevano personalmente costruito una cella insonorizzata. Appena trentacinque minuti dopo la sparatoria Moro fu fatto entrare nella stanza dove avrebbe trascorso i successivi 55 giorni, gli ultimi della sua vita.