Ci sono “cure” per i molestatori sessuali?
Ma soprattutto: i molestatori sessuali sono dei malati? Che cos'è la dipendenza da sesso? E il consenso cosa c'entra?
di Giulia Siviero
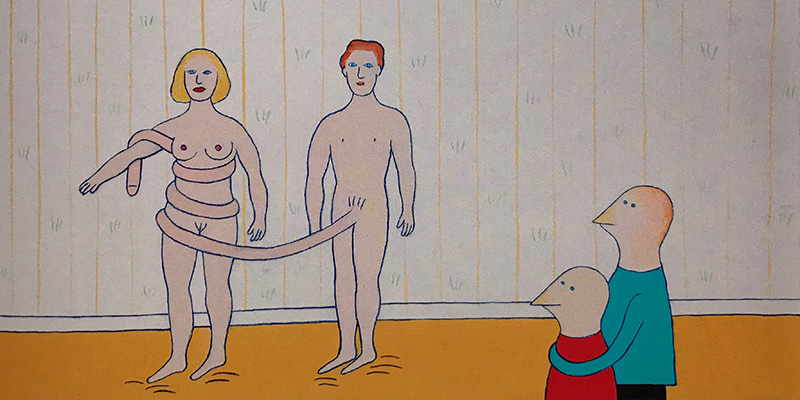
Harvey Weinstein, il produttore cinematografico statunitense da settimane al centro di un grande scandalo per molestie sessuali, lo scorso 5 ottobre aveva diffuso un comunicato in cui tra le altre cose diceva: «Mi aspetta un viaggio che mi porterà a conoscermi meglio e a dominare i miei demoni». Il 10 ottobre il sito di gossip TMZ ha scritto che Weinstein stava per andare «in una clinica di riabilitazione» per curare la sua dipendenza dal sesso. Il portavoce di Kevin Spacey, altro personaggio famoso accusato di molestie, ha annunciato più o meno la stessa cosa: ha detto che l’attore si sarebbe preso «il tempo necessario per curarsi».
Ricondurre queste storie all’ambito della malattia può avere diversi effetti: indurre le altre persone a provare maggiore empatia, deresponsabilizzare chi ha agito e dare l’idea che possa esserci una soluzione semplice e codificata al problema. Hai la tosse, prendi lo sciroppo; hai una dipendenza da sesso, pure. In questo caso, però, sia la diagnosi che la medicina sono ben più complicate e incerte. Che rapporto c’è, dunque, tra quelle che in modo generico potremmo chiamare “cattive condotte sessuali” e disordini psichici? E tra le cattive condotte sessuali che posto ha la dipendenza dal sesso? Infine: come si combinano insieme disturbi e cultura (intesa non in senso umanistico, ma come sistema del nostro stare insieme)? E di conseguenza: quali “cure” esistono? E per chi?
Il sex offender e le categorie criminologiche
La prima domanda è ineludibile se vogliamo capire di cosa parliamo: dato che esistono molte cose diverse che si possono definire “cattive condotte sessuali”, in base a cosa è possibile fare distinzioni all’interno di questo insieme? Meglio far riferimento alla giurisprudenza, alla criminologia o alla psichiatria?
Il problema, per quanto riguarda la giurisprudenza, è che le categorie dipendono dalle legislazioni dei vari paesi. Quelle contemplate dalla psichiatria, poi, spesso non coincidono con quelle riconosciute dalla legge: l’esibizionismo, cioè gli “atti osceni in luogo pubblico”, è stato depenalizzato in Italia nel 2016, ma nel DSM-5 (il Manuale diagnostico e statistico psichiatrico che è la principale fonte per i disturbi psichiatrici ufficialmente riconosciuta in tutto il mondo) è considerato una parafilia. La psichiatria individua una serie di comportamenti sessuali atipici: perversioni sessuali che consistono in ricorrenti impulsi, fantasie o comportamenti sessualmente eccitanti che vengono indirizzati verso oggetti inanimati, bambini, persone non consenzienti o che hanno a che fare con il fatto di ricevere o infliggere della sofferenza fisica o psicologica a se stessi o agli altri. Resta comunque molto difficile che si presentino, per così dire, “in purezza”: ci arriviamo.
Paolo Giulini, criminologo che si occupa di prevenzione e “cura” degli autori di reati sessuali, ha spiegato al Post che «non è consigliabile parlare di categorie a livello psicopatologico, ma criminologico: nel nostro codice penale sono cioè presenti delle condotte da punire». Ci ha anche spiegato – e qui veniamo al discorso sulla “purezza” dei disturbi – che i fattori che portano le persone a compiere questi atti «sono molteplici» e che «non c’è dunque un’unica causa universale dell’agire criminoso a sfondo sessuale, bensì un insieme di possibili variabili causali».
Di conseguenza, come è spiegato bene qui, «non esiste uno standard condiviso che permetta di categorizzare la personalità del sex offender tramite dei criteri diagnostici ben definiti»: non esiste un modello di vittima perfetta e non esiste il modello del perfetto stupratore. «Stiamo parlando di un reato trasversale che viene commesso all’interno di qualsiasi ceto sociale e da persone di qualsiasi tipo di livello culturale», aggiunge Giulini. E quando gli chiediamo se nella sua lunga esperienza ha individuato delle costanti che permettano di stabilire delle categorie all’interno delle cattive condotte sessuali, ci spiega che sì, «possono esserci delle esperienze infantili problematiche e vari fattori culturali nel caso della violenza contro le donne», ma aggiunge anche che – sebbene possano esserci persone con tratti patologici – «sono comunque rari i casi in cui c’è una vera e propria devianza». Una volta commesso il reato, un punto di partenza comune, invece, è individuabile: il sex offender si percepisce come una vittima, nega quanto ha fatto o lo minimizza.
Giulini ha fondato nel 1995 il Centro Italiano per la Promozione della Mediazione (C.I.P.M.), da cui a Milano dipende il Presidio Criminologico Territoriale, che è un servizio del settore Sicurezza del comune dove si svolge un’attività clinica di prevenzione rivolta ai soggetti che hanno compiuto condotte violente a rischio di recidiva o che sono coinvolti in situazioni che rischiano di passare dalla potenza all’atto. Nel 2005 Giulini ha ottenuto i fondi per avviare un progetto con i sex offender al carcere di Bollate. Qui il percorso delle persone che rientrano nel programma dura un anno, procede per tappe secondo un approccio multidisciplinare e attraverso un lavoro che si svolge sia in gruppo che individualmente: sono previsti incontri in cui si lavora sulla parola, sull’abilità sociale, sull’empatia, sulla gestione dello stress, sul senso di responsabilità, ci sono lezioni di yoga, meditazione e corsi di educazione sessuale. Per esempio è fondamentale, nel percorso di trattamento, portare l’aggressore a usare le parole esatte per parlare di ciò che ha fatto (e quindi dire “Ho messo le mani nei suoi pantaloni contro la sua volontà”, per esempio, e non “sono andato un po’ oltre”), dargli la possibilità di ascoltare la storia delle vittime per sviluppare empatia nei loro confronti, renderlo consapevole delle conseguenze delle sue azioni non solo sulla vita delle altre, ma anche sulla propria, reputazione compresa.
L’obiettivo finale, spiega Giulini, «è aiutare queste persone a diventare consapevoli dei loro fattori di rischio ed evitare quindi una ricaduta». E questo avviene attraverso un’operazione di «smantellamento dei meccanismi difensivi, delle distorsioni cognitive che impediscono alle persone di riconoscere ciò che hanno fatto». Il trattamento, stando ai numeri, funziona: all’interno del carcere di Bollate, in dodici anni, su 248 persone trattate si sono verificate solo 9 recidive. I progetti di altri paesi confermano: tramite il trattamento le recidive calano della metà.
Cure e limiti
Una volta stabilito che possono esserci percorsi di riabilitazione e che questi percorsi portano a risultati significativi, va anche detto che rimangono almeno due grandi problemi: la volontarietà e i numeri.
Come si racconta qui, «a differenza del mondo anglosassone e della Francia – dove il trattamento per questo tipo di reati è parte integrante e obbligatoria della rieducazione del condannato – in Italia l’adesione a un progetto di recupero è su base volontaria». L’esperienza di Bollate è infatti unica in Italia, e dunque riesce a intercettare solo una piccolissima percentuale delle persone che hanno commesso un reato a sfondo sessuale.
Facciamo un esempio. L’ISTAT dice da decenni che la percentuale delle denunce delle donne che hanno subito violenze è molto bassa, mentre è altissima la percentuale delle donne che afferma di aver subito violenza. Questo rapporto riguarda anche lo stalking. Il 78 per cento delle donne che hanno detto di essere state perseguitate da qualcuno non si è rivolto ad alcuna istituzione e non ha cercato aiuto presso servizi specializzati. Di quelle che hanno cercato aiuto, solo il 48,3 per cento ha denunciato o sporto querela: l’8,6 per cento di loro ha ottenuto l’ammonimento, nel 4,5 per cento dei casi l’autore è stato arrestato e nel 4,6 per cento condannato. Questi dati dicono che se anche l’esperienza del carcere di Bollate venisse applicata a tutti i condannati per stalking, e non è così, staremmo comunque parlando di una percentuale pari al 4,6 per cento.
Roberta Rossi, presidente della Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica, ci ha confermato che «viene agganciata una piccolissima parte delle persone che vengono arrestate» e che «coloro che individualmente riescono a leggere il proprio comportamento come eccessivo o dannoso, nonostante non vengano arrestate o condannate, sono ancora meno. Di conseguenza è molto difficile che si presentino su base volontaria».
E la dipendenza dal sesso?
La “dipendenza dal sesso” è un argomento controverso, anche all’interno della comunità scientifica. Molte persone credono che sia un problema serio e reale, altre lo escludono a priori. Nonostante “dipendenza sessuale” (sex addiction) sia un termine ampiamente utilizzato, raccontato dalla cultura mainstream e pure dal cinema, non è presente nel DSM-5. Nel 2014 la comunità psichiatrica statunitense ha negato che possa essere considerata un disturbo mentale e l’ha distinta da altri comportamenti che creano dipendenza.
Si possono trovare online molti recenti articoli che si occupano della dipendenza dal sesso, e praticamente tutti sostengono che non esista. Questo perché a oggi non esistono evidenze o criteri diagnostici ben precisi che la individuino: anzi ci sono indagini e studi che dimostrano il contrario e mostrano come il 92 per cento degli uomini che si definiscono sex addicts in realtà abbiano altri problemi psichiatrici. Nessun esperto intervistato sostiene comunque che le persone non possano distruggere e non distruggano effettivamente le loro vite sulla base di comportamenti sessuali compulsivi e rischiosi, e nessuno sostiene che alcune persone abbiano difficoltà a regolare i loro pensieri, desideri e comportamenti sessuali. La parola “dipendenza”, si dice, ha però una precisa definizione clinica.
Joye Swan, che insegna Psicologia in California, ha scritto per esempio che ci si è allontanati sempre di più dall’adesione al significato scientifico delle parole e che questo ha portato a una cultura che in generale trasforma in patologia ciò che prima rientrava in un ambito di normalità. E fa un esempio: da un sondaggio dell’American College Health Association risulta che il 45 per cento delle donne e il 36 per cento degli uomini abbiano riferito di avere una depressione così grave che rende loro difficile la vita. Ma dire di essere depressi, spiega Swan, non è la stessa cosa che aver ricevuto una diagnosi di depressione. «Non ci auto-diagnostichiamo il cancro o il diabete (…) Perché allora permettiamo la diagnosi soggettiva della salute mentale?».
Quando si tratta di sesso e disturbi mentali (reali o presunti), poi, tutto è ancora più confuso e ideologicamente connotato. David J Ley, autore di un libro che si intitola The Myth of Sex Addiction, sostiene che dietro alla definizione di “dipendenza sessuale” (e al suo successo) ci siano molti concetti che hanno a che fare con la morale e che suggeriscono come il sesso sia qualcosa di pericoloso, che non dovrebbe essere “apprezzato” in modo eccessivo. Dice che non ci sono al mondo due psicoterapeuti che applichino il concetto di “dipendenza sessuale” allo stesso modo, che alcuni pensano che la dipendenza dal sesso sia una compulsione, altri che sia una reazione ai traumi sessuali, anche se poi «ci sono molte persone che hanno subito abusi e non hanno nessuno di questi problemi, e molte persone che hanno problemi sessuali ma non sono stati mai abusati».
Da dove viene allora questa visione del desiderio sessuale come una specie di mostro che non può essere controllato? Secondo Ley è l’inevitabile conseguenza della lunga guerra contro il sesso condotta da società e religione, occupate per decenni a far passar l’idea che il desiderio sessuale è qualcosa di distruttivo, e che l’unico modo in cui gli uomini possono controllarlo è eliminarlo o circoscriverlo. Ovviamente attraverso paura e proibizioni: la “dipendenza sessuale” sarebbe dunque la versione evoluta del “masturbarsi rende ciechi”.
Joshua Grubbs, psicologo alla Bowling Green State University, Ohio, ha scoperto che le persone religiose hanno molte più probabilità di credere di essere dipendenti dal sesso rispetto ai non credenti, indipendentemente da quanto ne facciano. Molti hanno poi una comprensione limitata della “diversità sessuale”, cosa che potrebbe renderli più rapidi nel processo di patologizzazione di quei comportamenti non conformi a uno standard eterosessuale monogamo. Ma la storia del sesso si è evoluta, certe pratiche considerate devianti ora non lo sono più (come l’omosessualità, per esempio). E già negli anni Cinquanta Alfred Kinsey, comprendendo la varietà dei desideri e delle esperienze sessuali, ammonì contro la patologizzazione di ciò che semplicemente sembrava differente. La normalità, diceva, è qualcosa di soggettivo, e molti giudizi sono più morali che scientifici. Quella che secondo alcuni potrebbe essere una ninfomane potrebbe quindi essere semplicemente una donna che fa più sesso di chi la sta giudicando. Se ci si muove all’interno di un concetto, come quello di dipendenza sessuale, che non riguarda precise evidenze diagnostiche, di tutte queste influenze va tenuto conto.
Nonostante l’assenza della dipendenza sessuale dal DSM-5, molti terapeuti e programmi di recupero dichiarano di poterla trattare e curare, anche in Italia. Negli Stati Uniti la “cura” della dipendenza dal sesso è diventata un grande business, come si dice. Non solo. In molti casi è diventata anche una strategia giustificatoria e molto conveniente per uomini che vengono sorpresi a fare “qualcosa che non va” (tradire la moglie, per esempio). Le stesse mogli, dicono gli esperti, tendono a essere più tolleranti verso l’infedeltà quando credono che sia il “sintomo” di una malattia. I malati non possono insomma essere ritenuti pienamente responsabili delle loro azioni.
Dipendenza sessuale e molestie
Affermare “sono dipendente dal sesso e guardo film porno dieci ore al giorno” o “sono dipendente dal sesso e quindi ho tradito mia moglie” è la stessa cosa che affermare “ho una dipendenza dal sesso e molesto chiunque”? La dipendenza sessuale e le molestie possono insomma stare sullo stesso piano? Anche in questo caso, spostare un comportamento che evoca disgusto e sdegno nella sfera di una malattia può portare a una maggiore comprensione ed empatia da parte degli altri. E secondo molti è dunque piuttosto chiaro perché Weinstein e altri nella sua situazione abbiano lasciato intendere di essere persone malate. Il concetto di dipendenza applicato in questi casi ha poi un’altra conseguenza, che supera la relazione “tra moglie e marito”: non solo confonde le responsabilità e le consapevolezze reciproche, ma cancella anche la linea tra colpevole e vittima.
Va poi chiarita una cosa: anche gli psichiatri e i terapeuti che considerano la dipendenza sessuale una malattia, che quindi si può diagnosticare o curare clinicamente, spiegano o che il sesso non è il nodo della questione o che, soprattutto, la dipendenza sessuale non coincide con le molestie.
Giulini dice che la dipendenza sessuale può essere un fattore di rischio, ma che non è un abuso. Attraverso il sesso si compensano cioè sofferenze o disfunzioni della psiche. Roberta Rossi, a sua volta, ci ha detto che «può esser utile riconoscere i segnali di una cosiddetta dipendenza sessuale dal punto di vista clinico, perché dobbiamo essere in grado di accogliere e aiutare le persone che si presentano con una determinata domanda anche in mancanza di un riferimento diagnostico». Ma anche che «in questi casi non c’entra il troppo sesso ma il modo in cui quella determinata persona lo vive». E ancora: «La dipendenza sessuale può portare a comportamenti rischiosi, ma nella maggior parte dei casi non c’entra nulla con le molestie, con la mancanza di consenso da parte dell’altra persona. Ed è per questo che non può diventare una facile via di fuga per chi ha commesso molestie o abusi di potere attraverso il sesso. Il rischio è che tutti i molestatori sessuali passino per dipendenti. Ed è qui che entrano in gioco i clinici che è necessario abbiano un quadro della situazione di cui stiamo parlando e che facciano degli approfondimenti specifici. Detto questo, in tribunale la diagnosi di dipendenza sessuale non può essere considerata valida, visto che a tutt’oggi non esiste una categoria diagnostica definita».
Andrea Bramucci, psicologo-psicoterapeuta che coordina il centro San Nicola di Senigallia dove si tratta la dipendenza sessuale, ci ha confermato che la dipendenza dal sesso è una compulsione «che non ha niente a che vedere con le molestie. La persona che ha una dipendenza sessuale è (a suo parere) portatrice di una dipendenza che può esprimere attraverso la masturbazione, la ricerca di rapporti sessuali a pagamento ossessivi o di pratiche spinte e pericolose per sé. Ma non va fatta confusione: non stiamo parlando di sesso non consensuale. Un conto è che consensualmente si pratichi la propria dipendenza sessuale, un altro è usare il nome di una malattia per difendersi». Joye Swan, parlando nello specifico del caso Weinstein, ha scritto molto chiaramente: «Non è una persona che ama il sesso, ma una persona che ama il potere e l’intimidazione: è solo un altro uomo che brama usare il potere per ferire le donne».
I malati immaginari e la cura del mondo
Torniamo per un momento al racconto di Giulini sui sex offender. Giulini ci ha spiegato che la distorsione cognitiva «funziona sia come spinta di passaggio all’atto che come giustificazione ex post» e che «per quanto riguarda la violenza contro le donne ha a che fare con i classici stereotipi di genere basati sul mito del machismo». La grande difficoltà di trattare questi tipi di condotte riguarda dunque il fatto che «oltre al lavoro sugli aspetti dello psichismo va fatto un lavoro anche sulla cultura, sulle distorsioni cognitive che provengono dai modelli sub-culturali» (sul “se l’è cercata”, per capirci). D’altra parte, ci ha detto ancora Giulini, «in carcere verso un molestatore di donne c’è un ostracismo minore che non verso un pedofilo». Ma non solo in carcere. I processi di patologizzazione delle molestie funzionano come annullamento delle responsabilità e come rafforzamento dei meccanismi di negazione. Ostacolano, infine, sia la guarigione che il vero il cambiamento.
Manuela Fraire, psicanalista e femminista, concorda: all’interno delle cattive condotte sessuali «la violenza contro le donne ha una sua specificità. La violenza maschile è profonda, ed è in corso una guerra dei sessi dovuta al fatto che le donne non investono più tutte le loro energie e il loro bisogno d’amore nel rapporto con un uomo. Il desiderio femminile di vivere in proprio la vita per gli uomini è insopportabile, è vissuto come un abbandono, un tradimento quasi materno».
A tutto questo vanno poi aggiunte le convinzioni culturali sul genere che abbiamo interiorizzato, consapevolmente o meno: l’idea ancora molto radicata che l’aggressività maschile nei confronti delle donne faccia parte della biologia umana e che sia alimentata dal testosterone, o il culto della mascolinità che stabilisce che gli uomini siano predatori e che le donne siano le prede alla ricerca dell’imprevedibilità e del pericolo. «Bisognerebbe curare il mondo intero», spiega Fraire, che insiste molto su un femminile che sembra superato ma che invece le donne stesse contribuiscono a tenere in vita: «Va fatto un lungo lavoro di dis-identificazione, anche da parte loro: siamo ancora identificate con un modello di femminilità che rende possibile assolvere comportamenti che sono già il presupposto di un degrado della relazione. Questo proviene dall’educazione che abbiamo ricevuto, dal clima culturale in cui siamo cresciute, dal modello relazionale e sessuale che le famiglie hanno trasmesso senza accorgersene». L’identificazione femminile impedisce per esempio di vedere «per tempo che vengono fatti passare comportamenti che andrebbero fermati, comportamenti sostanzialmente abusivi che ci sembrano normali perché da quella parte c’è un uomo. Perché abbiamo fatto nostra la tesi che un uomo è aggressivo? Perché pensiamo che siano naturali certi comportamenti? Non lo sono. E poi ci sono gli uomini, che sono abituati ad essere in un certa posizione e che quando la perdono aggrediscono».
Che cosa significa non intervenire su tutto questo e anzi riservare i trattamenti a chi ha già commesso un reato o addirittura alimentare l’idea che siano tutti malati immaginari? Lo spiega attraverso i numeri l’Organizzazione mondiale della Sanità in un rapporto sugli impatti dell’educazione sessuale: nei paesi in cui è stata attuata, ha portato nel tempo a una diminuzione non solo delle gravidanze adolescenziali, degli aborti e delle malattie sessualmente trasmissibili, ma anche degli abusi sessuali e dei casi di omofobia.



