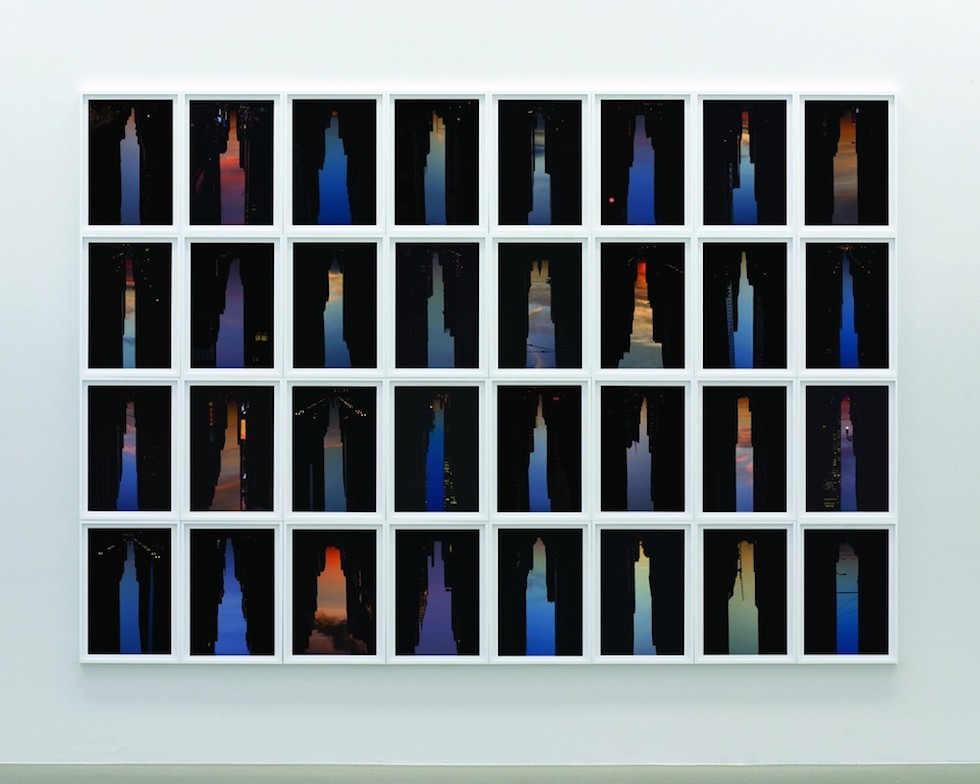L’Italia sta meglio, dice l’Economist
Il PIL cresce, l'occupazione va bene e la crisi bancaria sembra rientrata, ma ci sono ancora parecchie cose che non vanno e pessime prospettive di vederle sistemate

Il settimanale Economist è sempre stato molto attento, e molto critico, nei confronti dell’Italia. Nel 2011 si chiedeva se l’insipienza del governo Berlusconi non rischiasse di condannare l’intera area euro; nell’estate 2016 si occupò del sistema bancario italiano, definendolo un rischio per l’Europa più grave di Brexit; questa settimana, il giornale è tornato a parlare dell’Italia, ma per ragioni meno preoccupanti. In un articolo intitolato “Buone notizie dall’Italia”, il settimanale spiega come la situazione economica del nostro paese sembri essersi finalmente aggiustata, anche se non manca di far notare i problemi e le insidie che ancora minacciano l’economia.
Le buone notizie
L’articolo comincia ricordando che secondo le ultime stime l’Italia crescerà nel 2017 dell’1,5 per cento, una cifra che potrebbe salire ancora secondo le previsioni fatte dal governo lo scorso 5 settembre. Si tratta della crescita più rapida dall’inizio della crisi, ma sarebbe stato un tasso di tutto rispetto anche per gli anni precedenti al 2008. Era dall’inizio degli anni Duemila che l’economia italiana non andava così bene. L’Economist ammette che questo 1,5 per cento è un tasso di crescita ancora molto basso se paragonato a quello del resto della zona euro, dove l’economia cresce al 2,2 per cento di media. In altre parole, rispetto ai suoi vicini l’Italia continua ad essere un paese in “ritardo”, dove le recessioni sono più profonde e le riprese più lente. Il divario, però, sembra che si stia attenuando e il nostro paese sembra aver recuperato un po’ del terreno perso negli ultimi anni.
L’Economist scrive che anche i dati sul lavoro sono finalmente buoni. Il numero di occupati, cioè delle persone che hanno un lavoro, non era così alto dal 2008. Secondo gli ultimi dati, la disoccupazione continua a restare stabile, anzi: è leggermente cresciuta passando dall’11,2 per cento di giugno all’11,3 per cento di luglio. Ma questo non dovrebbe preoccuparci più di tanto: al termine di una recessione, solitamente, molte persone ricominciano a cercare lavoro dopo aver trascorso lunghi periodi senza nemmeno provarci. Chi non cerca lavoro non figura nelle statistiche sulla disoccupazione (i disoccupati sono definiti come coloro che non hanno lavoro e ne cercano attivamente uno), quindi – in maniera controintuitiva – non appena termina una crisi, un segnale di ripresa può essere proprio l’aumento della disoccupazione. Nel nostro paese sembra che sia in atto proprio una dinamica di questo tipo. I disoccupati aumentano, ma diminuiscono gli inattivi, cioè coloro che non lavorano, ma nemmeno sono in cerca di un’occupazione.
Secondo l’Economist, anche la situazione del sistema finanziario italiano è meno preoccupante di un anno fa. Lo stato è intervenuto per salvare la banca Monte dei Paschi e le due banche venete, Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Le operazioni sono state tutte molto criticate per essere arrivate tardi e per aver coinvolto nei salvataggi fondi pubblici, invece che penalizzare chi in quelle banche aveva investito. Nonostante questo, però, una situazione potenzialmente rischiosa è stata risolta, scrive il settimanale, e le cose continueranno a migliorare se le altre banche si comporteranno in maniera disciplinata, liberandosi dei loro “crediti deteriorati”, cioè i prestiti concessi che non riescono più a farsi restituire.
Infine, l’Economist sottolinea il successo che l’attuale governo ha ottenuto nel limitare l’immigrazione nel nostro paese, stringendo accordi con il governo libico e con le milizie che operano sul territorio. (Secondo diverse inchieste giornalistiche, il governo italiano ha anche fatto accordi con alcune organizzazioni criminali libiche, e il risultato di queste scelte è stato in ogni caso l’aumento esponenziale di persone imprigionate in Libia in condizioni terribili).
Le cattive
L’Economist ricorda che nonostante le buone notizie ci sono diverse cose che non funzionano in Italia. La disoccupazione giovanile è ancora saldamente intorno al 35 per cento e le misure adottate fino ad ora per cambiare questa situazione non sembrano aver avuto un effetto duraturo. Il settimanale ricorda che gli incentivi alle assunzioni sono stati uno sgravio fiscale soltanto temporaneo il cui effetto si è esaurito molto rapidamente. Praticamente non cita la nuova forma di contratto a tutele crescenti introdotta dal Jobs Act e spesso indicata dal segretario del PD Matteo Renzi come la ragione per l’aumento dell’occupazione.
In effetti non sembra che il Jobs Act da solo abbia avuto un forte impatto sul numero dei posti di lavoro. Le due “forze” che più hanno agito sul mercato nel lavoro negli ultimi anni, secondo gli esperti, sono da un lato gli sgravi fiscali alla contribuzione, dall’altro la riforma Fornero che ha mantenuto al loro posto numerosi anziani, soprattutto donne, che altrimenti ora sarebbero in pensione. Il governo Gentiloni sta pensando in queste settimane di trasformare i vecchi incentivi temporanei alle assunzioni in uno sgravio fisso per i più giovani, ma sarà difficile trovare le risorse per questa misura visto che molti all’interno del PD, in particolare i più vicini al segretario Renzi, insistono affinché almeno altrettante risorse siano spese a favore dei pensionati. Ma a limitare le risorse che i governi possono spendere per stimolare l’economia c’è il grande debito pubblico, che in questi ultimi anni non ha fatto che aumentare più o meno rapidamente. Pagare gli interessi sul debito costa all’Italia parecchi miliardi ogni anno, mentre il totale del debito è così grande da rendere incerta la capacità del nostro paese di ripagarlo in caso di nuove crisi o recessioni.
Ma se anche potessimo cancellare il debito con un tratto di penna, l’Economist ricorda che l’Italia ha un altro problema ancora più grave e di cui tra esperti ed economisti si parla da anni (anche se raramente il tema arriva sulle prime pagine dei giornali): la produttività del lavoro, cioè quanto valore riesce a produrre un lavoratore italiano in una certa quantità di tempo a paragone con i lavoratori di altri paesi. La produttività è influenzata da molti fattori diversi: il tipo di prodotti che vengono realizzati, l’abilità della forza lavoro, gli investimenti in macchinari, l’innovazione dei processi produttivi. L’Italia è da anni molto scarsa in tutti questi ambiti e secondo alcune ricerche è proprio il blocco della produttività una delle principali cause della decennale stagnazione del nostro paese.
Le ragioni di questa situazione sono numerose. Il tessuto imprenditoriale italiano è fatto soprattutto da piccole e piccolissime imprese con scarsa capacità di innovazione. Le imprese familiari, in particolare, rappresentano un ostacolo perché raramente le famiglie sono disposte a perdere il controllo dell’azienda mettendosi nelle mani di investitori in grado di fornirgli i capitali necessari all’innovazione. Ma anche le grandi imprese hanno spesso pochi incentivi ad innovare. In Italia esiste ancora un’ampia zona grigia in cui l’economia pubblica e quella privata si mischiano e si sovrappongono. Molte grandi società preferiscono infilarsi in queste nicchie di mercato dove le rendite sono garantite da alleanze politiche piuttosto che avventurarsi nel difficile terreno dell’innovazione e della competizione.
Quello che fa l’Economist è un lungo elenco di sfide difficili che i prossimi governi dovranno affrontare se vogliono mantenere i buoni presupposti di crescita che si sono visti negli ultimi mesi. Il settimanale, però, è scettico sulla loro capacità di farlo. Se i partiti non si accorderanno su una nuova legge elettorale, scrive, il risultato delle elezioni del prossimo anno sarà un parlamento ingovernabile, oppure una larga e instabile coalizione di destra e sinistra: entrambe situazioni in cui sembra complicato mettere in atto riforme di grande respiro.