Da dove viene il topinambur
E i cavoli, le zucche, le carote? Lo racconta la biografa Évelyne Bloch-Dano in un libro sulla storia delle verdure, dalla loro scoperta agli usi in cucina

L’interesse per i racconti biografici è generalmente legato alla fama e all’apprezzamento che si ha per la persona in questione: vogliamo conoscere dettagli personali e abitudini, ma vogliamo anche assistere alla formazione dei personaggi, che siano donne, uomini, oppure ortaggi. La favolosa storia delle verdure è il libro pubblicato da add editore in cui la biografa Évelyne Bloch-Dano – che di solito si occupa delle vite di persone importanti e in particolare di donne, come quella de La signora Proust – racconta come abbiano fatto il cavolo, la carota, il topinambur e altre verdure a diventare quello che sono oggi. O, come ha scritto nella prefazione al libro Michel Onfray (storico francese e fondatore dell’Université populaire du goût d’Argentan), per “mostrare che le verdure possiedono un’aura simbolica che va oltre il mero valore calorico o commerciale”.
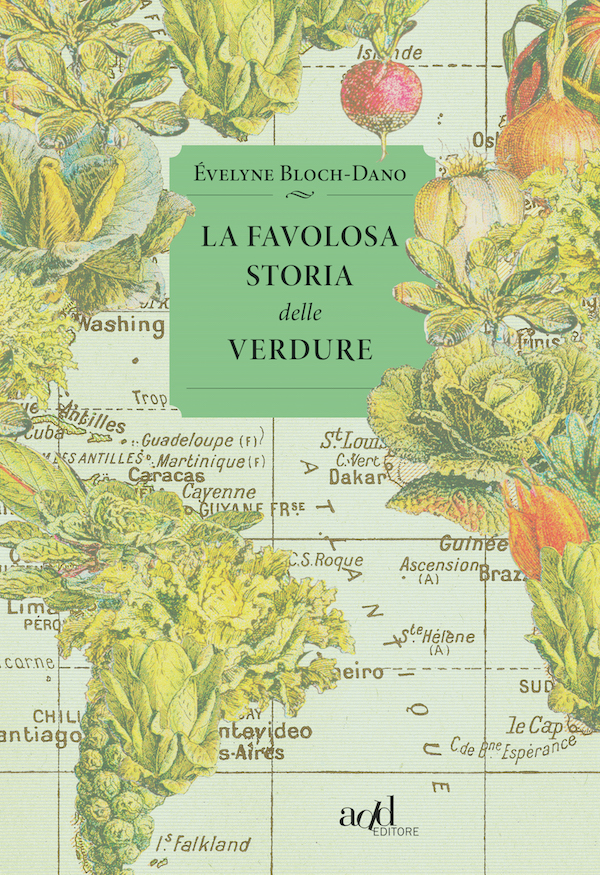 Nel suo libro (che è stato tradotto in italiano da Sara Prencipe) Bloch-Dano prende in esame dieci verdure, dal comune cavolo alla meno nota pastinaca, e ne ricostruisce la storia, arricchendo il racconto con aneddoti, poesie, citazioni e ricette. La storia dei singoli ortaggi si mischia alle innovazioni, alle scoperte e ai cambiamenti. Riflette sul rapporto tra cultura e natura, su quanto la prima abbia influenzato la seconda, portando come esempio le tecniche utilizzate negli ultimi anni per produrre rapidamente verdure più grandi e belle: pomodori più rossi e insalate più verdi di come sarebbero. “L’uomo – scrive la biografa – è l’unico essere vivente a non subire meccanicamente i vincoli dell’ambiente che lo circonda ma a poter scegliere la propria alimentazione in base a criteri non fisiologici, bensì simbolici”.
Nel suo libro (che è stato tradotto in italiano da Sara Prencipe) Bloch-Dano prende in esame dieci verdure, dal comune cavolo alla meno nota pastinaca, e ne ricostruisce la storia, arricchendo il racconto con aneddoti, poesie, citazioni e ricette. La storia dei singoli ortaggi si mischia alle innovazioni, alle scoperte e ai cambiamenti. Riflette sul rapporto tra cultura e natura, su quanto la prima abbia influenzato la seconda, portando come esempio le tecniche utilizzate negli ultimi anni per produrre rapidamente verdure più grandi e belle: pomodori più rossi e insalate più verdi di come sarebbero. “L’uomo – scrive la biografa – è l’unico essere vivente a non subire meccanicamente i vincoli dell’ambiente che lo circonda ma a poter scegliere la propria alimentazione in base a criteri non fisiologici, bensì simbolici”.
Ogni capitolo è poi introdotto dalla descrizione di un quadro, quasi sempre di nature morte, cioè il modo in cui sono rappresentati più frequentemente gli ortaggi, piuttosto trascurati rispetto a frutta, fiori e alberi: per ribadire il concetto, Bloch-Dano cita anche una serie di similitudini, come “belli come una rosa” e avere una “testa di rapa”. Ma le cose cambiano e le verdure hanno avuto la loro rivincita: lo si legge anche nel libro che “niente è più mutevole del gusto, influenzato dall’epoca, dal luogo, dal gruppo sociale cui apparteniamo, senza dimenticare la parte soggettiva e personale che coinvolge”.
Qui di seguito un estratto dal capitolo del libro in cui Bloch-Dano racconta la storia del topinambur, un ortaggio che nei secoli non ha avuto vita facile, menzionato per la prima volta da Samuel Champlain, l’esploratore francese che arrivo nell’attuale Canada nel 1603, dove fondò l’Acadia e la città di Québec, e che paragonò il suo sapore a quello del carciofo. A portarlo in Europa fu Marc Lescarbot, un avvocato che aveva vissuto qualche mese in Acadia: l’aveva scoperto dagli indiani che lo chiamavano chiquebi, ma lui avrebbe voluto chiamarlo Canada; in Europa iniziarono a diffondersi con vari nomi: “noci di terra”, “tartufi”, “patate”, “carciofi del Canada”.
***
Il topinambur
Contemporaneamente, nel 1613 sbarca in Francia una delegazione di indigeni tupinamba del Brasile, che devono esibirsi per l’arrivo del giovane re Luigi XIII a Rouen.
I tupinamba, un nome che nessuno sa come pronunciare (tupinambá? topinamba?) non sono del tutto sconosciuti al pubblico più colto. Jean de Léry li chiama Toüoupinambaoults nel suo Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil, pubblicato nel 1578 e considerato da Claude Lévi-Strauss il “breviario dell’etnologo”. Il libro fu molto amato da Montaigne, che pochi anni prima, nel 1562, aveva incontrato tre indigeni per l’arrivo a Rouen del piccolo Carlo IX e della madre, Caterina de’ Medici, incontro che diede origine a uno degli episodi più noti dei suoi Saggi. Quegli antropofagi gli apparvero molto assennati e lo indussero a interrogarsi sul concetto di barbarie. Cosa significa essere selvaggi? «Ora io credo che in quel popolo non vi sia nulla di barbaro e di selvaggio, a quanto me ne hanno riferito: se non che ognuno chiama barbarie quello che non è nei suoi usi.» Una bella lezione sulla relatività di costumi, valori e mora le, ma anche una riflessione sulla natura e, in nuce, sul mito del buon selvaggio.
Quando, nel 1613, i tupinamba sbarcano in Francia hanno quindi un immenso successo: ci si accalca per vederli danzare e agitare le piume che indossano, si rabbrividisce al pensiero dei loro usi culinari, che consistono nell’arrostire i nemici dopo aver loro amputato braccia e gambe, costume che aveva ispirato alcune riflessioni a Montaigne, per il quale non c’è «più barbarie nel mangiare un uomo vivo che nel mangiarlo morto, nel lacerare con supplizi e martìri un corpo ancora sensibile, farlo arrostire a poco a poco, farlo mordere e dilaniare dai cani e dai porci – come abbiamo non solo letto, ma visto recentemente, non fra antichi nemici, ma fra vicini e concittadini e, quel che è peggio, sotto il pretesto della pietà religiosa». Come denunciare la tortura e le guerre di religione con il pretesto dell’antropologia!
Per un bizzarro gioco di prestigio, i chiquebi canadesi hanno trovato la loro strada: in francese diventano topinambaux (Lescarbot), poi topinambou e infine topinambour, che rimane simile anche nell’italiano “topinambur”.
I vagabondaggi linguistici dell’Helianthus tuberosus però non sono finiti: per gli inglesi diventa Jerusalem artichoke, denominazione dubbia che nascerebbe dall’unione tra l’italiano “girasole” pronunciato con accento inglese e il sapore che ricorda il carciofo.
Il topinambur comincia a spopolare e viene servito persino alla tavola del re. Ma, forse in ragione della connotazione peggiorativa collegata alla nozione di selvaggio nel XVII secolo, in francese la parola topinambou comincia a poco a poco a indicare persone volgari e ottuse: «J’ai traité de Topinamboux / Tous ces beaux censeurs je l’avoue, / Qui, de l’antiquité si follement jaloux, / Aiment tout ce qu’on hait, blâment tout / ce qu’on loue» scrive il poeta Boileau. Lo stesso, decisamente appassionato al soggetto, definisce “topinamboue” l’Académie française! Brutto segno questa evoluzione semantica…
«Il topinambur» annota in una lettera del 29 ottobre 1658 il medico Guy Patin, preside della facoltà di Medicina di Parigi, «è una pianta che viene dall’America, della quale a Parigi non si fa uso, e da quanto ho sentito dire neanche altrove; un tempo se ne vendevano le radici, bulbose e tubercolose, ma non si usano più; ci volevano molto sale, pepe e burro, tre elementi dannosi…»
La fortuna del topinambur non è durata a lungo.
Dalla fine del XVII secolo la sua sorte è segnata. Per Antoine Furetière, nel suo Dictionnaire universel del 1690, il topinambur è «una radice tonda, nodosa, che i poveri mangiano cotta con un po’ di sale, burro e aceto». Rustico e prolifico, il topinambur perde la sua aura esotica e arriva sulle tavole dei poveri, danno irreparabile per la sua immagine. De Combles, autore dell’École du jardin potager (1752), non ha dubbi: lo indica come «il peggiore degli ortaggi, ma ancora molto consumato dal popolo».
Lo si mangia durante la quaresima in segno di penitenza. Per Jaubert, uno dei redattori dell’Encyclopédie, «queste radici sono insapori, acquose, insipide, gonfiano molto e non fanno bene, nel 1711 si smette infatti di mangiarle un po’ ovunque». Per sbarazzarsi di qualcosa i pretesti non mancano mai. Si sospetta addirittura che faccia venire la lebbra, come la patata! La particolarità però sta nel fatto che questa diffidenza per il topinambur nasce dopo una prima fase di entusiasmo, e non nella fase in cui è ancora una novità…
Quando compare la patata, il topinambur è dunque già ampiamente detronizzato. Viene utilizzato come pianta da foraggio, e in alcune zone della Normandia diventa addirittura mangime per i maiali, come testimonia l’Annuario di Falaise (nel Calvados) del 1830. Ci vorrà la Seconda guerra mondiale perché si riscopra il fascino del topinambur, inseparabile dalla cicciottella rutabaga: gli Stanlio e Ollio dell’Occupazione. Estremamente produttivi, permetteranno di scampare alla penuria di patate dovuta alle gelate, alle pessime condizioni delle strade, ai problemi dei trasporti legati al razionamento del carburante e alle razzie di quelli che venivano denominati doryphores.
Nel febbraio del 1942, tuttavia, il topinambur non è ancora comparso sui mercati, perché i contadini lo tengono per il bestiame, speculando su un rialzo dei prezzi. «I consumatori che li disprezzavano lo scorso inverno, oggi sarebbero felici di averli!» osserva con cinismo il rapporto di un prefetto.
Bene o male, il topinambur sostituisce la patata, una bella rivincita.
Nella regione di Hérault le sue virtù “carminative” (da carminare, ripulire) fanno sì che venga definito, come la rutabaga, “pétain”. La miseria non impedisce il senso dell’umorismo. Ecco spiegati forse i cinquant’anni che ci sono voluti perché il topinambur si liberasse della metafora. Durante la guerra si erano mangiati troppi topinambur e rutabaghe. Ricominciare a farlo è fuori discussione.
Insomma, una nuova eclissi.
Ci è voluto mezzo secolo perché, sulla scia delle “verdure dimenticate”, diventate dapprima “antiche”, poi “vintage” – e molto molto chic – si ritrovasse il topinambur. Da qualche anno compare nei menu dei grandi chef: con il foie gras, con tartufi freschi o in accompagnamento al salmerino alpino. Bisogna assolutamente dimenticare che era cibo per i maiali! E oggi lo troviamo un po’ ovunque.
© 2017 add editore s.r.l., Torino



