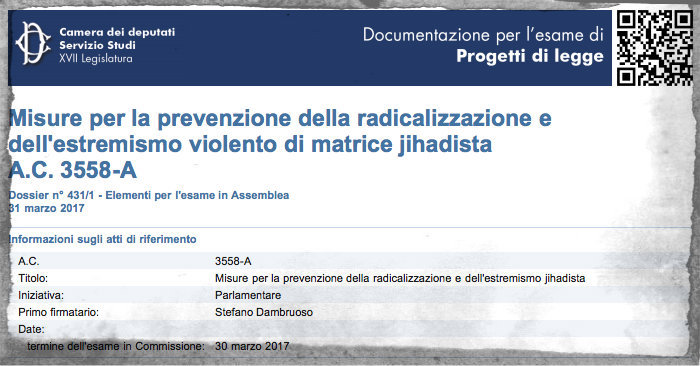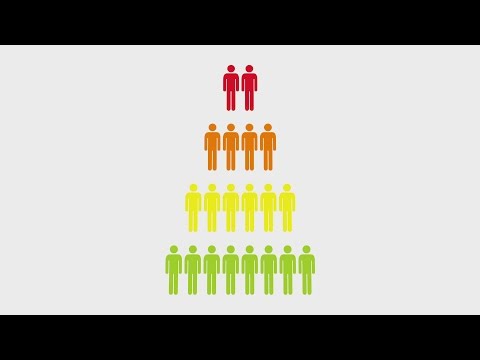Come si trova un terrorista prima che lo diventi?
La polizia non basta e ci sono programmi che hanno dato buoni risultati in altri paesi: cosa prevede la proposta di legge italiana per prevenire la radicalizzazione jihadista
di Elena Zacchetti – @elenazacchetti

Habib Hussein era il più giovane degli attentatori suicidi che parteciparono agli attacchi di Londra il 7 luglio 2005. Dopo gli attentati la polizia indagò sul suo conto e raccolse tutto ciò che era noto su di lui, accorgendosi che in nessun punto della sua giovane vita si era fatto notare dalla polizia per alcun motivo, e che pertanto non c’era mai stata alcuna possibilità di intervenire per evitare quello che è successo dopo. Tuttavia, ha raccontato Charles Farr, direttore generale dell’Ufficio per la Sicurezza e Antiterrorismo del Regno Unito, la polizia scoprì che, mentre era uno studente modello in un liceo di Leeds, i suoi quaderni erano pieni di scritte a favore di al Qaida. Dice Farr: «Scrivere sul proprio quaderno non è un atto criminale e non balzerebbe all’attenzione della polizia. Ma la filosofia dietro Prevent [il programma britannico di prevenzione della radicalizzazione] è, a mio parere, [chiedersi] se qualcuno all’interno della società avrebbe dovuto pensare che era opportuno intervenire. Cosa intendo per intervenire? Non intendo irrompergli in casa alle sei del mattino e trascinarlo davanti a un giudice. Ma voglio dire, non ci sarebbe dovuto essere qualcuno con cui potesse confrontarsi?»
Sono proprio questi i casi che da qualche anno diversi paesi europei hanno scelto di trattare con metodi innovativi, lontani dalle tradizionali misure di polizia, di solito descritti con l’espressione “programmi di prevenzione della radicalizzazione jihadista e di de-radicalizzazione”.
In Italia a metà luglio la Camera ha approvato una proposta di legge sulla prevenzione della radicalizzazione jihadista, una delle misure più importanti – almeno sulla carta – per frenare la diffusione di questo tipo di estremismo. Il testo è stato approvato con 251 voti favorevoli, 13 astenuti e 109 contrari (tra i contrari ci sono stati Movimento 5 Stelle, Lega Nord e Forza Italia), ma deve ancora essere discusso e votato dal Senato: quando, non si sa. La proposta di legge, diventata ancora più attuale dopo gli attentati compiuti in Catalogna, prevede l’introduzione di una serie di misure per prevenire la radicalizzazione jihadista, un fenomeno che finora l’Italia è riuscita ad arginare con efficacia, per motivi non solo legati all’azione del suo antiterrorismo; prevede anche delle misure per la de-radicalizzazione di persone che si sono già avvicinate all’ideologia jihadista: per esempio include un piano nazionale da applicare nelle carceri, uno dei luoghi dove negli ultimi anni si sono registrati più casi di radicalizzazione.
Leggi di questo tipo sono già state approvate da altri paesi europei, soprattutto da quelli colpiti più volte da attentati dello Stato Islamico (o ISIS), come la Francia. L’idea che sta alla base di questi programmi è che la sola azione della polizia e dell’antiterrorismo non bastino per prevenire gli attentati: di per sé “radicalizzarsi” o simpatizzare per un’ideologia estremista non è reato, a meno che non si studi o non ci si addestri per compiere attacchi violenti: è proprio in questa zona grigia che vorrebbe agire la proposta di legge, ha spiegato al Post uno dei suoi promotori, il deputato del PD Andrea Manciulli.
Per molti l’approvazione del testo alla Camera è una buona notizia, visto che negli ultimi anni l’Italia ha affrontato il problema dell’estremismo jihadista esclusivamente con misure di polizia, come le espulsioni amministrative, rimanendo però molto indietro sullo sviluppo di programmi di prevenzione e de-radicalizzazione. Non tutti sono d’accordo, comunque, e l’efficacia della legge – se e quando la proposta sarà approvata anche in Senato – dipenderà in larga parte da come verranno applicate le sue disposizioni.
Cosa prevede la proposta di legge
Come prima cosa, prevede l’istituzione del Centro Nazionale sulla Radicalizzazione (CRAD), cioè un organo che dovrà elaborare ogni anno una strategia per prevenire la radicalizzazione jihadista e intervenire nei casi di persone già radicalizzate. Il CRAD verrebbe istituito all’interno del dipartimento delle Libertà civili e dell’immigrazione del ministero degli Interni: questo è un punto importante, perché una parte delle critiche fatte alla proposta di legge è legata proprio agli eccessivi poteri che il testo darebbe al ministero degli Interni, oggi guidato da Marco Minniti. La strategia elaborata ogni anno dal CRAD, chiamata Piano Strategico Nazionale, dovrebbe definire i progetti e le iniziative da realizzare e verrebbe attuato dai Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione (CCR), organi istituiti presso le prefetture dei capoluoghi di regione. Non è finita.
La proposta di legge stabilisce anche la nascita di un Comitato parlamentare per il monitoraggio della radicalizzazione e dell’estremismo jihadista, composto da cinque senatori e cinque deputati: il comitato, che alcune forze di opposizione considerano solo un altro modo per creare-più-poltrone, dovrebbe monitorare in particolare la radicalizzazione nelle scuole e nelle carceri, e sarebbe incaricato di presentare dei rapporti periodici al Parlamento e al governo.
Nel testo vengono previste poi altre cose: per esempio corsi di formazione specialistica, sia per la conoscenza di lingue straniere che in materia di dialogo interreligioso rivolti a polizia, forze armate e guardie penitenziarie. Vengono stanziati dei fondi da usare nelle scuole per la formazione di docenti e studenti, e altri fondi per sostenere progetti universitari e post-universitari su questi temi. Il testo prevede anche l’adozione di un piano nazionale per la rieducazione e la deradicalizzazione dei detenuti, che dovrebbe essere elaborato dal ministero della Giustizia in coerenza con il Piano strategico del CRAD.
I programmi europei e il ritardo italiano
I primi a sperimentare programmi di prevenzione della radicalizzazione e di de-radicalizzazione sono stati alcuni paesi a maggioranza islamica, che da sempre sono i principali obiettivi dei gruppi jihadisti; per esempio uno dei programmi più studiati è stato quello dell’Arabia Saudita, che prevede il soggiorno di persone radicalizzate in centri di riabilitazione di lusso. In Europa i pionieri in questo campo sono stati Regno Unito, Paesi Bassi e Danimarca, seguiti rapidamente da diversi altri stati.
Non è facile spiegare con un unico modello il funzionamento di questi programmi, anche perché, come ha scritto Lorenzo Vidino in un articolo pubblicato sul sito di Oasis, un centro di ricerca specializzato nei rapporti tra cristiani e musulmani nel mondo, «le modalità di questo tipo di interventi variano da paese a paese ma anche da città a città: sono spesso parte di una strategia nazionale ma adattati alle esigenze locali». Amsterdam, spiega Vidino, si è dimostrata una città all’avanguardia: è stata creata un’apposita unità, chiamata “Information House”, all’interno del comune. In Danimarca invece i programmi sulla radicalizzazione si appoggiano spesso a una struttura già esistente, chiamata SSP (Social Services, Schools, Police). Anche il tipo di legame tra programmi e antiterrorismo cambia da paese a paese. Nel Regno Unito, per esempio, le strutture che si occupano di radicalizzazione includono agenti di polizia con esperienze nell’antiterrorismo, mentre in Danimarca e nei Paesi Bassi no.
Il primo di sei video dell’European Forum for Urban Security (Efua) che spiegano cosa si intende per radicalizzazione e de-radicalizzazione, e come dovrebbero essere sviluppati i relativi programmi governativi. I video sono sottotitolati in italiano
Nonostante in molte cose siano diversi, tutti questi programmi hanno un obiettivo comune: sono stati pensati per intervenire in quegli spazi dove la polizia non può agire, ma dai quali potrebbero comunque emergere comportamenti violenti. Su questo genere di programmi, l’Italia è rimasta molto indietro. I provvedimenti presi dal governo e dal Parlamento negli ultimi anni hanno riguardato esclusivamente l’aumento dei poteri della polizia e dell’antiterrorismo e l’introduzione di nuovi reati nel codice penale, per esempio quello che riguarda i cosiddetti “foreign fighters” e i “lupi solitari“, ma finora non sono stati affiancati da programmi di tipo diverso. Ci sono almeno due motivi che spiegano questo ritardo. Il primo dipende dalle lungaggini dei lavori parlamentari. Tra l’inizio della discussione della proposta di legge e la sua approvazione alla Camera, a metà del luglio scorso, sono passati più di due anni, e non è detto che la votazione al Senato avverrà in tempi brevi: siamo a fine legislatura – le elezioni politiche sono previste entro marzo 2018 – e la discussione della proposta di legge potrebbe essere rimandata e ancora rimandata.
Il secondo motivo è invece legato al tipo di jihadismo che si è visto finora in Italia. Dopo gli attentati in Catalogna del 17 e 18 agosto, l’Italia è rimasta l’unico grande paese dell’Europa occidentale a non avere subìto attentati terroristici rivendicati dallo Stato Islamico (o ISIS). Le ragioni sono diverse e sono oggetto di dibattito da tempo: rispetto ad altri paesi europei l’Italia ha una comunità di immigrati musulmani di seconda e terza generazione – quelli più influenzabili dalla propaganda dello Stato Islamico – molto ridotta, perché l’immigrazione dai paesi a maggioranza musulmana è un fenomeno piuttosto recente; gli italiani che sono andati a combattere in Siria e in Iraq sono qualche decina, un numero notevolmente più basso di quello registrato in paesi come per esempio Francia e Belgio, dove si parla di migliaia di persone; i “foreign fighters” italiani tornati dalla Siria e dall’Iraq, inoltre, sono molti meno rispetto alle decine, a volte centinaia, che le polizie di altri paesi europei si sono ritrovati a dover controllare e sorvegliare.
Tutte queste cose potrebbero avere convinto qualcuno che l’Italia sia in qualche modo immune al terrorismo jihadista e che quindi non avrebbe bisogno di investire tempo e risorse per i programmi di prevenzione della radicalizzazione jihadista e di de-radicalizzazione: ma non è così.
Negli ultimi anni la polizia italiana ha arrestato diverse persone per reati legati al terrorismo, alcune delle quali stavano preparando un attacco, e anche le comunità di immigrati musulmani di seconda e terza generazione stanno crescendo e diventando più numerose. L’Italia, oltre a essere da tempo obiettivo della propaganda violenta dello Stato Islamico, è stata anche coinvolta in via trasversale in alcuni dei più recenti attentati in Europa: Anis Amri, l’uomo che lo scorso dicembre investì la folla a un mercatino di Natale a Berlino, aveva cominciato a radicalizzarsi nelle prigioni siciliane ed era tornato in Italia dopo l’attacco, ucciso dalla polizia italiana a Sesto San Giovanni (Milano); uno dei tre componenti della cellula terroristica che colpì a Londra il 3 giugno scorso, Youssef Zaghba, era nato da madre italiana convertita all’Islam e da padre marocchino (aveva la doppia cittadinanza): nel marzo 2016 era stato fermato all’aeroporto di Bologna mentre tentava di raggiungere la Turchia e da lì, presumibilmente, la Siria.
 Youssef Zaghba, il 22enne italo marocchino ucciso insieme agli altri due suoi complici dopo l’attentato di giugno al London Bridge
Youssef Zaghba, il 22enne italo marocchino ucciso insieme agli altri due suoi complici dopo l’attentato di giugno al London Bridge
In altre parole: il fatto che finora sia andata bene non significa che il problema della radicalizzazione jihadista vada sottovalutato.
Sì, ma questi programmi sulla radicalizzazione sono efficaci?
Non c’è una risposta univoca a questa domanda. Manciulli, deputato del PD promotore della legge insieme a Stefano Dambruoso (Scelta Civica), ha sintetizzato così la questione: «La cosa veramente contrastante è l’efficacia dei percorsi di rieducazione, mentre l’individuazione di “devianze” funziona bene». Ci sono alcune cose da dire al riguardo.
Un tipo di programma di prevenzione della radicalizzazione che provoca sempre meno entusiasmi tra gli esperti di antiterrorismo è quello concentrato sul dialogo interreligioso, su vari incontri interculturali e corsi di integrazione: cioè sul tipo di programma a cui si pensa quando si parla di prevenzione della radicalizzazione jihadista. Come ha spiegato Vidino, ci sono sempre più studi che – contraddicendo il credere comune – hanno mostrato «come il legame causale tra la mancanza di integrazione e la radicalizzazione sia nella maggior parte dei casi tenue se non inesistente». Questo significa che non è vero che i paesi con una peggiore integrazione delle comunità musulmane siano anche quelli dove vengono compiuti più attentati terroristici (PDF): l’Italia è molto indietro nei processi di integrazione, ma finora non ha subìto nemmeno un attentato. Questo tipo di programmi, quindi, può favorire l’integrazione e può avere effetti positivi indiretti sulla prevenzione della radicalizzazione, scrive Vidino, ma va tenuto separato da una strategia di antiterrorismo.
Un discorso diverso invece va fatto per quei programmi che agiscono su persone già radicalizzate o che hanno mostrato i primi segni di radicalizzazione, come nel caso di Hasib Hussein, l’attentatore di Londra. Qui c’è più entusiasmo per due ragioni: perché la loro efficacia è più facilmente dimostrabile, e quindi è anche più immediato provare che un investimento di denaro pubblico abbia prodotto risultati; e perché costano meno rispetto ai tipi di programmi di prevenzione citati sopra. Si parla comunque di processi molto lunghi, che durano anche degli anni, e che si basano sulla capacità del personale specializzato di stabilire un rapporto di fiducia con la persona radicalizzata. Vidino ha raccontato per esempio la storia di una persona, il cui nome non è stato diffuso per ragioni di privacy, che si è de-radicalizzata grazie all’azione dell’Information House, l’organo istituito ad Amsterdam per svolgere questo tipo di lavoro.
Questa persona, che chiameremo X, era un membro del gruppo “Hofstad”, una rete di miliziani jihadisti nata nei primi anni 2000 tra Amsterdam e L’Aia al quale apparteneva anche l’assassino del regista Theo van Gogh. Dopo essere stato detenuto per tre anni per crimini legati al terrorismo, X fu rilasciato e l’Information House gli assegnò un assistente sociale per iniziare il processo di de-radicalizzazione. L’assistente sociale aiutò X a trovare una casa e a sistemare altre questioni logistiche: tra i due si instaurò un rapporto di fiducia ma a un certo punto l’assistente sociale, anch’egli musulmano, capì di non avere le competenze sull’Islam sufficienti per ribattere agli argomenti di X, persona molto intelligente e istruita. L’Information House decise allora di far intervenire un esperto di scienze religiose islamiche: il primo incontro finì con X che se ne andò sbattendo la porta. Poi però le cose migliorarono, il rapporto tra l’esperto e X diventò pian piano più profondo e durò quasi tre anni.
«L’assiduità delle conversazioni fu un fattore importante nella traiettoria di X, ma non meno di alcuni momenti chiave. Uno si verificò alla Mecca, dove X e il sapiente si recarono per un pellegrinaggio. X, che aveva sempre avuto forti sentimenti anti-sciiti, fu molto toccato dal fatto che l’unica persona che lo aiutò quando cadde e stava per essere calpestato dalla calca fu proprio uno sciita. Questo incidente, occorso al culmine di un lavoro certosino incentrato sul dialogo, contribuì fortemente al cambio di prospettiva di X. X, infatti, progressivamente abbandonò le vecchie amicizie, si sposò, continuò gli studi e, cosa più importante, abbandonò l’ideologia jihadista. Iniziò persino a collaborare con l’Information House, raccontando la propria storia in vari seminari.»
Non è possibile sapere cosa sarebbe successo a X se non avesse partecipato al programma dell’Information House; il suo caso, comunque, viene considerato come un esempio di successo, così come diversi altri già completati nei paesi europei dotati di leggi di questo tipo.
La de-radicalizzazione nelle carceri
Il discorso sulla prevenzione e de-radicalizzazione nelle carceri va fatto a parte. La proposta di legge approvata alla Camera dedica l’articolo 11 alla formulazione di un «piano nazionale per la rieducazione e la de-radicalizzazione di detenuti e di internati», che dovrà essere adottato dal ministero della Giustizia. Non si sa quindi cosa potrebbe essere deciso nel piano, ma intanto vale la pena dire un paio di cose.
Primo: il fenomeno della radicalizzazione jihadista nelle carceri è molto serio. Due dei tre terroristi che attaccarono la redazione del settimanale Charlie Hebdo si erano radicalizzati in una prigione francese; Abdelhamid Abaaoud, considerato uno degli organizzatori degli attentati di Parigi del novembre 2015, si era radicalizzato in un carcere belga; la stessa cosa era successa a uno degli attentatori suicidi dell’aeroporto di Bruxelles, nel marzo 2016, e al già citato Anis Amri, l’attentatore di Berlino che cominciò ad avvicinarsi all’ideologia jihadista nelle prigioni siciliane. Di casi simili se ne potrebbero citare ancora.
Secondo: è difficile dire con precisione i motivi che spingono una persona a radicalizzarsi in carcere, ma qualche ipotesi si può fare. Uno dei fattori sembra essere la scarsa comprensione tra detenuti e personale penitenziario, ha spiegato il sociologo Bartolomeo Conti in un articolo pubblicato sul sito di Oasis nel gennaio di quest’anno. Conti ha scritto che può capitare che le guardie carcerarie finiscano per vedere la radicalizzazione anche là dove non c’è, quando la radicalizzazione viene «confusa con la pratica religiosa ortodossa/fondamentalista, il discorso politico o la “semplice” provocazione verso l’istituzione penitenziaria». Queste incomprensioni possono aumentare il livello di stigmatizzazione dei detenuti di religione islamica, che si sentono “ingiustamente discriminati”, fattore questo che potrebbe essere fonte di radicalizzazione. Spesso la radicalizzazione in carcere è favorita da persone carismatiche che propagandano idee jihadiste, e che finiscono per influenzare altri detenuti musulmani la cui conoscenza dell’Islam è invece molto limitata.
Terzo: il problema della radicalizzazione dei detenuti esiste anche nelle carceri italiane, come ha dimostrato il caso di Anis Amri. Lo scorso 11 gennaio il ministro della Giustizia italiano, Andrea Orlando, ha risposto a un’interrogazione parlamentare riportando i dati dell’amministrazione penitenziaria (DAP) riguardo la radicalizzazione nelle carceri italiane (che comunque è un problema di cui si discute da molti anni). Orlando ha detto che secondo i dati del DAP, i detenuti sottoposti a specifico “monitoraggio” sono 170, a cui si devono aggiungere 80 “attenzionati” e 125 “segnalati”, per un totale di 375 individui radicalizzati. Come ha segnalato sul sito di Open Migration Patrizio Gonnella, presidente dell’associazione Antigone, non è chiaro quali criteri siano stati usati per inserire i detenuti in queste tre categorie ed è quindi difficile valutare la gravità della situazione: il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria non ha risposto a una richiesta di chiarimenti da parte del Post.
 Ci sono poi i detenuti per reati legati al terrorismo internazionale: sono 45, ha detto Orlando, e si trovano nelle sezioni di alta sicurezza delle carceri di Benevento (Campania), Brindisi e Lecce (Puglia), Nuoro e Sassari (Sardegna), Tolmezzo (Friuli-Venezia Giulia), Torino (Piemonte), Roma Rebibbia (Lazio) e Rossano (Calabria): la loro distribuzione è mostrata dall’infografica qui a lato, realizzata da Open Migration usando i dati del DAP. Non sono numeri esagerati – certamente ben lontani da quelli di altri paesi europei – ma sono comunque numeri da non sottovalutare. Il governo italiano ha già cominciato a lavorare sulla prevenzione della radicalizzazione nelle carceri. Un progetto interessante, che potrebbe essere esteso se la proposta di legge diventerà legge, è quello che coinvolge l’UCOII, l’Unione delle comunità islamiche d’Italia, la più grande organizzazione islamica italiana. Da tempo l’UCOII collabora con il ministero della Giustizia affinché sia possibile far entrare nelle carceri degli imam cosiddetti “certificati”, ovvero gli imam dell’organizzazione, i quali non adottano una visione estremista dell’Islam. Una portavoce dell’UCOII ha detto al Post che gli stessi imam sono di grande aiuto alla polizia penitenziaria: sia perché parlano arabo, a differenza delle guardie carcerarie, sia perché sono disposti a collaborare con la polizia nel caso in cui ci siano detenuti che provano a diffondere una visione estremista dell’Islam. Ma anche questa proposta, così come molte altre contenute nella proposta di legge, è stata criticata da alcuni partiti di opposizione durante la discussione in Parlamento.
Ci sono poi i detenuti per reati legati al terrorismo internazionale: sono 45, ha detto Orlando, e si trovano nelle sezioni di alta sicurezza delle carceri di Benevento (Campania), Brindisi e Lecce (Puglia), Nuoro e Sassari (Sardegna), Tolmezzo (Friuli-Venezia Giulia), Torino (Piemonte), Roma Rebibbia (Lazio) e Rossano (Calabria): la loro distribuzione è mostrata dall’infografica qui a lato, realizzata da Open Migration usando i dati del DAP. Non sono numeri esagerati – certamente ben lontani da quelli di altri paesi europei – ma sono comunque numeri da non sottovalutare. Il governo italiano ha già cominciato a lavorare sulla prevenzione della radicalizzazione nelle carceri. Un progetto interessante, che potrebbe essere esteso se la proposta di legge diventerà legge, è quello che coinvolge l’UCOII, l’Unione delle comunità islamiche d’Italia, la più grande organizzazione islamica italiana. Da tempo l’UCOII collabora con il ministero della Giustizia affinché sia possibile far entrare nelle carceri degli imam cosiddetti “certificati”, ovvero gli imam dell’organizzazione, i quali non adottano una visione estremista dell’Islam. Una portavoce dell’UCOII ha detto al Post che gli stessi imam sono di grande aiuto alla polizia penitenziaria: sia perché parlano arabo, a differenza delle guardie carcerarie, sia perché sono disposti a collaborare con la polizia nel caso in cui ci siano detenuti che provano a diffondere una visione estremista dell’Islam. Ma anche questa proposta, così come molte altre contenute nella proposta di legge, è stata criticata da alcuni partiti di opposizione durante la discussione in Parlamento.
Le altre critiche alla proposta di legge
La proposta di legge approvata dalla Camera a luglio, come detto, non è ancora definitiva, visto che deve ancora passare all’esame del Senato, e prevede che molte procedure vengano stabilite in un secondo momento. È quindi difficile, se non impossibile, criticare nel merito i programmi che verranno adottati, ma è possibile fare valutazione sull’impianto generale della legge.
Partiamo da quelli che hanno votato contro. Forza Italia e Lega Nord hanno criticato tra le altre cose il fatto che la parola “moschea” non sia stata citata nemmeno una volta nella proposta di legge. Francesco Paolo Sisto, deputato di Forza Italia, ha definito le moschee «il luogo più amato del jihadismo», ma questo non è rilevato da alcun esperto e studioso di terrorismo islamista: i due principali luoghi di reclutamento dello Stato Islamico, il gruppo che ha compiuto la stragrande maggioranza degli attentati in Europa negli ultimi due anni e mezzo, sono Internet e le carceri. La parola moschea compare una sola volta anche nell’ultima Relazione annuale presentata dall’intelligence italiana al Parlamento (PDF), quella che definisce tra le altre cose il tipo di minaccia jihadista in Italia: è usata non per indicare un possibile luogo di diffusione di ideologie estremiste, ma in riferimento all’attentato suicida compiuto dallo Stato Islamico in una moschea sciita del Kuwait, nel giugno 2015.
Un’altra critica che è stata fatta dalle opposizioni, incluso il Movimento 5 Stelle e Possibile (che non ha votato contro ma si è astenuto), è che l’impianto previsto dalla legge non avrebbe efficacia: in pratica che l’iniziativa sostenuta dalla maggioranza sarebbe solo una “legge manifesto”, una “legge bandiera”. Angelo Tofalo, deputato del M5S, ha detto al Post che «la problematica della radicalizzazione da un punto si vista parlamentare si sarebbe dovuta affrontare mediante una commissione d’inchiesta istituita con legge specifica e della durata della legislatura». Secondo Tofalo, sarebbe stato necessario e più efficace rafforzare gli strumenti di intelligence già esistenti, invece che fare «nuove “stanze dei bottoni”» come il Comitato parlamentare previsto nella proposta di legge, che non farebbero altro che «confondere un quadro istituzionale ben definito». Andrea Maestri, deputato di Possibile, ha detto al Post che uno dei problemi della proposta di legge è che dà molti poteri al ministero degli Interni, anche in quei settori nei quali dovrebbero prevalere altri soggetti, per esempio quello che dovrebbe fare il ministero dell’Istruzione per le scuole. Secondo Maestri un altro problema è che la proposta di legge si concentra sulla sola radicalizzazione jihadista, e ignora altri tipi di radicalizzazione molto diffusi nella società italiana.
L’impressione, quindi, è che ci siano forze politiche in Parlamento che non solo non condividono il modo in cui è stata fatta la legge, ma che non concordano nemmeno sulla necessità di dotarsi di programmi ad hoc per affrontare la radicalizzazione jihadista, cioè strumenti diversi da quelli di cui già dispongono le forze di sicurezza.
Nonostante sia difficile dare oggi una valutazione su come sarà la legge, perché dipenderà molto da come verrà applicata, sembra altrettanto difficile ignorare l’importanza per l’Italia di dotarsi di strumenti di prevenzione della radicalizzazione e di de-radicalizzazione: sia perché lo hanno già fatto molti altri paesi europei già colpiti da attentati terroristici, che sono più esperti di noi nel combattere lo jihadismo, sia perché l’azione delle sole forze di sicurezza potrebbe non essere più sufficiente. Non è solo una questione numerica di uomini, ma anche una valutazione sul diverso tipo di lavoro che la prevenzione e la de-radicalizzazione possono fare: un lavoro in zone dove la polizia non può intervenire.