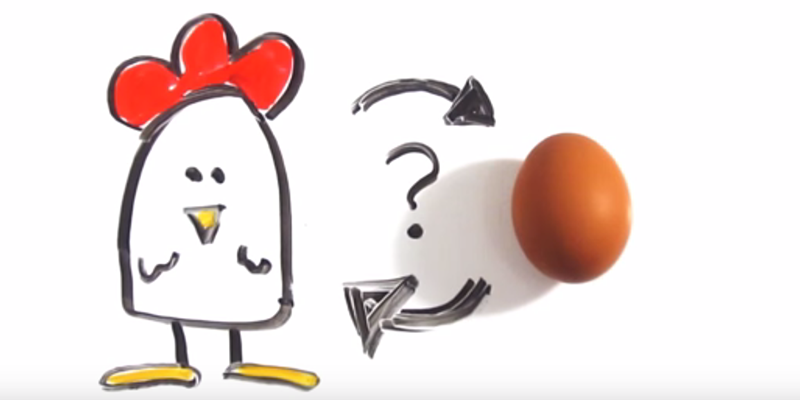L’uomo con le manette
Perché si parla di nuovo di Marwan Barghouti, uno dei più popolari e ambiziosi politici palestinesi, ma che ha alle spalle un passato pesante

Nelle manifestazioni di protesta che si tengono di frequente in Palestina contro l’occupazione israeliana, accanto ai colori della bandiera palestinese e al profilo familiare di Yasser Arafat, c’è una terza immagine che compare spesso. Mostra un uomo di mezza età con le mani ammanettate ma alzate sopra la testa, in segno di vittoria. La si trova ovunque: poster, striscioni, volantini, cartelloni. Qualcuno l’ha anche disegnata su un tratto del muro che separa gli insediamenti israeliani a nord di Gerusalemme con Ramallah, la capitale amministrativa dello stato palestinese.
 (ABBAS MOMANI/AFP/GettyImages)
(ABBAS MOMANI/AFP/GettyImages)
L’uomo dell’immagine è Marwan Barghouti, uno dei più popolari leader politici in Palestina, da anni considerato il successore naturale dell’attuale presidente palestinese Mahmoud Abbas. Barghouti è un parlamentare di Fatah, il partito laico e moderato di Arafat e Abbas, ma è gradito anche ad Hamas, il popolare movimento politico-terrorista palestinese; ha una credibilità e un consenso “vero” fra i palestinesi, attestato da diversi sondaggi, e contatti con i politici arabi che siedono nel parlamento israeliano. Ha passato la sua vita fra Palestina, Tunisia e Giordania ma ha anche una certa notorietà internazionale. Legge molti libri e oltre all’arabo conosce l’inglese e l’ebraico. Negli ultimi anni predica la non-violenza come strumento principale per l’emancipazione dei palestinesi: per questo impegno alcuni dei suoi sostenitori lo hanno definito il Nelson Mandela palestinese.
Il suo problema, condiviso anche con altri leader palestinesi, è un passato legato alla lotta armata. Nel caso di Barghouti, in particolare, le accuse sono molto pesanti: nel 2004 un tribunale israeliano lo ha condannato a cinque ergastoli per terrorismo dopo un processo ritenuto piuttosto controverso. Per questo motivo Barghouti è in carcere: i disegni che compaiono su manifesti e striscioni sono spesso tratti dalle foto scattate nel primo giorno del suo processo, il 14 agosto 2002, in una delle sue rarissime apparizioni in pubblico negli ultimi 15 anni. Da allora periodicamente il suo nome torna sui giornali internazionali, solitamente grazie alle iniziative del comitato per la sua liberazione, guidato da sua moglie e appoggiato da diverse importanti personalità internazionali (come l’ex presidente americano Jimmy Carter).
 (AP Photo/Brennan Linsley)
(AP Photo/Brennan Linsley)
Negli ultimi giorni si è riparlato della condizione di Barghouti per via di un articolo che ha scritto ed è stato pubblicato domenica 16 aprile nella sezione op-ed del New York Times, che ospita interventi di persone esterne alla redazione. Già in passato Barghouti ha scritto articoli simili per grandi giornali internazionali. Nell’articolo per il New York Times, Barghouti ha spiegato le ragioni di un nuovo sciopero della fame appoggiato da duemila detenuti palestinesi nelle carceri israeliane, per chiedere un trattamento migliore.
La questione nasce dal fatto che nella breve biografia allegata dal New York Times all’articolo non c’è traccia delle condanne ricevute e delle accuse di terrorismo: c’è scritto solamente “Marwan Barghouti è un leader e parlamentare palestinese”. In molti si sono arrabbiati per il fatto che non ci fosse nemmeno un accenno alle sue condanne. Daniel Shapiro, l’ex ambasciatore americano in Israele dell’amministrazione di Barack Obama, ha scritto che il New York Times «ha sbagliato». Diversi lettori hanno scritto alla public editor del giornale, Liz Spayd, che a sua volta è intervenuta sulla questione con un duro articolo intitolato “L’autore di un op-ed nasconde i propri crimini, e il New York Times lo imita”.
It's debatable if Marwan Barghouti has a political future. Pals & Israelis debate it. But NYT was wrong not cite his terrorism conviction.
— Dan Shapiro (@DanielBShapiro) April 17, 2017
Dal punto di vista giornalistico il caso si è chiuso con l’aggiunta di una nota in fondo all’articolo, ma rimane esemplare di una certa ambiguità dimostrata da Barghouti nel corso della sua carriera politica, e che alimenta il dibattito sulla sua possibile leadership in futuro.
«Una delle figure più moderate»
Barghouti è nato nel 1959 a Kaubar, un piccolo paese della Cisgiordania a nord di Ramallah. Come racconta un lungo articolo pubblicato da Haaretz nel luglio 2016, Barghouti finì nei guai molto presto, come moltissimi altri giovani palestinesi in quegli anni: fu arrestato per la prima volta a 15 anni per aver partecipato a una manifestazione contro l’occupazione israeliana. Quattro anni dopo fu condannato a cinque anni di carcere per la sua appartenenza a un ramo militante di Fatah, che non aveva ancora abbandonato la lotta armata. Barghouti finì il liceo in carcere, e poco dopo essere stato rilasciato sposò la sua attuale moglie, Fadwa. «Il loro matrimonio fu rinviato più volte per via dei frequenti interrogatori e arresti che subiva Barghouti», racconta Haaretz.
Barghouti si iscrisse a Scienze politiche all’università di Bir Zeit, in Cisgiordania, e divenne un importante leader studentesco. Per questa ragione nel 1987 fu deportato in Giordania assieme ad altri leader universitari: era un tentativo delle autorità israeliane di contenere le agitazioni che sarebbero scaturite nella prima “Intifada“, la rivolta popolare palestinese contro l’occupazione israeliana. Negli anni compresi fra la prima Intifada e gli accordi di pace di Oslo (1993), Barghouti fu molto attivo in Fatah e viaggiò spesso fra la Giordania e la Tunisia, dove vivevano in esilio molti dirigenti palestinesi della cerchia di Arafat.
Le persone che furono in contatto con Barghouti nei primi anni Novanta lo descrissero come entusiasta del processo di pace: Haim Ramon, un rispettato politico israeliano che dal 1992 al 2009 ricoprì diverse cariche di governo, ha detto che in quel periodo si incontrava con Barghouti ogni settimana a Tel Aviv. «Era una delle figure più moderate nell’entità statale palestinese. Mi disse che un accordo era possibile, anche sulla questione dei rifugiati palestinesi», ha ricordato anni più tardi Ramon. Lo stesso Barghouti nel 1994, un anno dopo gli accordi di Oslo, annunciò che la resistenza armata «non è più un’opzione» per l’emancipazione palestinese.
Gli accordi di Oslo, che dovevano essere temporanei, non sono mai stati seguiti da un trattato definitivo. Il 4 novembre 1995 un estremista ebreo uccise il primo ministro israeliano Yitzhak Rabin, uno dei principali promotori del processo di pace. L’anno successivo le elezioni politiche in Israele furono vinte da Benjamin Netanyahu, che sosteneva politiche molto più intransigenti con i palestinesi. Il processo di pace si interruppe definitivamente nel 2000, quando fallirono i cosiddetti negoziati di Camp David, mediati dall’allora presidente americano Bill Clinton. Barghouti allora cambiò idea, appoggiando il ritorno alla resistenza armata. In un’intervista data nel 2001 al giornalista israeliano Ben Kaspit, spiegò:
«Come vi sentireste se nuovi insediamenti sorgessero su ogni collina che vi appartiene? Se i vostri migliori amici, con cui avete combattuto spalla a spalla, continuassero a marcire in galera? Ho capito una cosa semplice. Voi [israeliani] non volete interrompere l’occupazione e fermare l’espansione degli insediamenti, quindi l’unico modo per convincervi a farlo è con la forza. Questa è l’Intifada della pace»
Gli anni di Tanzim
La seconda Intifada era iniziata nel settembre 2000, in seguito alla provocatoria passeggiata del leader politico israeliano Ariel Sharon alla Spianata delle Moschee di Gerusalemme, a cui di solito hanno accesso solamente i fedeli musulmani. «Durante la prima settimana della nuova Intifada», ha raccontato ad Haaretz l’ex capo dell’agenzia di intelligence interna Ami Avalon, «Barghouti e i suoi collaboratori furono sorpresi come tutti. In seguito, Barghouti iniziò ad occuparsi dell’organizzazione e della logica politica. Divenne il braccio destro di Arafat: credeva che l’Intifada fosse il mezzo per raggiungere l’obiettivo della soluzione dei due stati».
Barghouti ci arrivò preparato: alla fine degli anni Novanta aveva preso il controllo di Tanzim, una branca armata di Fatah che aveva l’obiettivo di combattere l’occupazione israeliana. L’attività di Tanzim si sovrappose spesso con quella della Brigata dei Martiri di al Aqsa, un gruppo armato considerato una loro sotto-branca che rivendicò diversi attacchi terroristici sia in Israele sia in Palestina fra il 2001 e il 2002: qui c’è un elenco degli attentati compiuti in quegli anni da Tanzim e dalla Brigata di al Aqsa, contenuto nel libro Chronologies of Modern Terrorism dello studioso israelo-americano Barry Rubin. Spesso furono aggressioni a israeliani civili o militari, nei pressi di colonie israeliane situate in territorio palestinese.
Anni dopo Barghouti si è assunto la responsabilità degli attacchi avvenuti in Cisgiordania, ma ha negato di avere appoggiato gli attacchi suicidi che si intensificarono soprattutto nel 2002 (in un paper del 2006, lo studioso israeliano Eitan Alimi ha calcolato che in quell’anno Tanzim organizzò più attentati suicidi di tutte le altre fazioni armate, a volte in collaborazione con gli islamisti di Hamas e Jihad Islamico Palestinese). Tanzim e la Brigata di al Aqsa, benché coinvolti nella lotta organizzata dell’Intifada, rappresentavano gli interessi dei membri più giovani di Fatah, gli stessi che anni prima avevano organizzato la prima Intifada; leali ad Arafat e al suo gruppo di intellettuali e collaboratori ma più impegnati di loro “sul campo”. Danny Rubenstein, un ex giornalista di Haaretz che in passato era legato a Barghouti, ha spiegato che «Tanzim era una milizia civile fedele a lui, che a sua volta era il principale oppositore del gruppo di Tunisi [gli intellettuali vicini ad Arafat e Abbas]. La sua carta politica era proprio quella, e in origine doveva condurlo alla leadership dopo Arafat».
Barghouti fu arrestato il 15 aprile 2002, dopo che l’esercito israeliano aveva circondato la casa in cui si nascondeva a Ramallah. Pochi mesi dopo fu incriminato in un tribunale civile, accusato di aver ucciso 26 persone e contribuito ad organizzare 37 attentati.
Il suo processo attirò molte attenzioni dei media israeliani, e fu causa di grandi controversie: Barghouti rifiutò di difendersi, dato che sosteneva di essere stato deportato illegalmente in Israele, e un report commissionato dall’Inter-Parliamentary Union – un’organizzazione internazionale che collabora stabilmente con l’ONU – stabilì che c’erano state diverse irregolarità nel trattamento di Barghouti da parte delle autorità israeliane.
Nel report si legge fra le altre cose che a Barghouti fu concesso di consultare un avvocato solamente una volta nel primo mese di detenzione, e che fu portato davanti a un giudice solamente una settimana dopo il suo arresto. Durante il processo, a un certo punto, il giudice si rivolse a lui spiegandogli che «chi combatte per la pace non trasforma delle persone in bombe e ammazza dei bambini». Ci furono altre irregolarità, come le condizioni opinabili in cui fu tenuto Barghouti in quei mesi (una cella di 2,5 metri quadrati da cui poteva uscire solamente per 45 minuti al giorno). Inoltre, il report giudicò “deboli” le prove raccolte dalle autorità israeliane: dei circa 100 testimoni chiamati dall’accusa, solamente 21 erano nella posizione di testimoniare sul coinvolgimento di Barghouti negli attacchi, ma nessuno lo fece.
Non c’erano dubbi sul fatto che Barghouti avesse praticato la lotta armata: lo aveva ammesso lui stesso. Secondo gli osservatori internazionali, però, non ci sono le basi giuridiche per stabilire che il suo fu un “giusto processo” in relazione agli episodi specifici di cui era accusato. Nel 2004 Barghouti fu riconosciuto colpevole di cinque omicidi, oltre che di tentato omicidio e associazione terroristica. Il tribunale stabilì che non c’erano prove sufficienti per collegarlo alle altre 21 morti.
Dopo la condanna
Negli anni successivi alla sua condanna, la popolarità di Barghouti è rimasta stabile, nonostante le sue attività politiche abbiano rallentato. Periodicamente si torna a parlare dell’ipotesi della sua liberazione: di recente anche Hamas l’ha messa fra le sue priorità. In questi anni Barghouti ha continuato a fare politica: è stato rieletto diverse volte in absentia al parlamento palestinese, ha mantenuto i suoi contatti e fatto sapere la sua su alcune questioni più recenti (era contrario alla cosiddetta “Intifada dei coltelli” del 2015, per esempio). Anche la sua fama internazionale non ha smesso di crescere. Nel 2013 il comitato ufficiale per la sua liberazione è stato inaugurato nella celebre cella dove fu imprigionato Nelson Mandela a Robben Island, in Sudafrica.
Barghouti si presenta oggi come politicamente alternativo ad Abbas. Ha molte più credenziali di lui per proporsi come il leader che può raggiungere un compromesso con Hamas, ha un passato da attivista e militante relativamente recente e l’anno scorso ha fatto sapere ad Haaretz che per costringere Israele a nuovi negoziati appoggerebbe una protesta di massa non-violenta (un’opzione gradita ai sostenitori internazionali della causa palestinese).
Barghouti, insomma, è in un’ottima posizione per diventare il prossimo leader dei palestinesi, ma solo se dovesse riuscire a uscire dal carcere tramite un negoziato o una decisione spontanea di Israele (magari in caso di una sua elezione diretta). A giudicare dal racconto di alcuni agenti dell’intelligence israeliana che l’hanno interrogato, Barghouti aveva programmato di trovarsi in una condizione del genere da diversi anni. Scrive Haaretz:
Nelle sue lunghe conversazioni con gli agenti dello Shin Bet, ha dimostrato di essere un politico ambizioso e calcolatore. Ha preso parte alle violenze, ha spiegato, cosicché «in futuro avrebbe potuto dire di aver agito sia durante la pace sia durante la guerra, al contrario di altri leader che non si erano sporcati le mani. In questo modo avrebbe ottenuto il consenso del popolo palestinese».