Gli ultimi giorni di Primo Levi
Morì l'11 aprile di trent'anni fa, nella casa in cui era nato e in cui aveva vissuto per tutta la vita: aveva sessantasette anni
di Giacomo Papi – @giacomopapi
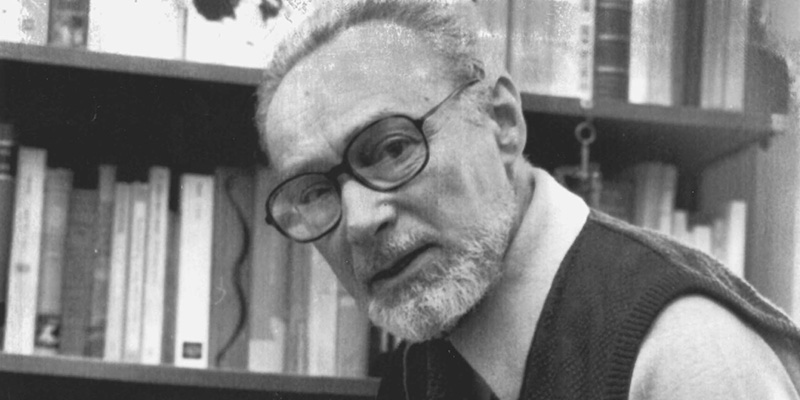
Primo Levi morì intorno alle 11.25 della mattina di sabato 11 aprile 1987. Aveva sessantasette anni. Lucia Morpurgo, sua moglie, era fuori per spese. Intorno alle 11 Iolanda Gasperi, la portinaia, salì al terzo piano come faceva tutti i giorni da dodici anni, e Primo Levi le aprì in maniche di camicia: «Il dottor Levi aveva sì l’aria stanca ma non più del solito. È stato gentile. Ha preso la posta, pochi giornali e dépliants pubblicitari, mi ha salutato con cordialità», disse a Giuseppe Josca del Corriere della sera. Una settimana prima Levi le aveva regalato, come faceva sempre, una copia del suo ultimo libro, I sommersi e i salvati, uscito nell’aprile dell’anno precedente, con la dedica: «Con amicizia e stima». Iolanda Gasperi rientrò nella portineria e pochi minuti dopo sentì un tonfo nella tromba delle scale: «C’era come un nodo di membra», riporta così la sua dichiarazione il Corriere. «Un pover’uomo giaceva schiacciato sul pavimento. Il sangue gli nascondeva la faccia. Ho guardato attorno e, Dio mio, quell’uomo l’ho subito riconosciuto, era il dottor Levi». La moglie rientrò in quel momento. Il figlio Renzo abitava nello stesso palazzo. Primo Levi era morto nella casa di corso Re Umberto 75, sette minuti a piedi dalla sede dell’Einaudi, il suo editore. Era la casa in cui era nato e in cui aveva vissuto per tutta la vita. La sua assenza più lunga era stata dal 1942 all’ottobre 1945, e la raccontò nei suoi libri: un anno a Milano in una fabbrica di medicinali, qualche mese da partigiano in Val d’Aosta, l’arresto il 13 dicembre 1943 e la deportazione nel campo di concentramento di Fossoli, vicino a Carpi, e poi ad Auschwitz, per undici mesi, infine altri nove sulla via del ritorno. In alcune interviste successive avrebbe definito il periodo di Auschwitz come l’unico «in technicolor» di una vita altrimenti in bianco e nero.
 La casa dove visse Primo Levi (Google Street)
La casa dove visse Primo Levi (Google Street)
L’8 aprile, tre giorni prima della morte, Levi aveva detto a Giulio Einaudi: «Non riesco più a scrivere». Il libro a cui stava lavorando avrebbe dovuto intitolarsi Chimica per signore o Il doppio legame, un romanzo epistolare sulla storia d’amore tra un anziano chimico e una signora sposata e con figli. Qualche mese prima Einaudi gli aveva offerto la presidenza della casa editrice, ma Primo Levi aveva rifiutato perché non se la sentiva. La moglie avrebbe confermato alla Stampa che era depresso da tempo. L’ipotesi più probabile e diffusa è che si sia suicidato, anche se periodicamente qualcuno sostiene che la caduta possa essere stata provocata dalle vertigini, di cui soffriva. L’ipotesi del suicidio fu espressa da subito. Nel 1978, ricordando sulla Stampa Jean Améry, un altro grande scrittore deportato ad Auschwitz morto suicida nel 1976, Primo Levi scrisse che nessuno, neppure il suicida, conosce le ragioni della propria morte.
Nel gennaio 1987, quattro mesi prima della caduta, era scoppiata la polemica sul revisionismo. Alcuni storici tedeschi, in particolare Ernst Nolte nel libro La guerra civile europea, 1917-1945. Nazionalsocialismo e bolscevismo, interpretavano il nazismo come una reazione al comunismo russo, e indicavano nei gulag sovietici l’ispirazione diretta dei campi di sterminio nazisti. Primo Levi era intervenuto con un articolo sulla Stampa, Buco nero ad Auschwitz: «Gli scopi dei due inferni non erano gli stessi», scrisse. «Il primo era un massacro fra uguali; non si basava su un primato razziale, non divideva l’umanità in superuomini e in sottouomini: il secondo si fondava su un’ideologia impregnata di razzismo». Nei gulag la morte era «un sottoprodotto», nei campi di sterminio lo scopo. I campi nazisti, scrive Primo Levi, «non erano una imitazione “asiatica”, erano bene europee, il gas veniva prodotto da illustri fabbriche chimiche tedesche; ed a fabbriche tedesche andavano i capelli delle donne massacrate; e alle banche tedesche l’oro dei denti estratti dai cadaveri. Tutto questo è specificamente tedesco, e nessun tedesco lo dovrebbe dimenticare».
Quanto alla vita privata, si sa che nel mese di marzo Primo Levi aveva subito un intervento alla prostata a causa del quale aveva sospeso gli antidepressivi e che era molto preoccupato per la salute della madre Ester, allora novantaduenne, che aveva avuto un ictus, e per quella di sua suocera. Ma la depressione si alimentava probabilmente anche del senso di colpa di essere sopravvissuto, un tema, quello della differenza tra i sommersi e i salvati, al centro del suo ultimo libro. «Schiacciato dal fantasma dei lager», titolò il Corriere. Nei mesi precedenti ne aveva parlato con Giovanni Tesio, uno studioso torinese che stava lavorando alla sua «biografia autorizzata». Il giorno della morte Tesio raccontò ai quotidiani che Levi gli aveva chiesto di smettere perché ricordare era troppo doloroso. Ma che poi, la sera prima, il venerdì, gli aveva telefonato per proporgli di riprendere. Disse Tesio: «Questo raccontare, questo scavare nei ricordi era un po’ diventato come una operazione psicanalitica, senza ovviamente averne le tecniche e i fini. Su certi nodi della memoria il racconto insisteva, come se scoprisse cose, situazioni mai prima rimesse in luce. Su altri si arrestava. Levi accennava qualcosa ma subito se ne ritraeva. (…) Non posso essere preciso. Non me ne sento autorizzato. Ma, ecco, posso dire che lo tormentava per esempio, il ricordo di un compagno di lager. Come se stesse addossandosi, ora, la colpa di non essere riuscito a salvarlo».
Nel 2001 un altro studioso, Giovanni Falaschi, avrebbe intuito che il compagno a cui Tesio aveva accennato era una donna, Vanda Maestro, che Primo Levi aveva conosciuto al liceo, e che come lui era ebrea torinese e laureata in chimica. Tesio confermò l’ipotesi. Vanda Maestro compare in molti libri di Primo Levi, in alcuni con il suo nome, in altri citata come «una donna che mi stava nel cuore» o evocata: «Il nome e il viso della donna che era scesa negli inferi con me e non ne era tornata». Le apparizioni di Vanda sono riepilogate in Primo Levi di fronte e di profilo di Marco Belpoliti, una monumentale enciclopedia dedicata alla figura di Levi da cui, insieme ai giornali dei giorni successivi, sono tratte molte delle notizie di questo articolo. Vanda Maestro era con Primo Levi a Milano, poi in Val d’Aosta dove erano stati arrestati e deportati insieme, prima a Fossoli, poi ad Auschwitz. Belpoliti la riconosce anche in un passaggio di Se questo è un uomo: «Accanto a me, serrata come me tra corpo e corpo, era stata per tutto il viaggio una donna. Ci conoscevamo da molti anni, e la sventura ci aveva colti insieme, ma poco sapevamo l’una dell’altra. Ci dicemmo allora, nell’ora della decisione, cose che non si dicono tra i vivi. Ci salutammo, e fu breve; ciascuno salutò nell’altro la vita. Non avevamo più paura». Vanda sarebbe morta ad Auschwitz il 31 ottobre 1944, a venticinque anni.

 Due fotografie di Vanda Maestro (nella prima è con Giorgio Segre) tratte dalla fototeca del CDEC, Centro di documentazione ebraica.
Due fotografie di Vanda Maestro (nella prima è con Giorgio Segre) tratte dalla fototeca del CDEC, Centro di documentazione ebraica.
I funerali di Primo Levi cominciarono alle 14.30 del 13 aprile 1987, lunedì, all’Istituto di Medicina legale di corso Galilei 22, angolo via Chiabrera. Il rabbino Emanuele Artom lesse il Salmo 91, quello che dice:
«Non temerai i terrori della notte
né la freccia che vola di giorno,
la peste che vaga nelle tenebre,
lo sterminio che devasta a mezzogiorno.
Mille cadranno al tuo fianco
e diecimila alla tua destra;
ma nulla ti potrà colpire».
Il corpo era avvolto in un lenzuolo, e la bara coperta da velluto nero, con pochi fiori. La funzione fu molto sobria perché il giorno dopo sarebbe incominciata la Pasqua ebraica, periodo nel quale non si possono tenere cerimonie, neppure funebri. Dall’Istituto di Medicina legale la bara di Primo Levi fu trasportata al primo reparto israelitico del Cimitero generale di Torino, e sepolta. C’erano associazioni di deportati, Norberto Bobbio, Giulio Einaudi, Piero Fassino, i colleghi della Siva, Società industriale vernici affini, di Settimo Torinese dove Levi aveva lavorato per trent’anni, ragazzi con la kippa, il copricapo ebraico. Primo Levi si definiva un ebreo «laico», non andava in sinagoga, ma il giorno prima di morire – raccontò a La Stampa Anna Bises Vitale, vicepresidente della comunità ebraica di Torino – «aveva telefonato per sapere se erano arrivate le azzime, il pane senza sale della nostra Pasqua che comincia».
Il giorno dopo il suo funerale, lo scrittore Ferdinando Camon, che negli anni precedenti aveva realizzato una lunga intervista con Primo Levi, ricevette una lettera dello scrittore: «Se m’è arrivata al martedì», scrisse Camon su Avvenire, «doveva averla imbucata il sabato: dunque durante la passeggiata che faceva ogni mattina. La apro: un inno alla vita, un vortice di programmi, speranze, attese, da riempire settimane, mesi e anni». Sulla prima pagina del Corriere della sera di domenica, accanto al ricordo di Levi scritto da Claudio Magris, c’era la notizia del primo bambino nato in Italia da un embrione congelato. Ha compiuto trent’anni.




