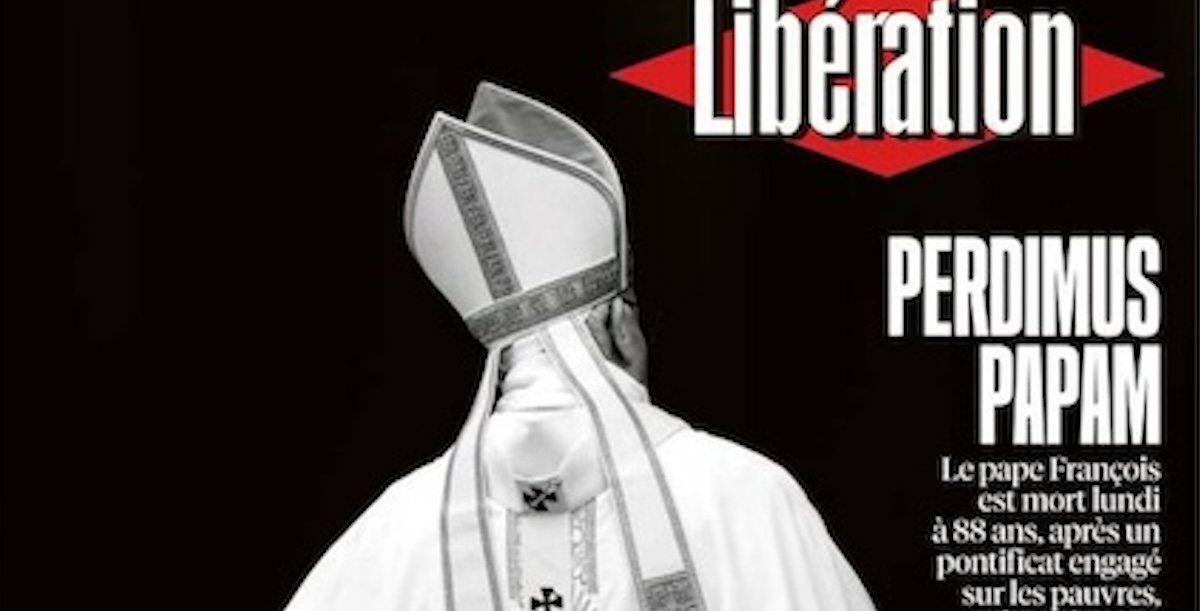Il Daily Mail come fonte
Un po' di esempi sulle notizie false che i giornali italiani riprendono attingendo al tabloid screditato e che Wikipedia ha dichiarato inaffidabile

I responsabili britannici di Wikipedia hanno deciso di indicare come “fonte inaffidabile” il quotidiano Daily Mail e il suo sito Mail Online, e di vietarne l’uso come riferimento nelle voci di Wikipedia, a causa dei loro caratteri di “inadeguata verifica dei fatti, sensazionalismo e deliberate falsificazioni”. Il Mail è il più popolare dei tabloid britannici e il suo sito è diventato un grande successo internazionale in termini di numeri, per la sua capacità di replicare ed esaltare le attitudini del giornale alla cronaca scandalistica, morbosa, inventata.
La stampa britannica è da sempre separata tra quella dei quotidiani più autorevoli e quella dei tabloid, screditati ma di grande successo presso i lettori meno esigenti in termini di verità e qualità dell’informazione. Questa distinzione, assente in Italia, ha fatto sì che i quotidiani italiani abbiano in misure diverse inglobato entrambe le funzioni: e che oggi – soprattutto grazie a internet – usino i tabloid britannici e il Daily Mail come fonti valide e frequenti per riprodurne le notizie, trascurando le diffidenze dei loro colleghi di altri paesi. Al tema dell’uso di queste fonti da parte dei giornali italiani Luca Sofri, peraltro direttore del Post, aveva dedicato un capitolo di esempi del suo libro Notizie che non lo erano.
*****
È tuttora online un articolo apparso nel 2007 sul «Giornale» intitolato: «Via la regina dal passaporto. E la Gran Bretagna si ribella». Si riferisce a una notizia completamente inconsistente data dal quotidiano inglese «Daily Mail» il 10 settembre 2007, secondo la quale «Bruxelles» o «l’Unione Europea» (nessuna fonte più esatta era indicata, e l’articolo era tutto un «si vuole», «potrebbe», e simili) era intenzionata a chiedere al Regno Unito di rimuovere dai propri passaporti la dizione iniziale che riferisce le funzioni del passaporto «a nome della Regina» per sostituirla con un testo riferito alla cittadinanza dell’Unione Europea.
L’eventualità era del tutto implausibile: non solo sono passati otto anni e non è successo (l’articolo dava come data prevista il 2010), ma alla fine di quello stesso articolo il ministro dell’Interno britannico diceva che «non ci sono attualmente progetti» di rinnovare i passaporti. Quindi era già completamente bugiarda la formula «Il Regno Unito potrebbe togliere la regina dai passaporti» usata da alcuni quotidiani italiani, ma ancora di più era quella perentoria e senza condizionale del «Giornale»: «Via la regina dal passaporto».
L’articolo del «Daily Mail» – originato da chissà quale lateralissima e volatile ipotesi – nasceva da due contesti rilevanti. Uno è un vivace sentimento antieuropeo in Gran Bretagna, che il «Daily Mail» e altri giornali hanno ripetutamente fomentato informando i loro lettori di improbabili intenzioni ogni volta più prepotenti e capricciose da parte dell’Unione Europea (dal raddrizzamento delle banane all’imposizione del sistema metrico decimale all’abolizione dello yoghurt): tanto che le «euroleggende» sono diventate il tema di articoli ridicolizzanti il fenomeno e anche di una sezione propria sul sito web della Commissione Europea, che ne elenca alcune centinaia.
A spiegare ancora di più l’inaffidabilità palese di quell’articolo sui passaporti c’era poi l’essenza stessa del «Daily Mail», e dei «tabloid»: storici quotidiani britannici chiamati così in ragione del loro formato ridotto rispetto a quello maggiore dei quotidiani più autorevoli (poi negli ultimi anni le cose si sono confuse in tutto il mondo, e il formato «tabloid» è stato adottato in moltissimi ridisegni di quotidiani: ma non solo il formato). Ma «tabloid» in Gran Bretagna è anche sinonimo di quotidiano popolare e di minore qualità, fatto di sensazionalismi, allarmi, contenuti pruriginosi e pettegolezzi, poca affidabilità e molte notizie false. Per molti inglesi «l’unica cosa a cui credo sul “Daily Mail” è la data» (per molti altri, ed è un tema che oggi riguarda tutti, molte notizie e storie sono interessanti o divertenti a prescindere dal fatto che siano vere).
Questo approccio un tempo screditato dai quotidiani «seri», attenti a tenerne le distanze e distinguersene, è diventato da diversi anni un modello da imitare. Soprattutto in conseguenza delle crisi di vendite dei giornali e dell’arrivo delle dinamiche di lettura e condivisione online e via social network, che hanno esteso enormemente il potenziale dei contenuti che un tempo si dicevano «popolari» e oggi si dicono «virali». La dimostrazione è che proprio il «Daily Mail» – con il suo approccio e forma così poco «moderni» e digitali – è diventato un caso clamoroso di successo online, arrivando a essere nel 2014 il più letto giornale in lingua inglese del mondo, nella sua versione web: proprio in forza di quegli stessi contenuti. Vogliamo leggere storie strane più che storie vere.
E se un tempo i quotidiani italiani trovavano la formula del «Daily Mail» più deprecabile che vincente, negli ultimi anni c’è stata un’inversione di attenzione, e un articolo del «Daily Mail» non è più qualcosa di cui essere diffidenti ma qualcosa che può generare grandissimi volumi di traffico e lettori: quindi la diffidenza viene spesso rimossa, e gli articoli del «Daily Mail» che generano scandalo, curiosità, o indignazione sono spesso raccolti dalle agenzie di stampa e dai quotidiani italiani come se si trattasse di articoli del «New York Times» o del «Wall Street Journal»: senza nessuna verifica e con la stessa fiducia.
L’8 marzo 2010 il «Corriere della Sera» pubblicò un articolo che iniziava così:
Ophelia Kirwan ha due anni, i suoi genitori fanno i medici, sono molto benestanti – abitano a Knightbridge, una delle zone più esclusive di Londra – e ha due sorelle più grandi. Sembra l’inizio di una bella favola metropolitana, non fosse che Ophelia è affetta dalla sindrome di Down. E i suoi genitori, per correggere i difetti dei lineamenti tipici di chi soffre di questa malattia, hanno deciso di sottoporla a una serie di interventi di chirurgia plastica suscitando un aspro dibattito.
In realtà ad avere suscitato un aspro dibattito – che in effetti c’era – non era stata la decisione dei genitori, ma un articolo del «Daily Mail» che la raccontava, a partire da un’intervista alla madre (il padre di professione fa il chirurgo plastico). Il titolo dell’articolo era «Dovremmo usare la chirurgia estetica per rendere nostra figlia bella come noi?», sopra una foto della bambina e sua madre.
Ma il dottor Kirwan – come spiegò mostrando successivamente le sue corrispondenze con l’autrice dell’articolo – aveva escluso di volere usare la chirurgia estetica su sua figlia, e si era anzi seccato quando aveva sospettato che l’articolo potesse prendere questa piega invece che descrivere la condizione dei bambini Down e dei loro genitori, ricevendo rassicurazioni dalla giornalista (i coniugi Kirwan si sono poi separati, molto tumultuosamente). La formulazione dell’ipotesi fu quindi una completa fabbricazione (l’articolo del «Daily Mail» è stato rimosso da internet, ma si trova riprodotto da altri siti), come era il caso di sospettare.
Fu invece estesamente ripreso da diversi quotidiani italiani («il Giornale»: «La figlia è down, plastica al viso»; «la Repubblica»: «Chirurgia estetica per bimbi down, il caso divide la Gran Bretagna»).
A dicembre del 2008 il «Daily Mail» scrisse che un gioielliere italiano aveva ricevuto dagli Stati Uniti richieste di informazioni su un anello che il presidente americano Barack Obama avrebbe voluto regalare a sua moglie. La notizia fu ripresa immediatamente da molti giornali italiani.
«Obama ha deciso: anello italiano per Michelle» [RaiNews] «Bosco, l’ex vicesindaco del Pci ha creato l’anello della First Lady» [«la Repubblica»]
«Ecco l’anello italiano che Obama vuol regalare alla sua Michelle» [«il Giornale»] «Obama regalerà un prezioso anello “italiano” alla moglie Michelle» [«Corriere della Sera»]
Un portavoce della Casa Bianca smentì la notizia il giorno dopo il primo articolo del «Daily Mail» (quello di «Repubblica» uscì due settimane dopo, indifferente).
Il 16 agosto 2013 il «Daily Mirror» annunciò con un articolo che «le autorità di sicurezza dell’aeroporto di Heathrow sono in un alto livello di allarme per la paura che delle donne con dell’esplosivo impiantato chirurgicamente nel loro seno possano farsi esplodere». La notizia era riportata senza nessuna fonte affidabile (anonimi impiegati dell’aeroporto), come al solito, e come al solito attraverso l’uso di tutta una serie di formule ingannevoli e vaghe: «È emerso che», «Alcuni esperti dicono», eccetera. E l’ipotesi venne immediatamente ripresa con toni allarmati da molti siti di news italiani.
«Londra, allarme a Heathrow, donna kamikaze avrebbe seni imbottiti di esplosivo» [«Corriere della Sera»] «Tette finte riempite col tritolo. Massima allerta terrorismo all’aeroporto di Heathrow» [«Libero»]
«Protesi seno esplosive: la kamikaze in areo nuova frontiera di Al Qaeda» [«Il Mattino»] «Londra, allarme per i seni “esplosivi”» [«Il Secolo XIX»]
Per tutti la fonte era il solo «Daily Mirror», che come abbiamo visto non aveva fonti. Ma la minaccia della donna dal seno esplosivo aveva già una storia lunga di allarmismi rituali. «Repubblica» ne scriveva già nel 2010 col titolo «Terrorismo: Allarme kamikaze, donne col seno al plastico». E il «Corriere», nella stessa occasione: «Fox: “Bombe nei seni delle terroriste”», dove Fox era la screditata e battagliera rete televisiva americana, anche in quel caso priva di sostegni credibili alla minaccia. Anche allora la fonte originaria era l’articolo di un tabloid britannico, il «Sun».
Il tema del terrorista suicida con dell’esplosivo all’interno del proprio corpo è tornato spesso negli anni delle paure dopo l’11 settembre: allo stato si conosce un solo caso concreto, ed è quello – mai chiarito del tutto esattamente – di un uomo di Al Qaida i cui complici avrebbero fatto detonare dell’esplosivo collocato all’interno «del suo retto» attraverso una chiamata telefonica, in un attentato contro un principe saudita nel 2009. Il principe fu ferito poco gravemente, l’attentatore dilaniato: tra le molte ragioni di scetticismo sulla potenziale efficacia di azioni simili ci sono le difficoltà di detonazione dell’esplosivo (ancora di più nel caso sia contenuto nell’ipotetico impianto chirurgico) e l’effetto di contenimento del corpo dell’attentatore sull’esplosione. Il «seno esplosivo» è quindi un’ipotesi che viene ciclicamente evocata dai giornali allarmistici e discussa in circoli online di appassionati di sicurezza, ma a oggi ritenuta molto implausibile e priva di indizi concreti. Salvo che dai tabloid britannici, e dai giornali italiani di conseguenza.
Il 2 novembre 2011 il «Daily Mirror» pubblicò una bella fotografia in bianco e nero di un nudo – inginocchiato, pudico – dell’attrice Elizabeth Taylor da giovane: «Per la prima volta mostrato un ritratto intimo di Liz Taylor a 24 anni». La foto, si spiegava, era stata diffusa da un collezionista privato ora che Taylor era morta da pochi giorni, ed era stato un di lei regalo al suo marito di allora. Adesso era la prima foto conosciuta pubblicamente di Liz Taylor nuda.
Proprio per via della recente morte dell’attrice celeberrima – oltre al potenziale attrattivo dell’immagine per qualunque lettore del mondo –, la fotografia e la sua storia furono immediatamente ripresi dai siti e dai giornali di mezzo mondo. È ancora online come tale sui siti di «Repubblica», «Quotidiano Nazionale», «Il Messaggero», «Corriere della Sera», tra gli altri (e uscì allora sulle rispettive pagine di carta, il giorno dopo).
Ma dopo poche ore qualcuno scoprì l’originale dell’immagine, che ritraeva una modella fotografata da un famoso fotografo californiano: la somiglianza con Liz Taylor aveva ingannato alcuni osservatori della fotografia in anni precedenti, e ora quell’equivoco era chissà come divenuto una rivelazione sul «Daily Mirror» e sui nostri quotidiani.
Il 27 febbraio 2013 il sito del «Daily Mail» pubblicò le foto di oltre duecento mante morte deposte in fila sulla spiaggia di Gaza, in Palestina, descrivendo il mistero di questi animali andati a morire spiaggiati in grandi numeri e parlando dei pescatori palestinesi increduli del fenomeno. La storia fu ripresa il giorno dopo da molti siti di news italiani – «la Repubblica», Ansa, «La Stampa», tra gli altri – e dal sito di «Repubblica» e da quello del «Daily Mail» si propagò su molti altri media internazionali, sempre col «mistero» e le immagini impressionanti al centro.
Poi successe che alcuni siti e testimoni locali spiegarono nei giorni seguenti che le mante erano state semplicemente pescate in mare dai pescatori che si vedevano nelle foto, che le avevano poi disposte sulla spiaggia per squartarle e venderle (nelle foto gli animali sono in file ordinate). E le stesse indicazioni erano in realtà presenti nelle didascalie originali allegate alle foto mostrate. Su YouTube si trovavano poi dei video che mostravano la pesca delle mante sulle barche dei pescatori.
Nessuno dei siti italiani spiegò successivamente il «mistero» né corresse la notizia, che resta tuttora online in questa forma.
A Gaza quel tipo di pesce – considerato pericoloso perché la coda contiene un forte veleno – era scomparso del tutto da almeno sette anni. La scorsa notte, per ragioni per il momento ignote, i «manta giganti» hanno fatto improvvisamente ritorno, in grande stile. In parte si sono impigliati nelle reti dei pescatori, distese a breve distanza dalla costa. In parte hanno raggiunto la spiaggia e sono avanzati per alcune decine di metri, fino a esalare l’ultimo respiro. [Ansa]
Per ora resta solo un mistero. Difficile stabilirne le cause, ma lo scenario che si è presentato sulla spiaggia è stato davvero sconcertante. È qui che alcuni pescatori palestinesi hanno scoperto all’alba centinaia di mante spiaggiate sulle sabbie di Gaza Beach. [Repubblica.it]
Poi ci sono anche le versioni americane dei tabloid britannici, come il «National Examiner», citato in un articolo del «Corriere della Sera» del 2008: «Tabloid Usa: “Bush sta per divorziare”».
Wikipedia descrive così il «National Examiner», usato come fonte dal «Corriere»: «Il “National Examiner” è un tabloid da supermarket, i cui contenuti sono stati spesso messi in dubbio, ed è stato deriso per la sua scrittura sensazionalistica. […] Molto frequenti sono gli articoli che riguardano i personaggi televisivi, di solito di scarsa qualità».
«A dar retta alla rivista la decisione di Laura Bush è presa» aggiunge l’articolo ancora online di RaiNews. «I tabloid Usa scatenati “George e Laura si lasciano”» è il titolo di «Repubblica». Eccetera, su molte altre testate, tutte attribuendo a fonti screditate e prive di elementi la notizia, ma dandola lo stesso («A spingere la First Lady a lasciare il marito sarebbe un flirt del presidente con Condoleezza Rice» spiegava «l’Unità»).
Il matrimonio dei coniugi Bush, come si sa, è durato finora altri sette anni.
Il 24 giugno 2013 alcuni giornali internazionali – in Italia «Repubblica» e «Il Secolo XIX» raccontarono una storia che colpì chiunque la lesse: a un soldato americano era stata attribuita l’uccisione di 2746 iracheni durante la guerra in Iraq. Duemilasettecentoquarantasei. Storia pazzesca, e infatti «Repubblica» la mise in prima pagina e con ben tre pagine all’interno: «Il sergente Born to kill. Così uccisi 2746 iracheni».
Contava le teste come i petali delle margherite: morto, non morto, e nel dubbio, poiché era «umano», finiva quelli ancora vivi. Il sergente Dillard Johnson del 7mo Cavalleria contò 2746 iracheni uccisi da lui in un mese di guerra, record assoluto di petali umani staccati per un soldato, almeno da quando l’esercito americano tiene questa contabilità.
L’articolo spiegava che in gran parte i nemici erano stati uccisi dal cannoncino di un carro armato leggero (ribattezzato Carnivore dallo stesso Johnson), e che 126 invece erano stati colpiti con un fucile da cecchino. Però negli Stati Uniti la storia era stata ripresa da pochissimi siti e giornali, e da nessuno di quelli autorevoli, e le due fonti principali da cui l’avevano tratta «Repubblica» e gli altri erano rispettivamente l’americano «New York Post» e l’inglese «Daily Mail»: ovvero i due simboli del giornalismo sensazionalista e inaffidabile da tabloid a New York e Londra.
Il dato sui «nemici uccisi», in quegli articoli, proveniva da un comunicato promozionale del libro in uscita del soldato in questione, Dillard Johnson: il che lo rendeva ulteriormente sospetto, oltre a indicare un approccio giornalistico piuttosto discutibile, quello che si affidava per un titolo in prima pagina a un dato proveniente da un comunicato stampa prodotto per vendere un libro. Due giorni dopo, la diffidenza di molti lettori di quella storia trovò una risposta in un esauriente articolo sul sito del «Christian Science Monitor», vecchia e autorevole rivista americana.
Un nuovo libro di memorie belliche, Carnivore di Dillard Johnson, espone delle notizie piuttosto eccezionali, a quanto riferiscono alcuni media e il materiale promozionale dell’editore HarperCollins. Ma sembra probabile che queste notizie siano esagerate, e per qualcuno si avvicinano al territorio dell’impostura.
L’articolo spiegava come molti esperti e veterani avessero contestato soprattutto su internet il dato su Johnson e altre parti del racconto diffuso su di lui (che nel frattempo era stato acriticamente promosso anche dalla tv statunitense Fox), e di come queste cifre si fossero dimostrate piuttosto implausibili sulla base di testimonianze e confronti con dati e fatti certificati. Fidandosi di quel dato, Johnson aveva ucciso ben il 14 per cento del complessivo numero di nemici uccisi dalla coalizione in Iraq, senza aver partecipato a nessuna battaglia maggiore, e oltre cinquecento in più rispetto al numero complessivo attribuito al suo intero squadrone, composto da alcune centinaia di soldati.
Il giorno seguente, l’autore dell’articolo sul «Christian Science Monitor» aggiunse questo aggiornamento.
Ho parlato con Mr Johnson dopo la pubblicazione di questo articolo. Dice che il suo libro non sostiene che abbia ucciso 2746 combattenti nemici o che da cecchino ne abbia uccisi 121. Dice che quei numeri sono sì sulla copertina del libro e nella pubblicità al libro di HarperCollins, ma che il dato non è mai affermato nel testo del libro e che è inesatto. Dice che non è responsabile di quello che ha scritto l’editore. Il numero di 2746 è la sua stima di coloro che sono stati uccisi in battaglia da lui e dagli altri uomini con cui ha combattuto.
Fine della storia. «Repubblica» non ne scrisse più dopo quel grande articolo in prima pagina.
Attraverso il mirino ottico del fucile da cecchino, nella solitudine degli agguati con lo «spotter», l’assistente accanto per la misurazione della distanza e del vento, il sergente aggiunse altri 126 morti al bottino fatto con il «Carnivore», portando ai 2.746 il totale. Uno per uno, contando le teste, quando non restava altro nei veicoli nemici carbonizzati, i fucili abbandonati, poi i nemici colpiti senza che neppure potessero immaginare di essere bersagli a centinaia di metri di distanza, Johnson annotava tutto. Su un libretto, e sempre con una matita, molto più affidabile di biro o penne, annotava i suoi successi. Li riportava ai superiori come un diligente compito a casa, per il «body count», il conteggio dei corpi che il Pentagono diceva di non fare più dai tempi del Vietnam, ma che continuava a fare. Non si può naturalmente sapere con certezza storica se quei quasi tremila nemici abbattuti siano realmente un record assoluto, nella infinita sequenza di guerre, non soltanto americane. [«la Repubblica», 24 giugno 2013]