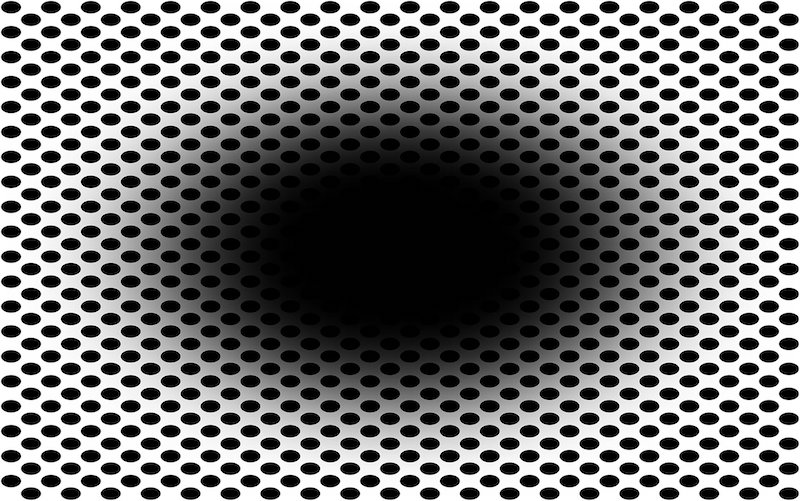Perché non si riesce a espellere i migranti irregolari
Si fa presto a dirlo, ma farlo è complicatissimo: c'entrano una legge del 2011 e l'assenza di accordi bilaterali per i rimpatri

Uno dei problemi più citati in questi giorni, quando si parla di migranti, è la difficoltà a individuare ed espellere i cosiddetti migranti “irregolari”, cioè quelli che non hanno un permesso per rimanere in Italia. Se ne parla soprattutto da quando sono emerse le difficoltà di riportare in Tunisia Anis Amri, l’attentatore di Berlino, nel 2015.
Gli esperti di immigrazione considerano le espulsioni uno dei principali problemi della gestione dei flussi migratori verso l’Italia, ma anche uno dei più delicati: fra i cosiddetti “irregolari” ci sono anche decine di persone che hanno un lavoro – dopo vediamo come – ma che non possono essere regolarizzate, oppure persone le cui procedure di asilo sono state gestite in maniera sbrigativa e poi negate, quando invece avrebbero avuto diritto a maggiori forme di protezione. In generale, comunque, espellere una persona è materialmente molto difficile sia per questioni di forze e costi sia per ragioni legislative. Il governo sta provando a fare qualcosa, ma gli esperti non hanno molta fiducia sul fatto che le cose miglioreranno a breve.
I provvedimenti recenti
L’approccio adottato in questi giorni dal governo Gentiloni e dalle autorità italiane prevede quella che i giornali hanno definito una “stretta” sulle espulsioni e la ripresa dei negoziati per i controlli nel Mediterraneo con alcuni paesi come la Tunisia e la Libia.
Il 31 dicembre 2016 il capo della polizia Franco Gabrielli e il ministro degli Interni Marco Minniti hanno inviato una circolare congiunta a prefetture, questure e comandi dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria, in cui chiedono di «conferire massimo impulso all’attività di rintraccio dei cittadini dei Paesi terzi in posizione irregolare, in particolare attraverso una specifica attività di controllo delle diverse forze di polizia». Pochi giorni dopo il governo ha fatto sapere che intende aprire un CIE – cioè i centri di identificazione ed espulsione degli stranieri irregolari, molto controversi e paragonati a delle prigioni da esperti e attivisti per i diritti dei migranti – in ogni regione italiana, verosimilmente per accelerare i processi di espulsione degli stranieri “irregolari” rintracciati.
Nei giorni scorsi inoltre Minniti è stato a Tunisi per discutere col governo tunisino di prevenzione del terrorismo e del traffico di migranti, e secondo diversi giornali ha programmato per i prossimi giorni una visita in Libia per discutere degli stessi temi con il governo libico di unità nazionale, frutto di un accordo raggiunto tra diverse forze politiche circa un anno fa (la Libia è il principale paese da dove partono i barconi di migranti diretti verso le coste italiane).
Attorno ai provvedimenti del governo non c’è grandissima fiducia. In questi anni i CIE – oltre che posti dalla dubbia legittimità giuridica, dato che ai migranti viene limitata la libertà personale senza che abbiano compiuto un reato – si sono rivelati anche particolarmente inefficaci: secondo un rapporto presentato pochi giorni fa dalla Commissione diritti umani del Senato, da gennaio a settembre del 2016 su 1.968 persone detenute nei CIE, solamente 876 sono state effettivamente espulse, meno della metà. E anche la ripresa dei negoziati per gli accordi internazionali conta fino a un certo punto, visto che con i paesi del Nordafrica la collaborazione esiste da anni, mentre mancano accordi per i rimpatri con i paesi da cui in questi mesi stanno arrivando moltissimi migranti. L’assenza di questi accordi, in particolare, è una delle principali debolezze del sistema italiano delle espulsioni.
Come funziona
In Italia esistono vari tipi di espulsione per gli stranieri “irregolari”, cioè che non dispongono di un permesso per rimanere sul territorio italiano (né turistico, né lavorativo, né una forma di protezione internazionale né sono in attesa che la loro richiesta venga esaminata). Il più grave è il decreto di espulsione amministrativa emanato dal ministero degli Interni per motivi di sicurezza: dal 2014 a oggi ce ne sono stati 133, un numero altissimo rispetto a quello degli anni scorsi – dal 2004 al 2014 il governo italiano aveva espulso per motivi di sicurezza una media di 14 persone all’anno – ma tutto sommato contenuto. La maggior parte dei decreti di espulsioni sono emanati dalle singole prefetture, e riguardano – semplificando molto – le persone che non hanno un permesso di soggiorno, o che semplicemente hanno esaurito le pratiche giuridiche per procurarsene uno, e le persone ritenute “socialmente pericolose” perché hanno compiuto un reato e il giudice ritiene che potrebbero compierne altri.
Fino al 2011, la norma per applicare il decreto di espulsione era l’accompagnamento forzato alla frontiera da parte delle autorità italiane. Il decreto legge 89/2011, emanato dal governo Berlusconi, ha ribaltato questa consuetudine: all’espulsione forzata ha sostituito l’allontanamento volontario da concordare con la persona espulsa – probabilmente per questioni di forze e risorse – a cui viene semplicemente dato un periodo di tempo entro cui lasciare l’Italia (nel caso dei migranti parliamo spesso di 7 o 15 giorni). L’espulsione forzata a oggi è prevista solamente in alcuni casi che devono essere decisi da un giudice, che dipendono dalla pericolosità della persona in questione (va allontanato forzosamente, per esempio, se il giudice ha convertito la pena detentiva in un provvedimento di espulsione). Concretamente, a migliaia di persone che le autorità italiane non ritengono pericolose viene semplicemente consegnato un foglio che gli ordina di lasciare l’Italia, senza però che questa misura sia davvero applicata. Secondo dati forniti dal ministero degli Interni al Corriere della Sera, nel corso del 2016 sono stati fermati 38.284 migranti “irregolari”, dei quali però più di 21mila non sono stati né allontanati dal territorio nazionale né rimpatriati.
Migranti, via a retate ed espulsioni Il ministro Minniti: «Cie in ogni regione» https://t.co/nKScR7foM4 pic.twitter.com/qQG1J8dYBf
— Corriere della Sera (@Corriere) December 30, 2016
Con i paesi con cui ha degli accordi bilaterali, infatti, l’Italia può concordare rimpatri forzati dei migranti che si trovano nelle proprie strutture (che siano CIE, hotspot o centri di prima accoglienza). L’Italia ha accordi bilaterali per il rimpatrio con Tunisia, Nigeria, Egitto e Marocco: ma almeno fino a qualche mese fa non aveva nessun tipo di accordo con paesi tutto sommato stabili come Senegal, Gambia e Costa d’Avorio (cioè i paesi da cui complessivamente proviene il 20 per cento dei migranti arrivati in Italia nel 2016, secondo i dati dell’ONU). Qualche mese fa Carlotta Sami, portavoce per l’Europa meridionale per l’agenzia ONU per i rifugiati, ha detto: «Con le espulsioni gli Stati membri intimano agli irregolari di lasciare il paese, ma poi quasi mai questi si allontanano. Con i rimpatri invece il migrante viene effettivamente riportato nel paese d’origine. Senza accordi di riammissione non si muove nulla». L’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), una delle più importanti associazioni che si occupano di migranti in Italia, ha invece proposto che i vari tipi di espulsione vengano «drasticamente ridotti e razionalizzati», e che vengano «resi efficaci e concreti i programmi di rimpatrio volontario assistito» (una specie di forma intermedia fra l’espulsione e il rimpatrio forzato).
I casi limite
Per via di una stortura delle leggi italiane in materia di immigrazione, molti migranti arrivati in Italia riescono a trovare lavoro ma non a regolarizzare la propria posizione: è il caso delle persone occupate ma a cui viene negata la richiesta di protezione internazionale. Solitamente la loro richiesta viene esaminata nel giro di due-tre anni: il fatto è che in questo lasso di tempo i richiedenti asilo hanno la possibilità di cercare lavoro, e anzi sono incoraggiati a farlo se entrano nel circuito delle strutture SPRAR (cioè quelle di cosiddetta “seconda accoglienza”, e considerate l’aspetto virtuoso del sistema di accoglienza italiano).
Mentre la procedura è in corso, secondo la legge italiana la richiesta di protezione umanitaria non può essere convertita in una richiesta di permesso di soggiorno lavorativo. E se alla fine del loro percorso giuridico queste persone hanno trovato un posto di lavoro, il loro datore di lavoro non può assumerli perché di fatto non hanno più il permesso di stare in Italia; paradossalmente queste persone – che per giunta sono state formate a spese dello Stato e delle imprese – non possono nemmeno chiedere un permesso di soggiorno, proprio perché non hanno più un lavoro. Al momento non è chiaro quante persone possano trovarsi in questa situazione: qualche tempo fa la Stampa aveva raccontato le storie di alcune di loro.