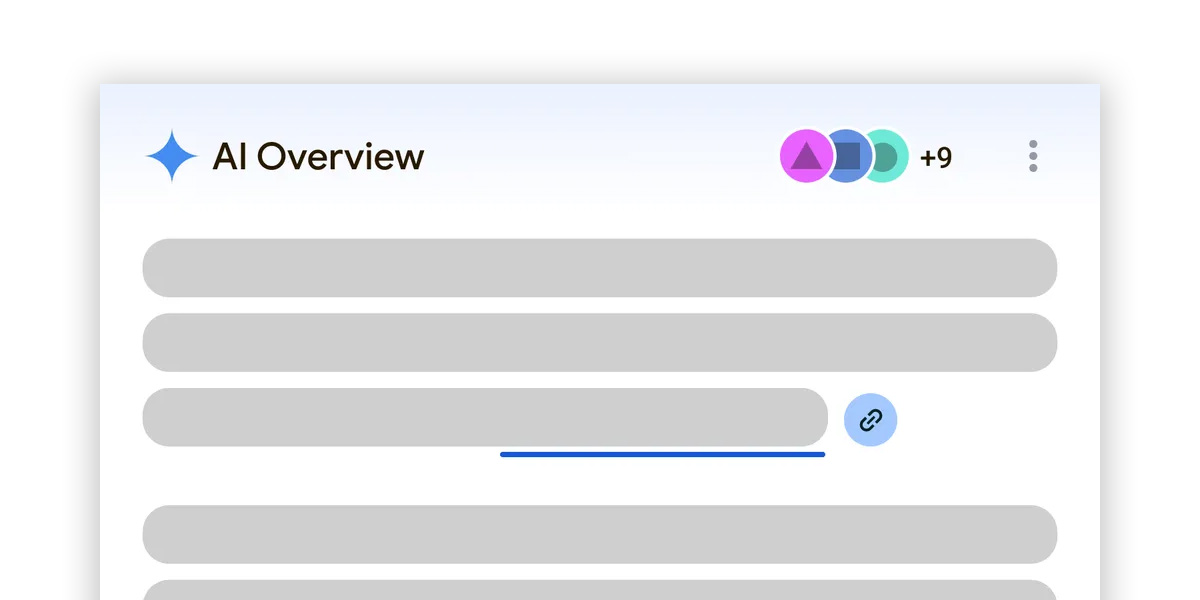Ben Harper, nove belle canzoni
Scelte tra i due canoni del suo repertorio: le dolci ballate o gli aggressivi rocchettoni

Ben Harper è un cantautore americano, nato il 28 ottobre 1969 a Pomona, in California: diventò famoso tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila per le sue canzoni che mescolavano suoni ed elementi tipici del folk e blues statunitense a ritmi provenienti dal reggae e dalla world music. Oltre alla sua voce molto riconoscibile, l’elemento più distintivo delle sue canzoni è l’utilizzo della “steel guitar”, una chitarra elettrica che si suona schiacciando i tasti con un tubo in metallo, tenendola appoggiata su un supporto o sulle ginocchia. Il suo ultimo disco, Call it what it is, è uscito lo scorso aprile. Queste sono le nove canzoni che Luca Sofri, peraltro direttore del Post, aveva scelto per il suo libro Playlist.
Ben Harper
(1969, Pomona, California)
Ben Harper prima non c’era. È difficile avvicinarlo a qualcun altro, benché alla fine non faccia che cantare dolci ballate o aggressivi rocchettoni: perché lo fa usando molto e in modo particolarissimo la chitarra, e perché ha una voce che ha solo lui. Dopo, gli sono somigliati un po’ il suo amico Jack Johnson e Chocolate Genius. Nero, californiano, stimatissimo, e idolatrato dai fans, dà il suo meglio sulle prime: le dolci ballate. I dischi e le collaborazioni degli ultimi anni hanno la stessa sincerità e coerenza di sempre, ma hanno perso molto di originalità e inventiva.
I’ll rise
(Welcome to the cruel world, 1994)
È l’ipnotico gospel che chiudeva il disco di debutto di Ben Harper. Il testo è una poesia di Maya Angelou, Still I rise: “Mi potete cancellare dalla storia con le vostre amare e torbide bugie, potete disperdermi sottoterra, ma io – come polvere – risorgerò”.
Another lonely day
(Fight for your mind, 1995)
In un disco di temi sociali e aggressività politiche (a cominciare dal titolo), una canzone d’amore finito, ridotta musicalmente all’osso: chitarra, voce, pochissimi accordi, quasi un testo da manuale al corso di chitarra.
Eppure perfetta, oppure perfetta.
Give a man a home
(Fight for your mind, 1995)
Come in “I’ll rise”, un refrain fatto della reiterazione del titolo, questa volta implorante piuttosto che rivendicatoria. La strofa sembra preludere alla necessità di dare a ognuno una speranza, “a hope”. Ma il refrain parla appunto di una casa – “a home” – più prosaicamente, o metaforicamente.
Glory & Consequence
(The will to live, 1997)
Con un’idea di arpeggio come quella che apre e sostiene questa canzone ci si potrebbe fare di tutto: “pa-pa-pà para-pa-pà”. Lui ci fece una dichiarazione alla “meglio un giorno da leoni eccetera”, formidabile anche come apertura del disco dal vivo Live from mars.
I shall not walk alone
(The will to live, 1997)
Uno vorrebbe essere sulla veranda della sua casa in Georgia, a dondolarsi sulla sedia a dondolo, davanti al tramonto. Uno vorrebbe essere sulla terrazza del suo bungalow sull’oceano, nel Maine, davanti al tramonto (con il problema che nel Maine, il tramonto è dall’altra parte). Uno vorrebbe essere almeno sulla sdraio dello stabilimento balneare Mariuccia di Marina di Pietrasanta, davanti al tramonto.
I want to be ready
(The will to live, 1997)
Vuole essere pronto per il regno dei cieli. Si sospetta l’ispirazione congiunta di letture bibliche e una discreta quantità di erba. (Se mi fate un funerale, voglio o questa o “You can’t always get what you want” dei Rolling Stones, in citazione del Grande freddo).
When she believes
(Diamonds on the inside, 2003)
A questo punto, Ben Harper aveva cominciato a farsi venire qualche voglia in più. Senza esagerare per carità: ma un’ideuzza, una trovata, un tentativo. Questa – dolcissima – comincia con una fisarmonica che pare una canzone francese degli anni Sessanta. Poi lui dice di sentire i violini, e si sentono i violini. Poi c’è il solito repertorio evangelico, ma almeno stavolta è per concludere quanto sia bello quando una ragazza crede in lui.
Crying won’t help you now
(Both sides of the gun, 2006)
Anche qui Harper indovina una cosetta con la chitarra, quattro note, tre secondi, e basta e avanza. Dopo, c’è solo da cantare con passione una melodia zuccherina e un testo disincantato, ma il più è fatto.
Better way
(Both sides of the gun, 2006)
Se tutto di te fa pensare a un tempo in cui il rock era un’altra cosa, se sei un grande chitarrista, se canti di emancipazione e liberazione, prima o poi va a finire che fai la vera canzone fricchettona, quella con i suoni indiani e il coro sul mondo migliore. E ti viene anche bene.