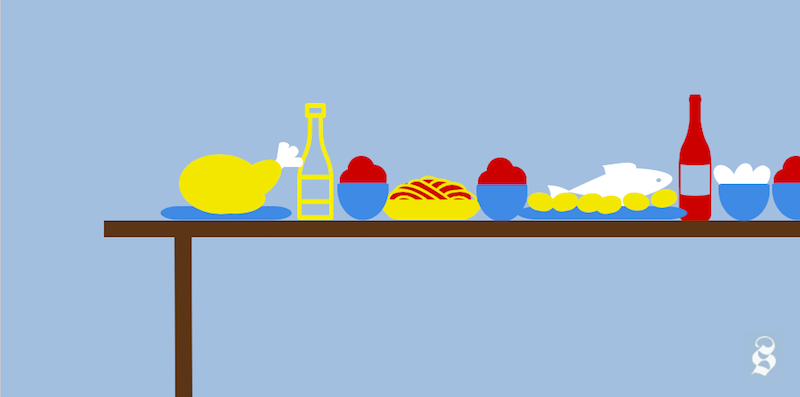I giornalisti stanno uccidendo il giornalismo?
Quando continuano ad «aggrapparsi ostinatamente ai vecchi metodi» invece di abbracciare il cambiamento, dice il Washington Post, sì
di Chris Cillizza – The Washington Post

La scelta del New York Times di nominare Jim Rutenberg come nuovo responsabile della sezione media è stata una mossa intelligente. L’ultimo articolo di Rutenberg – che parla di come le notizie siano sempre più in stile BuzzFeed e di come il giornalismo debba e/o dovrebbe cambiare – è una lettura davvero interessante. Anche se non sono d’accordo su tutto, credo che Rutenberg nel suo pezzo, in cui tra gli altri cita il cofondatore di Politico Jim VandeHei, racconti qualcosa di molto importante su come il giornalismo debba cambiare:
Inizia tutto con l’idea volutamente provocatoria di VandeHei secondo cui «i giornalisti stanno uccidendo il giornalismo». Lo fanno, dice VandeHei, «aggrappandosi ostinatamente ai vecchi metodi», cioè scrivendo 50 articoli che si fanno concorrenza tra loro ma sono praticamente identici sull’ultimo discorso di un candidato alla presidenza, o un aggiornamento di 700 parole sulle trattative per il bilancio nel settore dei trasporti.
«Una volta, in un giornale, non c’era modo di sapere se le persone leggevano il nostro articolo di 600 parole su un rincaro del pedaggio di un’autostrada. Ora invece lo sappiamo», ha detto VandeHei. «Non dico di lasciare che sia il pubblico a decidere tutto, ma una società di news intelligente, aggressiva e proiettata al futuro scriverà quello che ritiene importante, e quello che il suo pubblico pensa sia importante».
Questo punto è fondamentale. Ma per capirlo davvero bisogna fare un passo indietro, prima di farne uno in avanti. Immaginate che il giornalismo si possa scomporre in tre categorie di base: la categoria del “cosa”, quella del “e quindi?”, e la categoria del “e ora?”. Nella categoria del “cosa” c’è il racconto diretto degli eventi. «Oggi c’è stato un incendio in via Verdi. Non ci sono feriti», eccetera. La categoria del “e quindi?” racconta perché quell’evento si è verificato e/o perché è importante da un punto di vista giornalistico; racconta ai lettori che l’incendio di via Verdi è stato il terzo questo mese, e che la polizia sta indagando su tutti e tre gli incendi. La categoria del “e ora?” spiega dove va la storia, qual è la prossima cosa a cui una persona interessata a quella storia dovrebbe fare attenzione; i vigili del fuoco si stanno mettendo in contatto con altri quartieri della città per capire se ci sono stati incendi simili a quelli nella zona di via Verdi, e così via (per inciso, la divisione delle notizie in queste tre categorie non è mia, ma di Erik Rydholm, produttore esecutivo del programma sportivo americano Pardon the Interruption, un vero genio).
Leggi anche: Il giornalismo delle angurie
Fino a circa dieci anni fa i prodotti di news avevano sempre dedicato il 95 per cento del loro tempo e delle loro risorse al “cosa” di ogni storia. Era questo che qualificava un prodotto di news come tale: la capacità di raccontare quel “cosa” meglio di chiunque altro, e a più persone di chiunque altro. Funzionava. Prima dell’arrivo di Internet – e prima dell’enorme frammentazione dei media – le persone avevano un numero limitato di fonti per trovare il “cosa”, quindi essere tra quelle fonti significava avere grande successo ed essere molto ricchi. Poi, all’improvviso, Internet ha cambiato tutto. Era diventato possibile ottenere il “cosa” da qualsiasi fonte e da chiunque nel giro di qualche secondo, semplicemente cercando la storia nel proprio browser.
L’ascesa di Google News come “smistatore di traffico” ha fatto che sì che fosse un algoritmo a decidere se le persone avrebbero letto il tuo “cosa”. Lo stesso vale per Facebook e per il “web della condivisione”. Per dirla in modo semplice, il “cosa” non aveva più la stessa presa sul lettore medio (ovviamente ci sono delle eccezioni a questa regola, come quando per esempio il “cosa” rivela qualcosa di nuovo e la tua società di news è l’unica ad avere quella storia, come nel caso del database sulle sparatorie della polizia americana per cui il Washington Post ha da poco vinto il premio Pulitzer). Con il declino del “cosa” in termini di interesse dei lettori, è iniziata l’ascesa del “e quindi?” e del “e ora?”. All’improvviso le persone non si accontentavano più di leggere di un dibattito durante la campagna elettorale per le presidenziali: volevano anche l’analisi del dibattito, insieme alla notizia; non volevano più aspettare il giorno dopo per scoprire chi era andato bene e chi no, volevano tutto in tempo reale. E per i lettori sotto i trent’anni questa tendenza si è moltiplicata per due. L’interesse crescente per l’analisi, il contesto e i commenti del “cosa” spiegano il grande successo negli Stati Uniti di programmi-parodia dei telegiornali e dei programmi di approfondimento politico come il Daily Show e il Colbert Report. Comedy Central, il canale che li trasmette (il Colbert Report ha chiuso nel 2014), ha capito che le persone volevano avere un’opinione insieme alla notizia, e che l’era dei giornalisti vecchio stile era finita.
Come VandeHei ha giustamente sottolineato, tuttavia, la maggior parte delle redazioni faticava, e fatica, a riconoscere il cambiamento nelle abitudini di consumo dei lettori. Vengono dedicate ancora grandi quantità di tempo e soldi al “cosa”, per un articolo che raggiungerà molte persone solo se verrà scelto dall’algoritmo di Google o Facebook, o se un grande aggregatore – come per esempio l’americano Drudge Report – lo pescherà tra gli altri mille articoli simili che circolano su Internet.
Questo non significa che il “cosa” non sia più importante. Non è così: è ancora la spina dorsale del corpo delle notizie, che permette a tutto il resto di stare in piedi. Non sto suggerendo di azzerare l’attenzione e le risorse dedicate al “cosa”, ma piuttosto (e credo che VandeHei sarebbe d’accordo) di ridistribuirle. Non saprei dare cifre esatte, ma credo che il 50 per cento per il “cosa”, il 25 al “e quindi?” e un altro 25 al “e ora?” sia una buona approssimazione di come una società di media dovrebbe ripartire le proprie risorse. Per i nuovi arrivati nel settore, però, le percentuali per le ultime due categorie sarebbero – e dovrebbero essere – più alte.
Questo aspetto tende a perdersi nel dibattito sul futuro dei media. Si tende a dare per scontato che ci sia una dicotomia tra il tutto e il niente. O si racconta il “cosa” o si dedica il proprio tempo a far esplodere un’anguria con degli elastici e a trasformare illusioni ottiche in contenuti virali. Ma è una falsa scelta, che serve solo a bloccare un dibattito di cui chi lavora nel mondo del giornalismo ha disperatamente bisogno. La verità è che dobbiamo occuparci sia del “cosa” che del “e quindi?” e del “e ora?” che compongono il giornalismo. Solo che il “cosa” ha un pubblico sempre più difficile da intercettare (e con cui ottenere guadagni), e dobbiamo capire che il miglior modo per far affezionare le persone ai nostri contenuti potrebbe essere investire più tempo ed energia sugli altri due fattori dell’equazione giornalistica.
© 2016 – The Washington Post