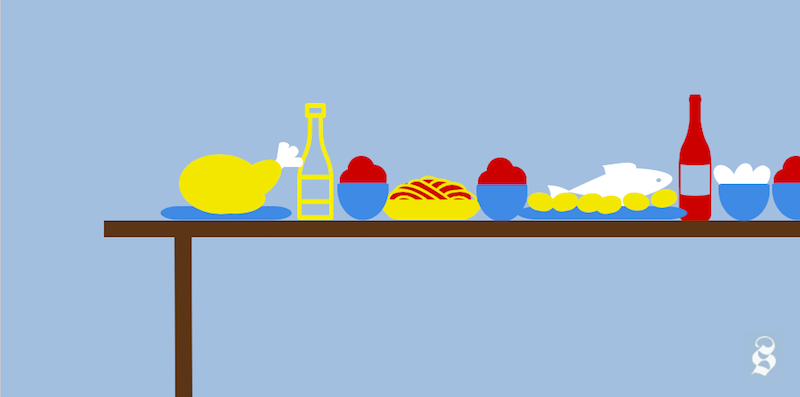Che poteri sono magistratura e stampa in Italia
Il politologo Mauro Calise spiega in un libro come si sono evolute e perché si somigliano, nel quartetto dei maggiori poteri delle democrazie

Laterza ha pubblicato il libro La democrazia del leader, di Mauro Calise, docente di scienza politica all’Università Federico II di Napoli, editorialista del Mattino e autore di diversi libri nei quali ha esaminato i cambiamenti di questi ultimi anni della politica italiana e del ruolo di partiti e leader dei vari schieramenti. In questo libro Calise analizza la crisi della democrazia in Italia, dove la personalizzazione della politica ha lasciato come unico ruolo ancora centrale e significativo nei processi decisionali quello dei leader, a scapito della democrazia rappresentativa e del ruolo del Parlamento.
Questo è il capitolo intitolato Il fattore M, in cui Calise analizza gli sviluppi paralleli dei ruoli della magistratura e del sistema dei media.
***
Nei testi di repertorio sulle democrazie contemporanee, si dà unanimemente per scontato che si reggano su quattro poteri. I tre canonici di Montesquieu, più il sistema dell’informazione a presidio della libertà d’opinione. Quattro pilastri tutti indispensabili per un corretto funzionamento. Si aggiunge sempre, subito dopo, che per la stabilità e l’efficienza è necessario che ci sia, tra i poteri, un equilibrio, quella balance of power che da sempre viene considerata il fondamento di ogni regime liberaldemocratico. Poi, però, si registra uno scarto, di analisi e di prospettiva, che porta a concentrare l’attenzione molto più sui primi due poteri che sugli altri due. Sappiamo meticolosamente come funziona il parlamento, e come e perché si modifica il suo rapporto con l’esecutivo. Da un’analisi anche superficiale della letteratura in materia, emerge che, invece, sappiamo, in proporzione, molto meno su come concretamente opera la magistratura. In parte ciò dipende dalla frammentazione dell’organismo giudiziario, e dalla sua complessa stratificazione. Ma, in buona misura, è anche una conseguenza del fatto che, in questo caso, il quadro prescrittivo tende a fare aggio su quello empirico.
Ci si accontenta, cioè, di ribadire l’indipendenza della magistratura, e la necessità che operi nella più piena autonomia. Con l’implicita considerazione che, una volta salvaguardato questo fondamentale principio, le conseguenze restino conformi al dettato costituzionale. Tutt’al più aggiungendo, a margine, qualche accorata considerazione sulle lungaggini e inefficienze che scandiscono l’iter giudiziario. Nei casi migliori inquadrandole in una tabella comparata, in cui, quasi sempre, l’Italia rappresenta il fanalino di coda. Senza però che questi costi – sociali, economici, umani – del sistema giudiziario varchino mai la soglia della impotente lamentazione e della – altrettanto inconcludente – vaga proposta di riforma. Con una prima importante conseguenza, nella percezione del pubblico, rispetto al trattamento riservato al governo e al parlamento. Per entrambi questi organi, infatti, pregi e difetti vengono adoperati per perorare mutamenti anche radicali. La magistratura, al contrario, resta intoccabile. Pena il rischio che venga messo in discussione il tabù della sua autonomia. Qualsiasi proposta di correttivo deve comunque avvenire entro il perimetro – le procedure e gli attori – dell’autogoverno. Finendo così col sancire, accanto all’indipendenza, anche l’irresponsabilità nei confronti di un attore terzo: che sia il governo, il parlamento, o il popolo sovrano da cui entrambi questi istituti derivano la loro legittimità. In questo, la magistratura conserva – pienamente e insindacabilmente – il suo statuto pre-democratico.
Analoghe considerazioni si applicano al quarto potere, i media. Anche se il riconoscimento costituzionale del ruolo della stampa è frammentario, non vi è dubbio che, a tutti gli effetti, una stampa pluralista e indipendente rappresenti una condizione necessaria, anche se non sufficiente, di un moderno ordinamento democratico. Per verificare, tuttavia, la corrispondenza del sistema mediatico ai compiti cruciali cui è preposto esistono ben pochi canali, e ancor meno numerosi criteri. Il dibattito tende a concentrarsi sul potere delle reti televisive, soprattutto quando – come nel caso italiano – sono in misura sostanziosa di proprietà pubblica. È su questo fronte che si sviluppa e si anima lo scontro su quante siano le risorse, come vengano raccolte e distribuite e, più o meno professionalmente, utilizzate. A parte questo – importante – segmento del sistema mediatico, non esiste, tuttavia, un attore politicamente sovraordinato alla stampa. Si può – anzi, si deve – legittimamente sostenere che un simile ruolo sarebbe contrario alla funzione originaria dei media, di controllori – watchdogs – della sfera pubblica. Una funzione cui possono adempiere solo godendo di piena autonomia. E ogni volta che tale autonomia viene infiltrata da pressioni politiche, la qualità di una democrazia tende irrimediabilmente a peggiorare.
Nondimeno, sul piano dell’equilibrio tra i poteri, i media, come la magistratura, si caratterizzano per essere indipendenti da controlli che non siano quelli che essi stessi esercitano su se stessi, o i loro concorrenti. Un sistema autoregolamentato su cui il pubblico può intervenire attraverso solo due delle opzioni hirschmaniane: o restando fedele ai propri ascolti, o abbandonando la partita. Due canali importanti, che escludono tuttavia quello principale: la protesta, che contraddistingue il rapporto tra i cittadini e gli altri due poteri, governo e parlamento. In questo senso, anche nel caso dei media il principio fondativo dell’indipendenza può sconfinare nell’irresponsabilità. Una irresponsabilità limitata da meccanismi interni di regolamentazione ma, comunque, distinta dal principio di responsabilità nei confronti della volontà popolare che è a fondamento di parlamento e governo. I quattro poteri si presentano, dunque, diversi al vaglio del criterio democratico. Nel caso di governo e parlamento, il tratto dominante è quello della subordinazione ai circuiti della legittimazione elettorale. Per magistratura e media, prevale l’elemento della autonomia e indipendenza.
La coesistenza tra responsabilità e autonomia è alle radici del fatto che i regimi contemporanei vengono etichettati come liberaldemocratici, ispirati, cioè, a due principi diversi – anche se complementari – di legittimazione. Quello del comando popolare e quello della libertà individuale. Dal loro equilibrio dipende il tasso di democraticità o liberalismo. Ma anche, più in generale, le caratteristiche – e gli attori – che finiscono col prevalere. Se si guarda in retrospettiva, sul piano della costituzione materiale, il vero spartiacque segnato dall’avvento della Seconda Repubblica riguarda il riequilibrio dei poteri tra media e magistratura da una parte, e governo e parlamento dall’altra.
Come tutti i cambiamenti importanti, si tratta di un mutamento silenzioso, poco e male codificabile nel discorso pubblico dominante, e anche nelle analisi scientifiche, restie ad affrontare un tema difficile da quantificare e ostico da concettualizzare. L’ascesa del fattore M sulla scena politica italiana è, in parte, legato al declino del parlamento. E alle difficoltà del governo nel surrogarne il ruolo in modo soddisfacente. Ma, in misura molto maggiore, discende dalla strettissima simbiosi che si è venuta a creare col potere mediale, finendo con l’alimentarsi a vicenda.
Il ruolo politico della magistratura è stato, infatti, negli ultimi venticinque anni strettamente dipendente dalla amplificazione mediatica. Alcuni precedenti di rilievo si erano già registrati, negli anni della Prima Repubblica, con il protagonismo dei pretori d’assalto. La prima leva di magistrati a sfidare apertamente il connubio – invisibile ma ben tangibile – tra i vertici dell’apparato giudiziario e quelli dell’establishment politico. Ma è con la crisi di Tangentopoli che si assiste al repentino prorompere sulla scena delle toghe come protagoniste delle svolte chiave della transizione italiana. Il pool di Mani Pulite si afferma come il principale avversario dei partiti di governo e del loro ceto parlamentare, assurgendo nell’immaginario pubblico a simbolo dell’azzeramento e rinnovamento del sistema.
Alla simbiosi tra media e magistratura sulle rovine della Prima Repubblica concorrono diversi fattori. In primis, la drammatica notiziabilità del fenomeno, con centinaia di parlamentari inquisiti, i vertici dei partiti decapitati, la tragica fine di alcuni degli imputati. Ma non meno importante è il fatto che gli eventi che cambieranno l’Italia si attagliano perfettamente al linguaggio preferito dei media: il linguaggio della personalizzazione. Al centro del terremoto giudiziario ci sono nomi e cognomi, storie più o meno illustri ma sempre riconducibili al profilo individuale che, nella media logic, è l’archetipo della comunicazione efficace. In un crescendo bulimico, la dinamica del capro espiatorio, da sempre il palinsesto preferito delle campagne di stampa, si moltiplica ad infinitum. Al posto della generica accusa al fallimento di una classe dirigente, si afferma l’impianto accusatorio, personale e circostanziato, di una lista di proscritti eccellenti.
A questo fattore sistemico se ne aggiunge uno congiunturale e, almeno nella sua esorbitante misura, imprevedibile. Un fattore che diventerà un volano eccezionale della sinergia tra i poteri di stampo individuale-liberale. Il prorompere di Silvio Berlusconi, col suo carico di pendenze giudiziarie e il suo impero televisivo, costituisce il detonatore di una polveriera che già era in piena carburazione. Per il sistema inquisitorio della magistratura, la discesa in campo di Berlusconi e la sua rapida ascesa a Palazzo Chigi si rivela un’occasione eccezionale per potere prorogare il modello di Tangentopoli. Adattandolo al nuovo contesto politico-istituzionale: non più la destrutturazione e fuoriuscita dalla Prima Repubblica, ma l’instaurazione e il tentativo di consolidamento della Seconda. In questo ruolo, la magistratura inquirente – ma anche quella giudicante – entrano a pieno titolo tra i soci fondatori del nuovo regime politico. Non ci sarà fase – ascendente o declinante – della parabola di Berlusconi – come capo di Forza Italia o come primo ministro, in Italia o sulla scena internazionale – che non verrà scandita e condizionata da un catalogo inesauribile di vicissitudini giudiziarie.
In questa incessante attività, pm e giudici troveranno un alleato naturale quanto micidiale nella stampa, che coglierà nel berlusconismo l’occasione di perpetuare e rafforzare il modello emerso nel collasso della Prima Repubblica: la leadership come fattore di mobilitazione e identificazione dell’immaginario collettivo. Il movimento referendario aveva mandato in soffitta lo schema della contrapposizione ideologica tra i vecchi partiti di massa. La fulminante parabola di Mario Segni aveva fatto intravedere, per la prima volta nell’Italia repubblicana, il potenziale palingenetico di un capo investito di una forte ed entusiastica legittimazione popolare. Con Berlusconi, cambieranno i contenuti del messaggio: all’inizio la rivoluzione liberale, poi la diga contro il comunismo, quindi l’elogio del pragmatismo. Ma verrà consolidato e dilatato il potenziale di rinnovamento come qualità non di un’organizzazione – partito, parlamento, governo – ma di un uomo, e del suo carisma.
L’imprenditore finito nel mirino della Procura di Milano era lo stesso che prometteva di cambiare il paese a propria immagine e somiglianza. Un cortocircuito esistenziale che ridefiniva, in pochi mesi, archetipi culturali decennali. A tutto vantaggio dei media che potevano, finalmente, sottrarre la narrazione dell’identità italiana al monopolio delle oligarchie, ancorandolo alle gesta di un mattatore solitario. Dall’Italia dei partiti a quella del Cavaliere, con molte macchie ma senza paura. E un implacabile nemico: la magistratura.
La presa totalizzante del berlusconismo sul sistema politico italiano nasce da questa perfetta sinergia tra i due poteri personalizzanti, e dalla resa – inconsapevole quanto incondizionata – del potere corporativo fino a poco prima egemone, quello partitico parlamentare. L’accelerazione italiana rispetto a un trend che coinvolge le principali democrazie origina in questa incapacità – culturale, organizzativa, ideologica – di comprendere, mitigare, incanalare la crescita del fattore M. Al contrario, l’intreccio tra media e magistratura viene visto dalla sinistra superstite come l’unico argine residuo allo strapotere del Cavaliere. Scambiando un mutamento sistemico per uno spartiacque morale. È nota la lista dei fattori che concorrono a questo abbaglio. Dall’eccezionalismo geopolitico che aveva consentito all’Italia democristiana e comunista di restare per mezzo secolo un’enclave partitocratica inviolabile, all’istinto di autoconservazione di una oligarchia abituata a riprodursi per partenogenesi, fino al mito della diversità fondata sulla morale e, quindi, affidata – per definizione – alla denuncia e alla curatela mediatico-giudiziaria.
Il risultato di questa impasse e autodafé del ceto partitico parlamentare diventerà palese e incontrollabile con la crisi del berlusconismo. Che, invece di restaurare il potere politico corporativo, ne registrerà l’implosione. Prima Monti, poi Grillo, infine Renzi sanciranno l’inadeguatezza dei vecchi partiti a controllare le leve – decisionali e di legittimazione – del nuovo regime. E ribadiranno il ruolo preponderante di media e magistratura nel dettarne le scadenze e l’agenda. La giuridificazione della politica e, per converso, la politicizzazione dell’azione giudiziaria diventeranno la chiave dei passaggi più importanti, investendo rapidamente ogni arena. Da quella strettamente partitica, col Movimento 5 Stelle che diventa il primo partito italiano con una piattaforma incentrata sulla lotta alla corruzione e alla sua amplificazione attraverso l’integrazione di vecchi e nuovi circuiti mediatici. A quella del policy-making, con gli interventi della Corte costituzionale che amputano le prerogative legislative costringendo l’esecutivo sulla difensiva di fronte a partite cruciali per le sorti dell’economia nazionale. Fino all’aperta invasione di campo in occasione delle elezioni regionali, con l’invenzione di profili di colpevolezza sub-giudiziari e paraistituzionali, come la categoria degli «impresentabili», che monopolizzano l’agenda mediatica e condizionano pesantemente l’esito della competizione.
La caratteristica principale – e più inquietante – del fattore M è la sua congenita impoliticità. Vale a dire, la sua naturale estraneità alle forme tradizionali di partigianeria. La tendenza diffusa è nel vedere nel giustizialismo un fenomeno di sinistra, facendo riferimento alle posizioni ideologiche manifeste di molti protagonisti. Uno degli argomenti più usati dal centrodestra per difendersi dal ciclone di Tangentopoli è stato che i magistrati – e gli organi di stampa – avevano usato due pesi e due misure. Lasciando sostanzialmente – anche se non del tutto – fuori dai principali filoni investigativi i parlamentari del Pci. Ma questo metro di giudizio si rivela del tutto fuorviante se – piuttosto che alle supposte intenzioni – si guarda agli esiti. E quello più plateale e incontrovertibile della rivolta giudiziaria e mediatica contro la corruzione politica è stato la rapidissima ascesa al governo di Silvio Berlusconi. Un leader che la stampa stessa e la magistratura si sono affrettate ad accusare di misfatti analoghi, e in molti casi peggiori, di quelli che avevano imputato al vecchio ceto politico. Non c’è che dire: come strategia di sinistra, il risultato è stato proprio azzeccato.
Per non parlare del quadro attuale, il panorama dell’Italia post-berlusconiana misurato con le statistiche della corruzione. Rispetto a vent’anni fa, le analisi più autorevoli concordano su un diffuso deterioramento. A partire dalle caratteristiche portanti, in cui gli interessi e le reti individuali si sono sostituite a quelle che, più o meno direttamente, facevano capo ai partiti. Il ritratto delle tangenti intascate per finanziare l’organizzazione, al centro o nelle sue correnti, appare quello di un’epoca lontana, in cui l’appartenenza a un gruppo – a un corpo – poteva fungere da alibi per i comportamenti devianti. Oggi, i passaggi di mano – e di portafoglio – avvengono con logiche politiche trasversali, in cui l’unica appartenenza che conta è quella, contingente e personale, a uno snodo istituzionale che controlli un flusso di risorse pubbliche.
Nel contrastare questo fenomeno, media e magistratura appaiono un mix di sant’Agostino e Sisifo. Sia per la vastità del mare del malaffare, sia per la inadeguatezza dei mezzi. Gli interventi della magistratura riescono a intercettare e a fare emergere solo la punta di un sistema che resta prevalentemente sommerso. Vuoi per la complessità delle indagini, vuoi per la ristrettezza dei mezzi investigativi disponibili, il numero dei procedimenti attivati riesce a malapena a scalfire l’iceberg della corruzione politico-amministrativa. Un limite ulteriormente accentuato dai tempi dei processi che, tra lungaggini dibattimentali e la tagliola della prescrizione, solo in pochi casi producono una sanzione rilevante. L’entità stessa della sanzione, del resto, va commisurata a quella del giro di affari messo in moto dalle persone a vario titolo incriminate. Come in tutti i comportamenti devianti, il prezzo della pena acquista un suo valore solo relativamente al volume degli introiti dell’attività illecita. E, nella gran parte dei casi, può essere considerato come un costo inerente il rischio di impresa. Rispetto a questa logica sistemica, che coinvolge un elevato numero di attori e una notevole posta di bilancio, le indagini ordinarie della magistratura si sono mostrate, fino ad oggi, un deterrente insufficiente.
Paradossalmente, la situazione non migliora quando interviene l’amplificazione mediatica. Che può, invece, portare alcuni peggioramenti. Il risalto sulla stampa di un’inchiesta può infatti, nell’immediato, apparire come un fattore di rafforzamento dell’azione della magistratura. E certo può fornirle uno scudo di consenso e di legittimazione popolare nei confronti di eventuali pressioni da parte di qualche autorità politica interessata a frenare lo sviluppo delle indagini. Ma, rispetto a questo beneficio iniziale e temporaneo, intervengono altri fattori meno favorevoli, e più durevoli.
In primo luogo, l’alta visibilità sulla stampa di comportamenti incriminati in una città può mettere sull’avviso coloro che si trovassero coinvolti in un’analoga situazione in altri luoghi della penisola. Con il rapido inquinamento di eventuali prove a carico. L’ingente e insistente attenzione pubblica convogliata sul network cosiddetto di Mafia capitale ha consentito che intrecci simili, molto probabilmente presenti in altre città, potessero essere – retrospettivamente e preventivamente – sanati, o almeno – anche solo parzialmente – mascherati. Questo insabbiamento a titolo cautelativo è facilitato dalla scarsa visibilità di molti dei protagonisti. La differenza principale tra la corruzione denunciata, e colpita, negli anni di Tangentopoli e quella emersa in questi ultimi anni è che, allora, si trattava di un fenomeno prevalentemente concentrato al vertice dei partiti. Sia perché i traffici illeciti avvenivano con il beneplacito, e spesso il tramite, di personalità di rilievo nell’organigramma locale e nazionale. Sia perché, in larga misura, erano le casse dei partiti il principale destinatario delle tangenti provenienti dal mondo delle imprese. Oggi, invece, la microimprenditorialità della corruzione coinvolge i livelli intermedi, poco o per niente noti al grande pubblico, e anche per questo molto meno esposti all’effetto domino che falcidiò in pochi mesi, sotto la scure di poche procure, oltre metà della classe parlamentare italiana.
Un ulteriore limite del fattore M nel combattere la microcorruzione politica consiste nella saturazione mediatica. Riferita ad un consigliere regionale o comunale, la notiziabilità di un avviso di garanzia o di un rinvio a giudizio può durare solo poche giornate. È in questo breve lasso di tempo che va raggiunto il risultato. Se non intervengono le manette, il politico sotto accusa entra nella zona d’ombra di un iter processuale lunghissimo, del quale si perderanno rapidamente le tracce. Salvo tornare – ma molto più marginalmente – sui giornali nel momento della condanna definitiva o, più spesso, del proscioglimento. Col risultato che il combinato disposto di un intervento della magistratura amplificato dal risalto mediatico avrà sortito, nella maggioranza dei casi, scarsi effetti specifici e individuali ma un consistente quanto generico aumento del discredito nei confronti dell’intera classe politica. Rafforzando, al contempo, il sentimento di alienazione e di impotenza in quanti avevano puntato sul fattore M per fare, come si dice in gergo, pulizia.
Di fronte a risultati, sul piano sistemico, così deludenti, non sorprende che il fattore M tenda a privilegiare, nella scelta dei suoi obiettivi politici, personalità di maggior calibro istituzionale. Anche in questo caso, l’elemento scatenante principale non è un pregiudizio partitico. Il numero dei procedimenti a carico di Berlusconi ha indotto ripetutamente a parlare di un accanimento giudiziario da parte delle toghe rosse. Ma un trattamento non molto migliore è stato riservato a politici di spicco della sinistra – da Romano Prodi ad Antonio Bassolino a Vincenzo De Luca – da magistrati non necessariamente di destra. Anzi, in alcuni casi, assurti a responsabilità di governo nel campo del centrosinistra. In tutti questi casi, il battage mediatico a supporto dell’azione della magistratura è venuto soprattutto da organi di stampa dell’area progressista.
L’unica motivazione comune a stampa e magistratura è la visibilità del bersaglio. Per elementari quanto fisiologiche ragioni di efficienza ed efficacia dell’intervento. In un regime di indipendenza politica, al di fuori cioè dal sistema di pressioni e di veti che aveva caratterizzato l’età d’oro della egemonia partitocratica, e in un contesto in cui le principali cariche politiche sono di tipo monocratico, il fattore M individua nei leader il principale oggetto – soggetto – della propria attenzione. Quanto maggiore è il loro peso, tanto più cresce la tentazione di metterli sotto tiro, e sotto torchio. Una lezione che in America, antesignana della democrazia del leader, hanno imparato da molti anni. E che si sta facendo strada anche da noi. Dove ogni aspirante alla poltrona di sindaco o governatore – e di presidente del Consiglio – sa di dover mettere in conto, prima o poi, un avviso di garanzia. Per difendersi contro il quale ha due strumenti. Un agguerrito collegio di difesa. E un ampio supporto popolare. Consapevole che, sotto l’attacco del fattore M, anche il leader di maggior successo può trasformarsi rapidamente in un leader solitario.
© 2016, Gius. Laterza & Figli