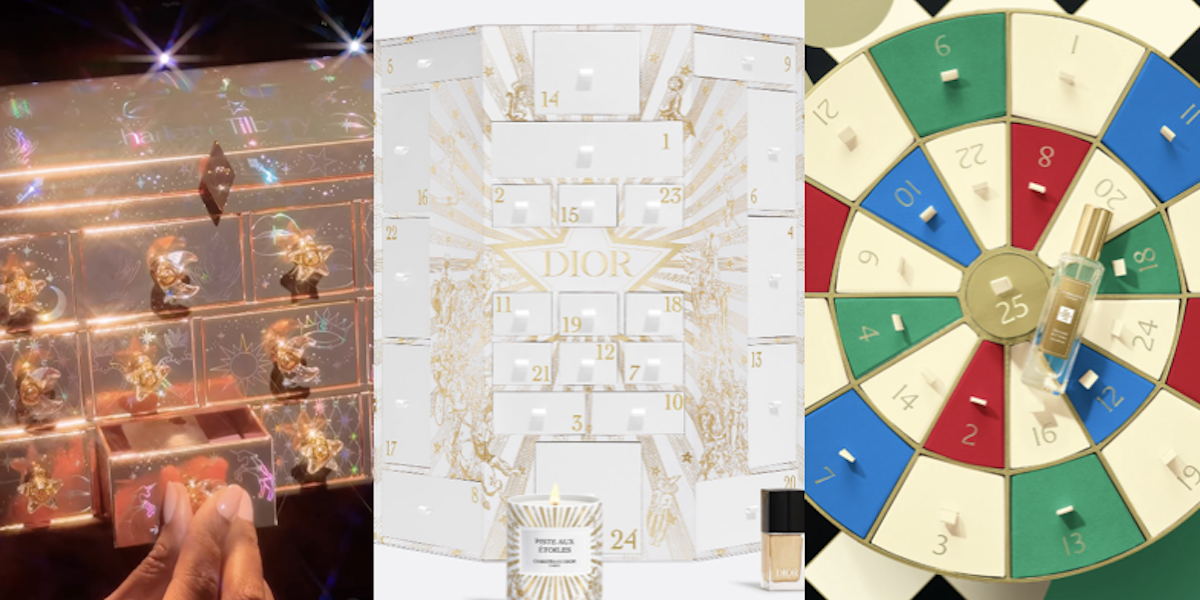I giornali di Adele Cambria
Il racconto delle eccezionali esperienze professionali e umane della giornalista morta ieri a 84 anni, tratto dalla sua autobiografia

Adele Cambria, giornalista e scrittrice che aveva partecipato al racconto ma anche alla costruzione di molta parte della storia e della cultura italiana soprattutto tra gli anni Cinquanta e Settanta, è morta a 84 anni giovedì. Nel 2010 aveva pubblicato per l’editore Donzelli un’autobiografia intitolata “Nove dimissioni e mezzo“, nella cui introduzione era già evidente la straordinaria varietà di esperienze e personaggi con cui aveva avuto a che fare in quegli anni.
*****
Marzo 2009
Arrivo verso mezzogiorno alla redazione de «l’Unità». La porta a vetri dove a quest’ora c’è la riunione per dare forma al giornale di domani è chiusa. Non oso aprirla. Mi rivedo, abusivamente, in Concita… Nei suoi 45 anni, nei suoi capelli biondi scarruffati, nei suoi quattro figli… (Abusivamente, certo, semmai fosse stato possibile, quando avevo io 45 anni, anche soltanto immaginare una donna alla direzione di un quotidiano, e con quattro figli!!!).
Mi dico che forse anche lei «non osa»: non osa dirmi che la riunione è riservata ai capiservizio, o ai loro vice. I miei capelli bianchi, mi chiedo, li vive come una specie di intimidazione?
Quando le cose andavano bene, e il suo arrivo come direttore di un giornale in crisi, la sua energia, il suo buon senso luminoso (e la scrittura, una scrittura che accompagna la vita, semplicemente) riaccendevano la voglia di fare anche in chi l’aveva perduta, allora, in quelle prime settimane entusiasmanti, entravo quasi senza scrupoli nella stanzaccia delle riunioni; non mi era mai venuto in mente, prima, di farlo, con gli altri direttori. (Perché mi intimidivano o perché mi ignoravano?).
Anche se Furio Colombo lo conoscevo fin dai tempi remoti de «Il Mondo» di Mario Pannunzio, dove scrivevo, dal 1956, colonnine di costume. Si chiamavano così. E qualche volta Pannunzio me le faceva firmare con uno pseudonimo maschile. Diceva che firmavano troppe donne, su «Il Mondo» (!). Io ne ricordo soltanto tre: la prima, Nina Ruffini, piccola, con i capelli bianchi ondulati e gli occhi celesti, e i suoi tailleur da suffragetta, uno stile mitigato – e sembra difficile – dall’austera genealogia piemontese; la seconda, la maestra sarda Maria Giacobbe, che dalla Danimarca inviava il suo «Diario di una maestra» (la leggevo, ma non la vidi mai); e la terza, la più presente nella mia vita – non oso chiamare il suo numero, temo di sapere… – ed è Giulia Massari: un pilastro della redazione, con la sua ironica diffidenza, il suo understatement (anche questa parola l’ho imparata in via della Colonna Antonina 52, dov’era la solenne sede del settimanale). Talmente snob, Giulia, che di rado si firmava con nome e cognome. Era «L’invitato». Il mio pseudonimo maschile lo scelse il direttore. Ero dunque, a volte, Leone Paganini, un leone per la forza che esprimevo: lo disse il direttore, inaugurando il mio nom de plume. Forse alludeva al coraggio – ma era piuttosto incoscienza – che mi aveva spinto da Reggio Calabria a Roma; in quanto al cognome, Paganini… A quel punto Mario Pannunzio sviolinava nell’aria con le sue mani bianche, curatissime, ed era detto tutto! Tempi favolosi, vivevo nel miracolo, qualcuno disse che camminavo sospesa a dieci centimetri dal suolo. E non dipendeva dai tacchi…
Ma ora? «l’Unità» è di nuovo in crisi: pre-pensionamenti, esuberi, giovani precari che hanno ricevuto le lettere di preavviso per il licenziamento. In quanto a me, ho un contratto a tempo indeterminato, ma sono pagata a cottimo, 35 euro lordi a pezzo, per la cronaca romana, un massimo di 70 euro («comminato» di rado) per «l’Unità Grande», come la chiamo io. Ma – ovviamente – ho anche la pensione di giornalista professionista iscritta all’albo dal 1° aprile 1959: il giorno che tocca i 1500 euro, se sono ancora viva, faccio una festa… E pensare che nel 1960 guadagnavo 200 000 lire al mese, una cifra…
…Ho deciso: oggi non ci provo neppure ad affacciarmi alla riunione, vado in cronaca romana, che è poi il mio luogo di appartenenza: il rischio di prendermi in carico l’ha affrontato, sei anni fa, Jolanda Bufalini, responsabile della redazione.
Sulla porta ingiallisce un’etichetta, «Cronaca romena»: che, in anticipo sui fatti, diciamo sull’epopea nera degli stupri quotidiani, segnalava la sfida al razzismo di questi ragazzi e ragazze ora sull’orlo della disoccupazione.
«Quanti ne hanno trovati ieri in Romania di stupratori con il Dna etnico?».
Si scherza, ma c’è un clima di malinconia diffusa, niente rabbia, questi ragazzi ci credevano, «l’Unità», fondata da Antonio Gramsci, come può fargli questo?
Per fortuna entra Andrea ed esplode, furioso e sprezzante: «I braccianti di Di Vittorio – (allude allo sceneggiato tv appena andato in onda…) – quelli sì che si ribellavano, noi invece zitti e muti, che vergogna… Scriviamo dei precari dei call-center, ma nessuno parla dei precari de “l’Unità”… Mia madre mi ha chiesto: e voi, non dite niente? Lei è stata una ragazza della Fgci, ai suoi tempi…».
È il mio momento. Posso sfoggiare le dimissioni da «Paese Sera», che mi impose il direttore, Fausto Coen. Erano i primi di novembre del 1962, avevo avuto il secondo figlio a fine maggio ed ero tornata a lavorare ad agosto. «Sei la stella di “Paese Sera” – mi disse quell’estate Franca Valeri. – Anche la foto in prima pagina! E con Sartre!».
…Ero giovane e avevo intervistato Jean-Paul Sartre. Aveva voluto che lo raggiungessi a Capri e mi aveva presentato Arlette El Kaim, una ragazza algerina, pallida, con grandi occhi neri e le occhiaie viola. Non aprì mai bocca durante la conversazione. Mi meravigliai perché Simone de Beauvoir era rimasta a Roma. Decenni dopo, anzi, praticamente soltanto ora, ho saputo… Leggendo Le sorelle Beauvoir di Claudine Monteil. Simone era diventata, come nella tradizione e spesso purtroppo anche nelle leggi dei paesi musulmani, non altro che «la prima sposa» di Sartre. Il quale adottò, nel 1967, la sua giovanissima amante, l’unica persona, dopo la morte del filosofo nel 1980, che ne porta oggi il cognome; e che riscuote i diritti d’autore. Ma la generosa Simone scrisse La cerimonia degli addii, un libro tenero e crudele, in ricordo dell’uomo di cui aveva prefigurato l’avvento nella sua esistenza quando aveva diciotto anni… (Dai Cahiers de jeunesse, 1926: «È l’amore più difficile, ma forse il più fecondo… Quello di un essere di valore quasi eguale al vostro… Assomigliargli, lavorare per lui, avere un piccolo posto ai suoi occhi… È come avere una fede»).
In quell’autunno del 1962 a «Paese Sera» tutto era cambiato. E il direttore me lo spiegò. Era simpatico, Coen, con quegli occhi celesti da bambino e i capelli bianchi. Lo ammiravo perché, con lealtà, difendeva la sua appartenenza ebraica, pur se il Pci – di cui, ma allora non lo sapevo, non aveva la tessera – già inclinava verso il sostegno politico ai paesi arabi. E quando esplose la guerra del 1967, dichiarata dal dittatore egiziano Nasser contro Israele, Coen lasciò il giornale…
Timidamente, dopo qualche mese dalla mia assunzione, nel luglio del 1960, gli avevo espresso il desiderio di iscrivermi al Partito, e lui mi aveva lanciato un lungo sguardo compassionevole, e mi aveva chiesto: «Ma lei vuole rinunciare a scrivere liberamente?». Non presi la tessera, ma pensai: nel Partito non mi vogliono, sono troppo frivola…
La spiegazione fu dunque questa: il 27 ottobre era caduto, a Bascapè (Pavia), l’aereo di Enrico Mattei – un incidente o un sabotaggio? – e Mattei era l’unico presidente di un ente pubblico, l’Eni, che dava la pubblicità ai giornali di sinistra. Inoltre, «Paese Sera» aveva appena lanciato il suo gemello milanese, «Stasera», ed aveva assunto perciò altri 80 giornalisti a Milano.
«Lei è così brava – esordì Coen – che può lavorare nei migliori giornali borghesi. Poi ha avuto un bimbo da poco e le farà piacere goderselo…». Diedi le dimissioni che mi chiedevano, visto che non potevano licenziarmi a causa delle leggi di tutela della maternità. «Altrimenti saremmo costretti a licenziare un capofamiglia», aveva concluso Coen. Presi la liquidazione a rate, e mi feci subito una lunga epatite B. (Del perché ero uscita da «Paese Sera» non raccontai nulla per dieci anni, per non danneggiare la sinistra. Fu l’onda alta del femminismo – «Non c’è rivoluzione senza liberazione della donna» – a sprigionare anche quel segreto. Tra i tanti, nei gruppi di autocoscienza).
Diventai tutta gialla in una notte.
Avevo tempo per pensare, una torre di nausea si elevava dal mio corpo sperduto nel letto della Clinica Nomentana dove ero ricoverata. (I figli, con la bambinaia, erano partiti per la Calabria, al sicuro da un possibile «contagio»; ancora una volta a casa di mia madre). Riflettevo su come Enrico Mattei, un personaggio già mitico, fosse entrato per la seconda volta nel mio destino. Infatti, mi ero dimessa, la prima volta, da un giornale – «Il Giorno» di Gaetano Baldacci – per solidarietà con il suo fondatore e direttore. Il presidente dell’Eni aveva dovuto cedere alle pressioni politiche dell’influente senatore liberale Giovanni Malagodi, che si opponeva strenuamente alla nascita del centro-sinistra, e a quelle, impositive, di Antonio Segni, presidente del Consiglio; e aveva licenziato l’uomo che aveva avuto il coraggio di immettere una nuova leva di giovani e nuove idee, nel giornalismo italiano. Cioè Gaetano Baldacci.
…Avevo visto Mattei a un ricevimento al Quirinale per lo scià di Persia. Quella sera nei saloni del palazzo ex pontificio di Montecavallo fui molto più impressionata da lui che dallo scià, che cominciavo a disprezzare per il ripudio di Soraya. Baldacci mi presentò Mattei; ormai lo sapevano tutti che la proprietà de «Il Giorno» era dell’Eni. Anche se un giovanissimo e brillante redattore del quotidiano milanese, Gianluigi Melega, era stato licenziato in tronco per averlo scritto in un libro – lui disse che era «soltanto un romanzo». Rivedo Gigi, tutto ridente, in una caotica stanza di via Settala 22: disse che addirittura l’editore che doveva pubblicarlo, Parenti, aveva chiuso… Questi sono i miei ricordi di allora, le chiacchiere di redazione; poi, trentacinque anni più tardi, Melega ha pubblicato la sua saga autobiografica: un’epopea in sei volumi, e c’è dentro tutto, anche la nascita de «Il Giorno» in via Settala; indimenticabile, da pagina 69 a pagina 72 del volume intitolato Tempo lungo. L’anima m’hai venduto, lo schizzo «espressionista» dei primi mesi di vita di quel quotidiano rovente, capitanato da un uomo leggendario, Baldacci, «con la sua capacità magnetica di convincere chiunque…».
…Nei ricevimenti al Quirinale mi colpiva sempre quello che, certamente, poteva sembrare un trascurabile dettaglio e che invece, da cronista ahimè mondana, notavo con qualche raccapriccio: e cioè com’erano malvestiti i nostri parlamentari, i Dc soprattutto, con spille da balia che trattenevano i pantaloni sotto le code del frac, e peggio erano imbacuccate le loro mogli. (Ma forse era meglio così, a scanso di tangenti, o no?). Quella sera Mattei e Baldacci parlavano apertamente – io ascoltavo – di come fosse indispensabile, nel panorama della stampa italiana, un grande quotidiano che perseguisse gli interessi dello Stato; gli altri due, il «Corriere della Sera» e «La Stampa», appartenevano a potenti famiglie dell’industria italiana, i Crespi (proprietari del «Corriere») e gli Agnelli (proprietari della «Stampa»); e da entrambi era partito l’attacco a Mattei. Il senatore Giovanni Malagodi arrivò a definire «Il Giorno» «una mantenuta da 100 miliardi», e Mattei, venendo allo scoperto, replicò: «Ci sono grossi complessi industriali che posseggono potenti organismi giornalistici… Anche l’industria statale ha il diritto di avere un portavoce che spieghi al pubblico ciò che è stato fatto, e ciò che si farà».
Senza contare che Baldacci, nei suoi brevissimi editoriali – sessanta righe – intitolati «Situazione», chiedeva da tempo un governo di centrosinistra: Dc-Psi.
Come racconta Italo Pietra nella sua biografia del presidente dell’Eni, «Mattei, a mano a mano che sale è esposto ad attacchi sempre più forti… e si sente solo, senza difesa, senza una base per un contrattacco efficace». Peccato che l’autore di questa biografia non abbia mai detto come e perché accettò di sostituire Baldacci, dopo che il presidente del Consiglio, criticato più volte su «Il Giorno», ne aveva chiesto con insistenza la testa.
Non c’ero quella sera di fine dicembre del 1959 in cui il direttore riunì la redazione per annunciare che se ne andava. Ero a Saint-Moritz, dove lui mi aveva comunque spedita per descrivere le feste di fine d’anno del nascente jet set… La scoperta del lago ghiacciato su cui trottavano, scampanellando, a mezzanotte, i cavalli che trainavano le carrozze dei vip, rischiarate da rosse lanterne, segnò l’acme di un sogno che, ormai lo sapevo, stava per finire.
Tornai a Milano, i colleghi mi raccontarono quell’ultima riunione commossa: ad ascoltare le parole drammatiche di un direttore molto amato, soprattutto per la passione che metteva nell’Utopia di un giornale nuovo, per una nuova società, per un nuovo paese, tutti, a cominciare dal caporedattore – Angelo Rozzoni, il pulsante motore del quotidiano –, avevano le lacrime agli occhi. (Rozzoni, che ci teneva alla sua fama di «duro», si infilò gli occhiali neri per nasconderle). Tutti giurarono fedeltà al direttore e promisero di seguirlo in nuove avventure. Ma il 6 gennaio del 1960, quando Pietra si insediò – dopo aver mostrato ai tipografi in sciopero la sua tessera del Psdi (socialisti saragattiani) per rassicurarli – ci dimettemmo soltanto in due: io e Sirio Musso, un vecchio pittore di Brera, dal volto che sembrava intagliato in un antico tronco di ulivo.
La notte, negli scantinati di quel palazzetto sdrucito di via Settala 22, che aveva ospitato «l’Avanti» fino alla soppressione del quotidiano socialista decretata da Mussolini, si confezionava il rotocalco de «Il Giorno». Il pittore di Brera curava la grafica del supplemento e litigava sull’arte contemporanea con gli altri due nottambuli di professione, Romeo Giovannini – collaborava al settimanale di Pannunzio, e del rotocalco faceva l’editing (in pratica, spesso, riscriveva tutto) – e il conte Ugo Tolomei, artefice di piccole sculture in fil di ferro – silhouette di cavalli al galoppo – e di chilometriche e spesso implausibili biografie di Marilyn Monroe e Rita Hayworth; che, sempre nottetempo, srotolava gemendo da una monumentale Underwood nera. Raccomando ai lettori di non perdersi le pagine che Melega, nel volume citato, dedica alla «Sezione rotocalco» de «Il Giorno» (pp. 107-11): «Buona, vecchia, cara, squilibrata sezione rotocalco!». Io pure ne ero incantata. E quando facevo tardi con le mie cronache delle «prime» alla Scala scendevo a scrivere il pezzo in cantina. Dove, battendo furiosamente sui tasti di un’Olivetti d’antan, raccontavo i palchi, la platea, il foyer delle «prime» alla Scala come una giungla di visoni, cincillà e petit-gris: qui circolavo, abbagliata dal fulgore dei gioielli delle «damazze», taccuino e penna branditi, coperta soltanto da un austero abitino Impero di chiffon grigio pieghettato. Era, dicevo, la mia «tuta operaia»: infatti, quando ero sbarcata a Milano con i miei tailleurini rosacipria, o blu Madonna, avevo capito subito che non era aria… Di rigore – almeno per le «vere dame» e non per le «damazze» – era il Balenciaga nero con broche di diamanti… E, per me – che aborrivo la targa di «cronista mondana» – la «tuta operaia», sia pure di chiffon. (In quegli anni Paolo Grassi la imponeva – quella vera – agli attori del Piccolo Teatro di via Rovello, ma dovette arrendersi davanti ai veli e al visone di Valentina Cortese, innamorata di Giorgio Strehler).
Intanto Milano marciava verso il miracolo economico: «Se Agnelli si arricchisce, sto meglio anch’io», mi diceva il tassista che mi riportava al giornale. Ma io che non avevo visto la città ai tempi della guerra, né la Scala distrutta dai bombardamenti, non sapevo nulla… No, Milano non poteva essere che quella, opulenta e vitalissima, che mi aveva accolta. E, semmai, ironizzavo sul cattivo gusto delle «damazze» arricchite – le donne, ahimè, erano ancora i bersagli più facili – e, per esempio, sugli smeraldi grossi come ciottoli della «Robiolina»… (E seguiva querela…).
Il 6 gennaio 1960 si chiudeva dunque la favola che avevo vissuto. A cominciare da quando a Roma, dove ero stata assunta in prova, a 38 000 lire al mese nel marzo del 1956, dal notista politico del nuovo quotidiano, Paolo Glorioso, e «sadicamente» istruita dal capocronista Alfonso Madeo su come-si-scrivono le notizie. (Si stavano facendo i numeri zero). Poi ero stata chiamata a Milano dal direttore in persona. Che un giorno chiese al capocronista, al telefono: «Ma chi è questa signorina Cambria? Brava è, a Milano deve venire, subito…». (Le sfumature dell’accento messinese del direttore furono eccellentemente imitate da Madeo, nel riferirmi, davanti a tutta la redazione, quella telefonata). E io partii. Non avevo mai visto Milano, arrivai in un giorno bollente di luglio, stavo lì con i tacchi a spillo imprigionati nell’asfalto che si scioglieva a piazza San Babila, ed ero felice. La domenica andavo in corriera a fare il bagno nelle acque scipite del lago di Como, io che ero cresciuta assaporando la salsedine delle onde freschissime dello Stretto. Ma non le rimpiangevo: il mio castello, miracolosamente conquistato, era in via Settala 22. Fu a Milano che mi trasformai (per breve tempo) da signorina Cambria in qualcosa che all’epoca non aveva ancora nome e soltanto decenni più tardi si sarebbe definita una single emancipata.
In quanto a me, nel momento in cui quest’espressione sarebbe diventata usuale, avevo già perduto un bel po’ di illusioni. Ma il primo a farmi dubitare del mio animo d’emancipata fu Pier Paolo Pasolini: quando, con dolcezza, decretò che sarei stata Nannina la Napoletana nel suo primo film, Accattone. Mi ribellai: «Io? Io sono una donna emancipata, non una succube che aspetta fedele un marito che va e viene dalla galera, e ogni volta che torna libero le pianta un altro figlio nella pancia!». Pier Paolo mi guardava con il sorriso di chi sa – e i veri poeti sanno – e io gli dissi di sì…
Tre settimane dopo il mio approdo in via Settala il direttore ci schierò tutti in fila in corridoio: aspettavamo la visita dell’editore, Cino Del Duca. (Che ci fosse anche Enrico Mattei nella proprietà era in quei primi mesi di vita del quotidiano soltanto una diceria). Del Duca arrivò, piccolo e saltellante, con le gambe ad arco come un fantino, il direttore ci presentò uno per uno, cominciando da me, l’unica donna in redazione; a quei tempi, per fortuna oggi remoti, di una «emancipazione» salutata come un fenomeno quasi da baraccone, essere donna poteva risultare persino un vantaggio. Così l’editore della presse du coeur francese (ma era stato un antifascista italiano in esilio a Parigi) si fermò davanti a me, mi strinse la mano, e poi, dandomi un leggero buffetto sulla guancia, esclamò: «Brava signorina Cambria! E mi raccomando… Varietà, sempre varietà!».