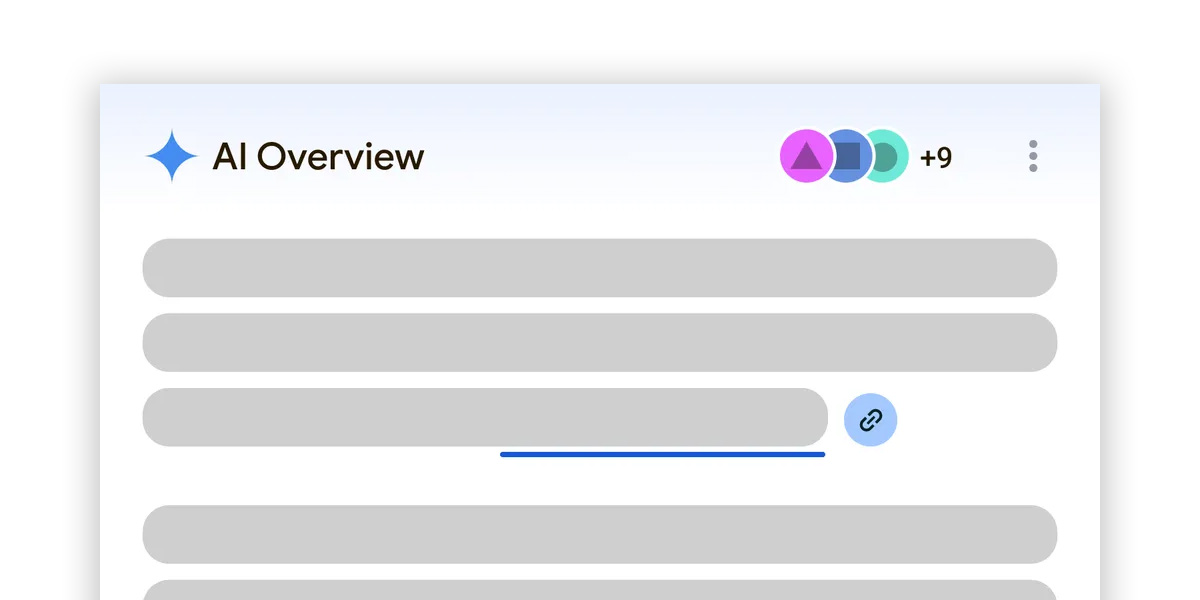L’ultimo libro di Henning Mankell
E il momento in cui l'autore, morto la settimana scorsa, si ricorda di quando da bambino capì di essere unico

Sabbie mobili. L’arte di sopravvivere – che esce per Marsilio il 15 ottobre, tradotto da Laura Cangemi – è l’ultimo libro di Henning Mankell, il popolare scrittore svedese morto nel sonno a Göteborg in Svezia nella notte tra il 5 e il 6 ottobre e autore di otto romanzi che hanno per protagonista il commissario Wallander. Il 29 gennaio 2014 Mankell, che era nato a Stoccolma nel 1948, aveva annunciato sul suo sito di avere un tumore al polmone e alla nuca, scoperto dopo essere andato da un ortopedico per un dolore al collo. Nei mesi seguenti aveva pubblicato sul quotidiano locale Gøteborgs Post una specie di diario della sua malattia, che è poi diventato il suo ultimo libro: “Ho deciso di scrivere di questa malattia”, ha scritto Mankell, “perché non riguarda solo me, ma tanti altri che si trovano nella mia stessa condizione. L’ho fatto con la prospettiva della vita, non della morte. È una riflessione su cosa significa vivere”. Nel capitolo che pubblichiamo, infatti, l’annuncio della fine rimanda all’inizio, a una mattina di 56 anni prima in cui il futuro scrittore è un bambino di nove anni che va a scuola dopo una notte di neve, e capisce all’improvviso di essere se stesso, una persona unica e irripetibile, come ogni altro essere umano. È da quel momento, dalla scoperta dell’identità, che “la vita diventa una faccenda seria”.
***
La grande scoperta
Nel caos emotivo in cui precipitai dopo che il torcicollo si era rivelato un cancro mi accorsi che spesso la memoria mi riportava all’infanzia.
Impiegai però parecchio a rendermi conto che voleva aiutarmi a capire e darmi uno spunto per trovare un modo di affrontare la tragedia che mi aveva colpito.
Dovevo semplicemente cominciare da qualche parte, fare una scelta. E mi convinsi sempre di più che il punto di partenza era da ricercare nei primi tempi della mia vita.
Alla fine scelgo una fredda giornata invernale del 1957. Aprendo gli occhi al risveglio non so ancora che di lì a qualche ora mi si svelerà un grande segreto.
Mi avvio verso la scuola che è ancora buio. Ho nove anni. Questa mattina il mio migliore amico Bosse è malato. Di solito passo a chiamarlo a casa sua, un edificio a un paio di minuti a piedi da quello del tribunale. Mi apre suo fratello Göran e dice che Bosse ha mal di gola e rimarrà a casa. Non mi resta che fare la strada da solo. Il centro abitato di Sveg è piccolo e i percorsi sono tutti brevi. Sebbene siano passati cinquantasette anni da quel giorno d’inverno, ricordo ancora tutto nei minimi dettagli. I lampioni radi ondeggiano lentamente nel vento capriccioso ma non troppo forte. Quello davanti al colorificio ha il vetro rotto. Ieri era intero. Dunque è successo durante la notte.
Mentre dormivo deve avere nevicato. Qualcuno ha già spalato davanti al mobilificio. Il proprietario, probabilmente, che è il padre di Inga-Britt. Anche lei è in classe con me, ma è una femmina e quindi non facciamo mai la strada insieme andando a scuola. Però corre forte. Nessuno riesce mai a batterla.
Ricordo persino cos’ho sognato quella notte. Sono su un lastrone di ghiaccio nel fiume Ljusnan, che si snoda tortuoso proprio sotto la casa in cui abito. Il lastrone scivola verso sud insieme alle acque del fiume in pieno disgelo. È primavera. Trovarsi da soli su una lastra di ghiaccio dovrebbe fare paura, dato che è pericoloso. Solo qualche mese fa un ragazzo poco più grande di me è annegato quando nel lago ghiacciato nei pressi del paese si è aperta una crepa inaspettata e insidiosa. È stato risucchiato sott’acqua e non è stato più ritrovato sebbene i vigili del fuoco siano andati sul posto a dragare il fondo. A scuola, la maestra ha disegnato una croce sul suo banco. C’è ancora. Tutti, in classe, hanno paura delle crepe nel ghiaccio, degli incidenti e dei fantasmi. Tutti hanno paura di quella cosa incomprensibile che si chiama Morte. La croce sul banco fa spavento.
Invece nel sogno il lastrone è sicuro. So che non cadrò in acqua.
Dal mobilificio attraverso la strada in diagonale e mi fermo all’altezza della Casa del popolo, dove ci sono due bacheche, lo stesso numero dei film proiettati ogni settimana. Vengono consegnati dentro scatoloni scuri allo scalo merci della stazione ferroviaria. O arrivano con il treno da Orsa, cioè da sud, oppure con l’automotrice da Östersund. Il trasporto dalla stazione avviene ancora con il carro trainato da un cavallo. È Engman, il custode della Casa del popolo, a scaricare gli scatoloni. Una volta ci ho provato anch’io, senza riuscirci. Erano troppo pesanti per un bambino di nove anni. Contengono un western pessimo che vedrò più tardi. Uno di quei film di serie B o C in cui la gente parla e parla, e che finiscono con un breve duello e poco altro. Il tutto con degli strani colori. Le persone hanno la faccia rosa e il cielo è più verde che azzurro.
Vedo ora che Engman proietterà Lo spietato, che non sembra particolarmente allettante, e un film svedese con Nils Poppe, il cui unico aspetto positivo consiste nel fatto che non è vietato ai minori. Questo significa che non sarò costretto a entrare attraverso la finestra del seminterrato che io e Bosse abbiamo lasciato aperta e bloccata in modo da poterci intrufolare da lì quando ci sono dei film vietati.
È mentre me ne sto qui fermo, in questa fredda mattina di cinquantasette anni fa, che vivo uno dei momenti che segneranno per sempre la mia vita. Ricordo la situazione con una nitidezza assurda. È come se l’immagine fosse impressa a fuoco nella mia memoria. Di colpo sono sopraffatto da un’intuizione inaspettata, come se prendessi una scossa. Le parole si formulano da sole nella mia testa: «Io sono io e nessun altro. Io sono io.»
In quest’attimo si forma la mia identità. Prima i miei pensieri erano infantili, com’era giusto che fossero. Ora s’inaugura una nuova condizione. L’identità presuppone la coscienza.
Io sono io e nessun altro. Non posso essere scambiato con altri. La vita diventa di colpo una faccenda seria.
Non so per quanto tempo rimasi lì fermo al freddo e al buio con quella nuova, scombussolante presa di coscienza. Ricordo solo che arrivai a scuola in ritardo. Davanti alla porta sentii che Rut Prestjan, la mia maestra, stava suonando l’armonium. Mi tolsi la giacca e aspettai. Era severamente proibito ai ritardatari fare irruzione in classe quando avevano già avuto inizio il canto dei salmi e la recitazione della preghiera mattutina.
Dopo un bel po’ la musica finì, si sentì il rumore dei banchi e io bussai ed entrai. Dato che non arrivavo quasi mai in ritardo, la signora Prestjan si limitò a scrutarmi e a rivolgermi un cenno. Se avesse sospettato pigrizia o sbadataggine da parte mia, mi avrebbe rimproverato.
«Bosse è malato» dissi. «Ha la febbre e il mal di gola. Oggi non viene.»
Poi presi posto nel banco. Mi guardai intorno. Nessuno si era accorto del grande segreto che mi sarei portato dentro a partire da quella fredda mattina d’inverno del 1957.
Copyright © 2015 Marsilio Editori S.p.A, Tutti i diritti riservati.