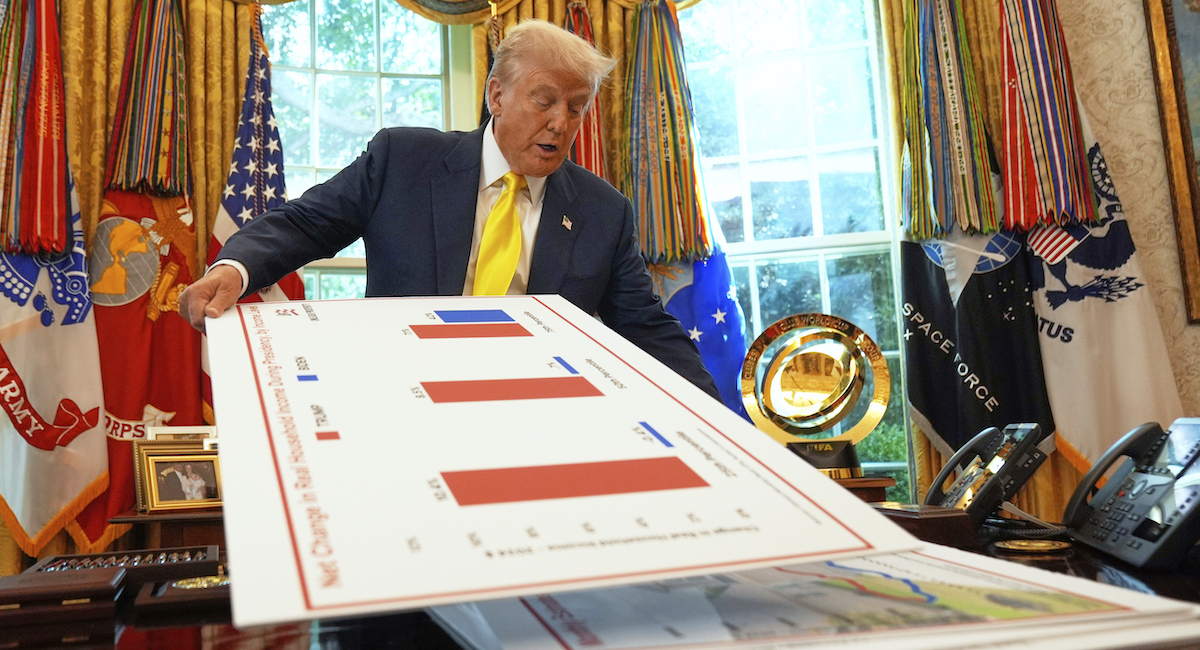La decrescita felice e crescente di Patagonia
Un noto brand di abbigliamento sportivo invita a riparare e scambiare i propri prodotti, riuscendo paradossalmente ad allargare così il proprio giro di affari
di Enrico Matzeu – @enricomatzeu

Un lungo articolo del settimanale americano New Yorker ha spiegato lo stile e la storia recente di Patagonia, una società americana che produce abbigliamento sportivo e da escursione. Patagonia è da anni famosissima per la sua particolare filosofia ecologista e quasi “no global”: ogni anno dona una buona parte delle sue entrate ad alcune associazioni ecologiste, e incoraggia i suoi clienti a riparare o scambiare i propri vecchi vestiti Patagonia. Nel 2011 pubblicò una famosa pubblicità sul New York Times che invitava a non comprare la sua giacca di pile di punta, elencandone tutti i costi ambientali che erano stati necessari per produrla.
Allo stesso tempo, però, i prodotti da Patagonia non costano poco, e negli anni hanno attirato una clientela piuttosto ricca (tanto che da alcuni hanno soprannominato la società “Patagucci”). J. B. MacKinnon, che ha scritto l’articolo per il New Yorker, ha scritto che il sito di Patagonia per esempio vende un kit di emergenza da cucito che costa trenta dollari (cioè 27 euro) e che piuttosto che a uno spartano pacchetto con ago e filo «assomiglia a un oggetto di scena di Moonrise Kingdom di Wes Anderson, uno di quelli utilizzati dal gruppo di scout del protagonista».
La strategia, comunque, sembra funzionare: nell’ultimo anno Patagonia ha raddoppiato le vendite online dei suoi prodotti, ed entro il 2015 dovrebbe avere un giro di affari di 600 milioni di dollari (ottenuto grazie all’apertura di diversi nuovi negozi in giro per il mondo, e a un raddoppiamento complessivo delle operazioni commerciali negli ultimi sei anni). Secondo alcuni il successo di Patagonia è stato ottenuto proprio grazie alle sue politiche anti consumistiche e ambientaliste. L’ultima, in ordine di tempo, si chiamava Worn Wear e si è conclusa il 12 maggio. Un camper rivestito di legno e alimentato a biodiesel ha fatto il giro degli Stati Uniti riparando capi logorati e rivendendo prodotti Patagonia usati: in tutto sono stati riparati circa 2100 vestiti di Patagonia – 93 dei quali solo a New York – e l’iniziativa è stata considerata un successo. Ma l’idea, spiega il New Yorker, è solo una delle tante che il brand sta mettendo in pratica sul tema della conservazione ambientale e anche della “self-inquisition”, una pratica piuttosto originale di fare campagna promozionale elencando i difetti del proprio prodotto.
Dall’inizio
La vocazione ambientalista di Patagonia appartiene dello spirito aziendale più o meno da quando la società fu fondata da Yvon Chouinard, negli anni Cinquanta. Da ragazzo, scalando le montagne californiane e lo Yosemite, Chouinard si rese conto che per farlo gli sarebbero serviti molti più chiodi di quelli che utilizzava di solito, e ispirato da un alpinista e fabbro svizzero iniziò a fabbricarli da solo. Cominciò così a vendere i chiodi che produceva a mano. Quando le richieste aumentarono aprì dapprima un negozio nel retro della casa dei genitori e poi, nel 1965, si mise in società con un altro scalatore, Tom Forst, e fondò la Chouinard Equipment, che iniziò a produrre attrezzature per l’alpinismo e l’arrampicata. Dopo nove anni, l’azienda cambiò nome in Patagonia. Il nuovo marchio cominciò a produrre anche linee di abbigliamento sportivo, allargandosi anche al surf, allo sci e alla pesca. Quelli di Patagonia furono i primi a proporre capi colorati per l’alpinismo e a introdurre materiali tecnici come il Synchilla e il Capilene, oggi utilizzati in molte attrezzature sportive.
Il primo progetto di riguardo nei confronti dell’ambiente risale ai primi anni di attività della Chouinard Equipment, quando i due soci capirono che i chiodi di acciaio che venivano utilizzati all’epoca danneggiavano la roccia. Decisero allora di sostituirli con dadi di alluminio, che potevano essere rimossi una volta utilizzati. Una maggiore attitudine ambientalista di Patagonia iniziò però verso la fine degli anni Settanta, quando si cominciava a parlare di surriscaldamento della terra e Patagonia dedicò attenzioni e investimenti ai luoghi dove venivano costruiti i suoi stabilimenti.
Dal 1986, inoltre, Patagonia devolve ogni anno il 10 per cento dei profitti annui o l’1 per cento delle vendite (a seconda di quale sia la cifra maggiore) a gruppi ambientalisti indipendenti, “per risarcire il pianeta dei danni che compie con la propria attività”, dicono loro, nonostante le molte attenzioni ecologiche nei processi di produzione e commercializzazione. Il centro di distribuzione del Nevada, ad esempio, ha raggiunto il 60 per cento di risparmio energetico con i pannelli fotovoltaici e solare termico; tutte le sedi e i negozi sono realizzati con materiali riciclati e hanno impianti di illuminazione ecosostenibili. Dal 1996, inoltre, tutti i capi Patagonia sono realizzati con cotone biologico.
La nuova strategia
Da alcuni anni Patagonia lavora molto proficuamente – avendo una clientela molto sensibile sui temi ambientali, e anche piuttosto disposta a spendere – su comunicazione e marketing in difesa dell’ambiente: producendo oggetti che hanno spesso un costo superiore agli altri, ma realizzati con tessuti biologici e certificati. Questo ha avuto un notevole ritorno economico per l’azienda, che negli ultimi cinque anni ha avuto un incremento graduale del proprio fatturato e una crescita costante. Nel 2012 per esempio, un anno in cui lo spirito della campagna pubblicitaria fu “comprate meno cose”, le vendite di Patagonia sono cresciute di quasi un terzo rispetto all’anno precedente (e le entrate erano inferiori di più di 50 milioni di euro rispetto a quelle attuali).
Nel 2013, invece, Patagonia avviò la campagna di “Economia Responsabile” contro l’inquinamento ambientale causato dalle aziende produttrici di abiti: lo scopo era quello di sensibilizzare al recupero di capi usati, di cui Patagonia ricicla circa 10 tonnellate l’anno, e riguardo la riparazione dei propri vestiti, di cui Patagonia si occupa per circa 40mila capi all’anno. Guardando però ai dati sulle vendite di Patagonia, scrive MacKinnon, «è chiaro che l’azienda ripara e ricicla solo una piccolissima parte del numero di prodotti che vende ogni anno». E Patagonia sta continuando a espandersi: dal 2011 a oggi ha aperto 40 nuovi negozi in tutto il mondo.
Ma come fanno a Patagonia a giustificare la loro immagine pubblica di azienda attenta anti-consumista e contemporaneamente continuare a espandersi? MacKinnon ha sintetizzato così lo spirito con cui quelli di Patagonia giustificano il loro recente successo: «c’è una crescita economica cattiva, e ce n’è una buona. Un’economia in espansione trainata da un consumo individuale sempre più alto di prodotti non riciclabili è il male. In un ipotetico futuro sostenibile, le persone compreranno meno cose ma saranno disposte a pagare di più per esse: la ricerca tecnologica ridurrà il loro impatto sull’ambiente, e gli oggetti saranno prodotti per durare, e infine riciclati. Dal loro punto di vista, più Patagonia espande la propria fetta di mercato, più si diffonde la nuova economia “buona”».
Adam Fetcher, direttore dell’ufficio di pubbliche relazioni di Patagonia, ne ha parlato al New Yorker in questi termini:
«A un certo punto, la crescita della nostra azienda creerà più problemi di quanti ne risolverà. Ma un momento simile non è all’orizzonte: per ora continueremo a produrre oggetti che permettono alle persone di condurre una vita più responsabile, tramite i loro capi di abbigliamento. E finché rimangono in giro un sacco di aziende che non lo fanno, e che quindi offrono più problemi che soluzioni, allora è giusto che la nostra azienda si espanda».