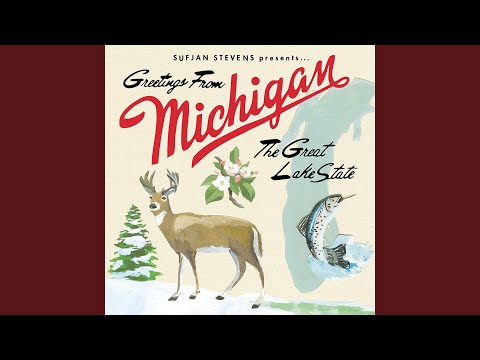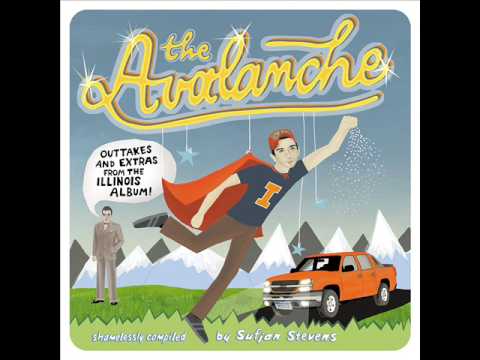Il leggendario Sufjan Stevens
Guida per canzoni al musicista indipendente più creativo del millennio, oggi che compie 40 anni, per quel 99% di noi che non lo conosce

Il primo luglio 2015 compie 40 anni Sufjan Stevens, considerato spesso tra gli appassionati della musica “indie” il più inventivo e originale musicista rock di questo millennio, e al tempo stesso sconosciuto ai successi mainstream (malgrado una produzione abbastanza ricca). “Sufjan”, come lo chiamano i fans, è stato celebrato come una novità di gran moda una decina di anni fa, ma non ne ha mai approfittato, continuando a fare cose dai suoni molto “Sufjan” e dalle lunghezze spesso ostiche. Quando nel 2006 Luca Sofri pubblicò Playlist, la musica è cambiata, chiese a Matteo Bordone – esperto di musica e autore e conduttore radiofonico – di esserne ospite compilando lui una raccolta di canzoni di Sufjan Stevens: che per quest’occasione lo stesso direttore ha arricchito e aggiornato.
Sufjan Stevens (1975, Detroit, Michigan)
Il nome – arabo o armeno – glielo hanno dato i genitori in tempi spiritual-fricchettoni. Lui è il più geniale e fantasioso cantautore americano del Duemila, che si è promosso annunciando la folle impresa di dedicare un disco a ognuno dei cinquantadue Stati americani. Per ora è a due, ma già il secondo ha appeso critici e appassionati di musica alle sue labbra, e alle sue invenzioni post-progressive e fiabesche con titoli sterminati.
All good naysayers, speak up! Or forever hold your peace!
(Michigan, 2003)
Nell’epopea dei pezzi con tempi dispari di Sufjan Stevens, questo è il punto di partenza. Da qui in poi metterà in ogni suo disco tempi insoliti ispirati alla musica dei minimalisti tipo Steve Reich. Sono delle specie di cavalcate morbide, che hanno qualcosa di storto ma ci si va dietro bene. Cori femminili, voci che si ripetono e tutto l’armamentario barocco che caratterizza la sua musica.
Oh Detroit, lift up your weary head
(Michigan, 2003)
La capitale del soul e dei motori, la Motown in tutti i sensi, raccontata come la potrebbe raccontare un ossessivo che legge l’enciclopedia. “Un tempo bel posto, ora prigione”: e poi qualche banalità e un elenco di nomi che comprende Henry Ford, la Pontiac e il wolverine, cioè il grosso mammifero unghiato che dà il nome al personaggio Marvel. Per la cronaca (e soprattutto per i nostalgici del progressive), la canzone è in nove ottavi.
Romulus
(Michigan, 2003)
La produzione di Stevens si divide tra i pezzi esagerati e quelli ridotti all’osso. Questa è della seconda categoria. Parla di una madre assente adorata dai figli, oggetto di un affetto inarrivabile e sconvolgente. Ma lei è una sbandata e il pezzo finisce con il verso “mi vergognavo di lei” ripetuto otto volte. Se ascoltata in una situazione vagamente favorevole alla commozione, ci si commuove. Forse anche per colpa del banjo.
In the devil’s territory
(Seven swans, 2004)
Una specie di mantra sempre identico che racconta di come delle persone abbiano aspettato un sacco di tempo per incontrare e sconfiggere finalmente chi? Satana in persona. E continua a ripetere dolcemente “to see you, to beat you” un sacco di volte. Millenarismo biblico dal volto umano? Forse sì, ma quello che conta è che non c’è panico, non c’è paura di morire. Vincono i buoni, cioè noi, con la pace nel cuore.
Abraham
(Seven swans, 2004)
Una disperata e lentissima lode di Abramo, quello che avrebbe sgozzato il figlio se l’angelo buono non gli avesse fermato la mano.
He woke me up again
(Seven swans, 2004)
Una canzone di conversione. Ma non è christian-rock. Racconta della chiamata, nel senso mistico del termine, sopra un organetto accattivante. E nel ritornello dice “Halle Halle Hallelujah”. Eppure la convinzione discreta nella voce di Sufjan non ha niente a che fare col sorriso idiota dei telepredicatori.
Come on! Feel the Illinoise!
(Illinois, 2005)
Un antidoto al minimalismo. Non si può essere indifferenti a questi pezzi di Sufjan Stevens, perché c’è dentro troppa roba. Qui o ti lasci prendere, oppure li trovi ridondanti e kitsch. Pianoforte, vibrafono, archi, pienoni orchestrali e cori di vergini: sembra veramente di sorvolare l’Illinois da parte a parte in cinque minuti, a bordo di un tappeto persiano.
John Wayne Gacy Jr.
(Illinois, 2005)
È una canzone che parla del serial killer che si travestiva da clown e che ha fatto fuori 27 bambini. Il tema lascerebbe spazio alla retorica più orrenda, quella di cui sono capaci il rock’n’roll e Oliver Stone; invece è una ballata struggente che dice tutto su quello che Gacy faceva e mette addosso una malinconia bella e inquietante.
Chicago
(Illinois, 2005)
Non è in effetti un pezzo su Chicago, ma piuttosto un’epica personale e dolente, che racconta di una fuga di casa, una fuga da Chicago e dalla famiglia in furgone. Per raccontare la tua città e il rapporto che ti ci lega, parti da quella volta che la odiavi per forza di cose. Tanto poi tutto passa: “All things go”. Chapeau. Ce ne sono altri tre arrangiamenti su The Avalanche, tutti ottimi.
Dear Mr. Supercomputer
(The avalanche, 2006)
L’anno dopo il capolavoro Illinois, Stevens raccolse gli avanzi e i doppioni e li pubblicò in The avalanche. In “Dear Mr. Supercomputer” si sentono ancora Penguin Café Orchestra e Steve Reich come se piovesse. Ma pur con i soliti numi tutelari, questa volta Sufjan parla con un supercomputer della morte di dio e dell’etica contemporanea. Verso chiave: “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, All computers go to heaven”. Col vibrafono e le trombe. Manca solo il settimo cavalleggeri.
Adlai Stevenson
(The avalanche, 2006)
Si può nel 2006 scrivere una canzone marcetta tutta flauti e fanfara sul politico democratico americano Adlai Stevenson, governatore dell’Illinois dal 1948 al 1952, e poi candidato perdente alle elezioni presidenziali vinte da Dwight Eisenhower? Sì, ed è anche un bel pezzo.
The mistress witch from McClure (or, the mind that knows itself)
(The avalanche, 2006)
Succede qualcosa di terribile tra un
padre e una donna-strega, forse so
lo sesso, forse qualcosa di più. E
come capita spesso nei pezzi nostalgici e lenti di Sufjan Stevens, il
punto di vista è quello collettivo
dei bambini, in questo caso spaventati. Ma la musica è carezzevole
e c’è una frase impagabile di trom
ba nel ritornello, che mette in pace col mondo.
Djohariah
(All delighted people, 2010)
Raro caso di pezzo di 17 minuti che avete voglia di rimettere dall’inizio quando arriva alla fine. Lo descrisse così Christian Rocca:
Djohariah è la sorella di Sufjan. La canzone è un inno alle ragazze madri. Una ballata gotica. I primi dodici minuti sono Pink Floyd allo stato puro. Un’elegia musicale che inizia con un coro “ooh, aah” accompagnato da un sinistro assolo di chitarra che sembra chiedere perdono a qualcuno, che quasi teme di pronunciare il nome della ragazza, che certamente avrebbe da dire qualcosa ma non ci riesce. Le trombe e i fiati aprono la strada. Le voci iniziano a scandire: «Djohari, Djohariah». Undici minuti e 44 secondi di crescendo orchestrale, poi comincia un’altra canzone. Scopriamo che Djohariah è stata lasciata da un marito traditore, violento, cattivo «heart grabber back stabber double cheater wife beater». «Non hai bisogno di quell’uomo nella tua vita», le dice Sufjan. «Sei una donna gloriosa e vittoriosa, la madre del cuore del mondo». «Non vergognarti, non nasconderti nella tua stanza, non piangere in bagno», «il mondo è vostro», «vai avanti sorellina, vai avanti».
Rhythm of Devotion
(Sisyphus, 2014)
Nel 2014 Stevens fece uscire un disco in collaborazione con i musicisti Son Lux e Serengeti, commissionato per una mostra da un museo di Minneapolis. Sulla rivista musicale fu definito “quasi sicuramente il più grande disco di elettronica hip-hop venata di folk electronica con un profondo groove techno pop che abbiate mai sentito”. Sufjan Stevens versione ballabile.
Death with dignity
(Carrie & Lowell, 2015)
Sufjan Stevens ha pubblicato un nuovo disco suo di nuove canzoni nel 2015, dopo un periodo lungo di collaborazioni ed esperimenti vari. Si chiama Carrie & Lowell ed esalta quell’andamento angelico di certe cose sue dei primi tempi, a cominciare dalla prima canzone: andamento che sembra srotolarsi con continuità attraverso tutti i pezzi successivi, e finirà il disco che vi sembrerà appena cominciato, quel sorriso appena abbozzato lì da tre quarti d’ora.
Fourth of July
(Carrie & Lowell, 2015)
La storia della musica americana è fatta da tantissimi quattro-di-luglio, prima e dopo Springsteen. Questo è così, ninnananna e funebre insieme.