I linciaggi degli italiani in Louisiana
Nel nuovo libro di Enrico Deaglio ci sono storie dimenticate e avvincenti che parlano di un secolo fa e di oggi

Il nuovo libro di Enrico Deaglio si chiama “Storia vera e terribile tra Sicilia e America” (Sellerio) e ricostruisce una storia che ne contiene molte altre: quella del linciaggio nel 1899 di cinque immigrati italiani a Tallulah, una città della Louisiana. Deaglio riempie il suo racconto di contesti, riferimenti e vicende che si muovono tra l’Italia e gli Stati Uniti, con palesi allusioni all’attualità: sia per quanto riguarda le questioni dell’immigrazione, che per esempio per quanto riguarda le questioni del razzismo. E mette in ordine una serie di storie sconosciute alla gran parte dei lettori, che descrivono cosa fosse il rapporto tra lo stato italiano e quello americano rispetto agli emigranti siciliani, e cosa fosse davvero la vita dei siciliani in Louisiana. Questa è la storia del contesto in cui avvenne un più famoso e famigerato linciaggio di italiani, quello di New Orleans del 1890, e di come cambiò la comunità italiana locale.
***
E soprattutto c’era la famiglia Macheca, che era a New Orleans da sempre. Il capostipite era venuto da Malta all’epoca in cui in quell’isola Napoleone fu sconfitto dagli inglesi; e lo stemma della sua famiglia, quello che i maltesi mettono sulle loro barche, era un misto di simboli in aramaico e in fenicio, cosa che spiegava quanto la sua gente navigasse nel Mediterraneo da sempre. Il vecchio Macheca aveva sposato una donna siciliana albanese e da quell’unione era nato il clan siciliano a New Orleans e poi un impero economico fatto di navi, docks e commercio. Joseph Macheca, il nipote del grande vecchio, adesso era uno dei grandi boss della città, proprietario di una magnifica villa con cappella privata, di un panfilo da diporto, di una flotta di pescherecci. Agli ordini suoi, duemila persone aspettavano la mattina lo scarico della frutta e si disperdevano agli angoli delle strade di tutta New Orleans a venderla dai loro carretti. Macheca era anche un boss politico, e come tutti gli altri, con una sua organizzazione armata. Quella di suo padre era chiamata «Gli innocenti», si vestivano con una camicia ricamata candida e si vedevano nei quartieri dare la caccia ai negri; i suoi si chiamavano «Stuppagghieri», reclutati soprattutto tra gli emigrati di Palermo e di Monreale, e tenevano l’ordine nella parte più fetida e infame della città, proprio quei quattro isolati di malattie ed epidemie della Little Palermo, giù in fondo al Vieux Carré. Little Palermo era povera, era disgraziata, ma forse era più ricca di quanto non fosse, negli stessi anni, la Palermo d’origine.
Era incredibile come Palermo avesse potuto riprodursi dall’altra parte del mondo, e con che velocità. Da quando l’esercito dei piemontesi era sfilato per i Quattro Canti e aveva imposto la sua legge, la Sicilia si era divisa in Regnicoli e Scappati. O meglio: Palermo, per dare da mangiare a tutti, aveva finito per divorare se stessa, e poi aveva vomitato i suoi abitanti in America.
Prometteva bene, la Palermo in America, certo meglio della Progenitrice. Ma da un anno, «le cose erano cambiate». Peppino, Saro e Ciccio, quante volte se lo sentirono dire. E quante volte la sentirono raccontata, quella storia. Loro non c’entravano niente, erano ancora a Cefalù quando successe, e non sapevano che li avrebbe inseguiti.
Ma la storia era questa, ed era bella e terribile da ascoltare come quelle dei cantastorie nei paesi. C’era qualcosa che li affascinava, come se li toccasse da vicino.
Il «fatto» fu inaudito, di per sé. L’uccisione, per strada, del capo della polizia di New Orleans. Non era mai successo in una grande città americana.
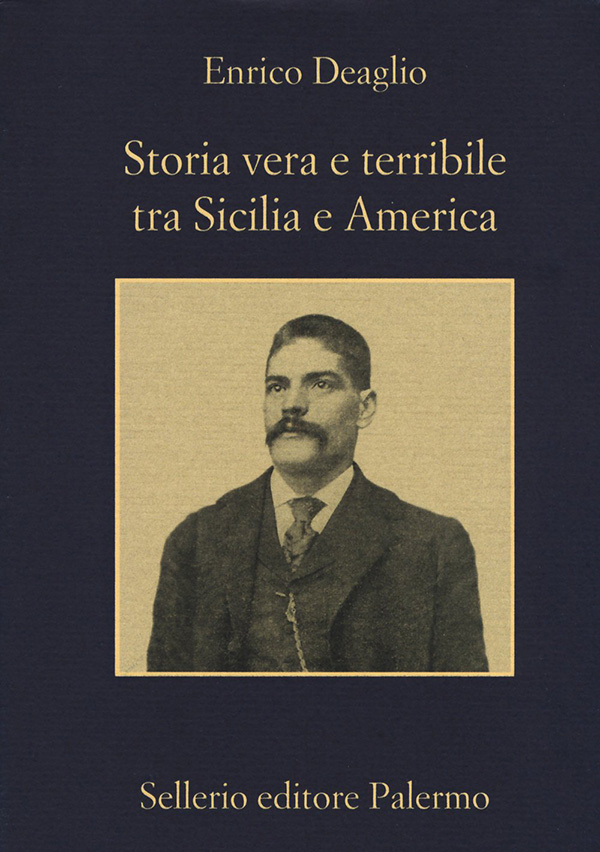 David Hennessy, un irlandese di 33 anni, era diventato da poco il «Chief» della polizia metropolitana, ruolo di grande potere che si giocava tra le varie correnti del Partito Democratico della città. Hennessy era un popolare detective che aveva sventato rapine e assicurato alla giustizia un famoso brigante siciliano, un certo Esposito che, a Lercara Friddi, aveva rapito e mozzato le orecchie a un industriale inglese dello zolfo e poi era scappato in America. Niente soffiate, intuito, solo intuito: Hennessy aveva visto un tipo strano in un bar e l’aveva riconosciuto come Esposito da un vecchio disegno che proprio la sua vittima aveva fatto di lui. La cattura di Esposito diede molti punti a Hennessy. Ma c’era un altro concorrente per diventare Chief. L’altrettanto famoso e giovane detective Thomas Deveraux. Beh, sembra impossibile, ma Deveraux venne ucciso a colpi di pistola dal cugino di Hennessy, alla presenza del nostro futuro Chief, dopo una banale lite in un locale pubblico. Il processo dimostrò che si era trattato di legittima difesa: Deveraux aveva tirato fuori la pistola per primo.
David Hennessy, un irlandese di 33 anni, era diventato da poco il «Chief» della polizia metropolitana, ruolo di grande potere che si giocava tra le varie correnti del Partito Democratico della città. Hennessy era un popolare detective che aveva sventato rapine e assicurato alla giustizia un famoso brigante siciliano, un certo Esposito che, a Lercara Friddi, aveva rapito e mozzato le orecchie a un industriale inglese dello zolfo e poi era scappato in America. Niente soffiate, intuito, solo intuito: Hennessy aveva visto un tipo strano in un bar e l’aveva riconosciuto come Esposito da un vecchio disegno che proprio la sua vittima aveva fatto di lui. La cattura di Esposito diede molti punti a Hennessy. Ma c’era un altro concorrente per diventare Chief. L’altrettanto famoso e giovane detective Thomas Deveraux. Beh, sembra impossibile, ma Deveraux venne ucciso a colpi di pistola dal cugino di Hennessy, alla presenza del nostro futuro Chief, dopo una banale lite in un locale pubblico. Il processo dimostrò che si era trattato di legittima difesa: Deveraux aveva tirato fuori la pistola per primo.
Nominato capo della polizia, David Hennessy sorvegliava il porto, il mondo del vizio, l’immigrazione, le licenze. Dato che la città era intimamente corrotta, difficile pensare che Hennessy facesse eccezione. Intascava tangenti, schierava la polizia a sostegno di questa o quella fazione, faceva pagare la sua protezione, si diceva che fosse socio in uno dei più noti bordelli della città, aveva le mani in tasca negli affari della lotteria ed era candidato a una grande carriera politica.
La sera del 15 ottobre 1890, Hennessy era in procinto di dare testimonianza in tribunale su una faida tra i Provenzano e i Matranga per il controllo del porto.
Questa era una storia che a Little Palermo conoscevano tutti: di quando Tony Provenzano aveva attaccato un carro di scaricatori del porto che tornava dal lavoro e ferito a pistolettate nientemeno che il figlio di Charles Matranga, che aveva perso una gamba. Hennessy era arrivato sulla scena e adesso doveva testimoniare al processo, ma tutta la città sapeva che Hennessy era a libro paga dei Provenzano.
La sera prima del processo, The Chief se n’era andato a spasso con amici. Era uscito dal famoso Dominic Virget’s Saloon, dove aveva mangiato dodici ostriche e bevuto un bicchiere di latte (Hennessy era astemio), in compagnia del suo amico Bill O’Connor, anche lui irlandese, capitano di un corpo di polizia privato. Uno dei tanti: New Orleans era la patria delle fazioni armate.
I due si lasciano, Hennessy ha due isolati per arrivare a casa. È buio, sono le 10 e mezzo di sera del 16 ottobre 1890, la strada è tutta una pozzanghera dopo un violento temporale, la zona è di case di legno basse, dove abitano negri e siciliani. All’improvviso una raffica di colpi di fucile, ombre che scappano, Hennessy che stramazza. Si rialza, spara con la pistola, si accascia di nuovo. Arriva in ospedale cosciente, è ferito all’addome; i medici gli danno la morfina, lui dice: «Mi hanno tirato, ma io ho risposto. Ho fatto del mio meglio».
Il suo amico Bill O’Connor, che lo aveva portato su quella strada e poi lo aveva lasciato andare a casa solo («tanto sono solo due isolati») è il primo ad arrivare al capezzale. Più tardi, nella notte, dirà ai reporter che si affollano all’ospedale: «Mi sono chinato su di lui e gli ho chiesto: “Who gave it to you, Dave?” He replied: “Put your ear down here”. As I bent down again, he whispered the words: Dagoes».
Nessun altro, oltre O’Connor, sentì quel bisbiglio di risposta.
Non solo nessun altro sentì quelle parole, ma a nessun altro Hennessy le pronunciò, ai tanti, compreso un giudice, che lo visitarono nella notte e lo trovarono lucido. Stava bene, gli chiesero diverse volte se voleva fare qualche dichiarazione, ma The Chief ripeté che c’era tempo, non c’era urgenza. Poi venne sua madre e i due parlarono a lungo, da soli, delle loro cose finanziarie. Alla mattina, improvvisamente, le condizioni di Hennessy peggiorarono; entrò in coma e morì nel giro di mezz’ora. Bill O’Connor scomparve dalla scena. Non diede nessun’altra testimonianza e non fu nemmeno sentito al processo. Tra cento voci di popolo che lo indicavano come colui che aveva portato l’agnello al macello.
Ma quel bisbiglio – da-go-oes – portò i primi cinquanta arresti nella notte e poi una retata di duecentocinquanta siciliani di New Orleans. Era l’occasione che il sindaco cercava per stangare gli italiani. Joseph Macheca e Charles Matranga, i siciliani più in vista, vennero arrestati per complotto, nonostante quella sera fossero a teatro. Bambini di dodici anni entrarono in galera. Un «comitato dei 50» – i cui membri dovevano restare segreti, come se fossimo tornati al Medioevo – venne formato per indagare sul pericolo della «mafia siciliana» (è stato qui, prima che in Italia, che il termine divenne noto) e nel giro di poco tempo uno spaventoso cortocircuito si abbatté sulla comunità siciliana. Il sindaco diede ordine di fermare o arrestare ogni italiano sospetto, fece un editto in cui considerava responsabili dell’omicidio tutti i siciliani che non collaboravano con la polizia, vennero fermate le barche da pesca che risalivano il fiume per perquisirle, venne setacciato il quartiere di Little Palermo.
Lo stesso sindaco sostenne di aver ricevuto dal governo italiano una lista di mille criminali che avevano trovato rifugio in Louisiana.
Anche se sapevano come andava a finire, i nostri tre ragazzi ogni sera se la facevano raccontare di nuovo.
Dunque, dopo tante indagini, tante teorie, il procuratore concluse che la mafia siciliana aveva ordito un complotto per uccidere Hennessy e che Macheca e Matranga erano i capi. Fecero un processo, con 19 imputati, ma si scoprì che non avevano niente in mano, se non le accuse di un certo Emanuele Polizzi, che era malato di mente e durante il processo tentò addirittura di buttarsi dalla finestra. Nessuno se lo aspettava, ma nemmeno la giuria popolare se la sentì di condannare gli italiani. Li assolse tutti! Erano liberi! Not guilty, cumpà: hai capito?
Ma – fate bene attenzione – la polizia non li fece uscire dalla prigione, perché disse che dovevano ancora vedere delle carte e controllare che non ci fossero altre accuse.
E così successe come ai troiani che credevano di aver vinto la guerra e non si erano accorti del cavallo. I siciliani festeggiarono a Little Palermo con i fuochi artificiali e scesero in strada con le bandiere del Re d’Italia. Dissero che era il compleanno del Re, ma veramente non era la data esatta del compleanno. Ma lo facevano per il verdetto, capisci? E non sapevano, meschini, quello che stava per succedere.
La mattina dopo i cittadini di New Orleans trovarono sul quotidiano in prima pagina un annuncio esplicito:
Mass Meeting
Alla good citizen are invited to attend a mass meeting on Saturday, March 14 1891, at 10 o’clock a.m., at Clay Statue, to take steps to remedy the failure of justice in the Hennessy case.
Come prepared for action.
Seguivano 61 nomi, ed erano quelli dei politici e degli industriali più in vista della città. Spiccava anche quello del braccio destro del sindaco.
Fu il signor Wickliffe, proprietario di giornali che conduceva una campagna contro i siciliani, a parlare alla folla. «Siamo qui per capovolgere l’infame sentenza di una giuria corrotta dalla società mafiosa. Mr. Parkerson, l’assistente del sindaco, sarà il vostro capo. Mr. Houston sarà il suo primo assistente ed io sarò il suo secondo».
La folla aumentava di minuto in minuto, fino a raggiungere le ventimila persone. Il corteo partì in direzione della prigione, accompagnato da cori di ragazzini che scimmiottavano la parlata dei dagos e ritmavano «Who killa da Chief! Who killa da Chief!».
(«Avete capito ora, che cosa vi urlavano al porto quando siete arrivati? Uchilladacif vuol dire “assassini”, “avete ucciso voi il capo della polizia”. Ce lo urlano sempre. Non dovete rispondere, mai! Tenete la testa bassa e allungate il passo»).
Alla testa della folla comparvero improvvisamente cento uomini armati di fucile a ripetizione Winchester e divenne chiaro il finale della giornata. La porta della prigione venne abbattuta e cominciò la caccia agli italiani, cella per cella. Ne trovarono undici e li uccisero. Presero i cadaveri e li portarono alla folla. Alcuni li impiccarono ai lampioni, dove rimasero per un giorno intero. Intanto squadre attaccavano i siciliani nella Little Palermo, sfondavano e incendiavano i loro negozi.
I siciliani non ebbero alcuna possibilità di reagire; il clima di terrore costrinse molti di loro a nascondersi, per settimane, nelle cantine.
C’erano un sacco di dettagli che animavano questi racconti. Un sacco di sospetti. Come mai gli avvocati non protestarono per fare uscire i loro clienti dalla galera? Era vero che il governo italiano aveva mandato quella lista di mille criminali? Come mai Charlie Matranga, che era l’uomo più in vista, riuscì a salvarsi? E come mai Macheca che era così ricco invece venne ucciso? Matranga disse che si era nascosto sotto un materasso nella parte femminile della prigione. Strano però che non si siano accorti che proprio lui mancava, quando hanno allineato i cadaveri nel cortile. E si salvò anche Bastian Incardona, un palermitano che era il suo braccio destro.
Ancora oggi che sono passati 125 anni, non si sa chi uccise il capo della polizia di New Orleans. Non venne mai fatto un altro processo, né altre indagini. Tutta l’operazione, vista con gli occhi di oggi, appare molto diversa dallo «scoppio di rabbia popolare» per la morte di un eroe in divisa. Fu in realtà il primo caso, in America, di un uso della folla per motivi politico-economici. Fu il proseguimento dei pogrom che si svolgevano in Russia, e un anticipo di quanto sarebbe successo in Germania, nel 1938, alla notizia dell’uccisione di un diplomatico tedesco a Parigi ad opera di un diciassettenne ebreo. Fu un’operazione di sterminio (il sindaco disse: «Io vi spazzerò via dalla faccia della terra») contro una comunità in ascesa sociale, di cui si contestava la razza. Il Mr. Parkerson che aveva guidato l’eccidio diventerà un famoso governatore della Louisiana, i dagos divennero un «nemico ufficiale», etichettati tutti come appartenenti alla «mafia society». Un decreto tolse loro la possibilità di lavorare al porto; venne sciolta la loro organizzazione sindacale di scaricatori. Il console italiano, Pasquale Corte, che nel giorno dell’eccidio aveva cercato in tutti i modi di parlare con le autorità, con la polizia, con il sindaco, fu dichiarato persona non grata e costretto a lasciare la città. Tutti i politici locali dissero che «a New Orleans era stata fatta la cosa giusta». Teddy Roosevelt, che sarebbe diventato dieci anni dopo il presidente degli Stati Uniti, disse: «era tempo che a quella razza venisse data una lezione». L’ambasciatore italiano a Washington, il barone Francesco Fava, venne richiamato a Roma e lasciò per mesi la sede vacante, mentre si diffondevano a New Orleans le notizie più incredibili. Che la flotta italiana era partita per il golfo del Messico, che una milizia di mafiosi si preparava ad attaccare con diecimila uomini la città. Centinaia di persone corsero ad arruolarsi, i giornali davano risalto a notizie come questa:
Una compagnia di coraggiosi cittadini della Georgia è pronta ad invadere Roma, a disperdere la mafia e alzare la bandiera a stelle e strisce sulla basilica di San Pietro.
Il Regno d’Italia, in realtà, non aveva alcun proposito bellicoso; ma piuttosto l’assoluta necessità di tenere vivi i canali della emigrazione. Dopo sei mesi, Fava tornò a Washington e trovò un’intesa per sistemare la questione. Il Congresso americano avrebbe ricompensato le famiglie degli 11 impiccati con 2.500 dollari a testa. Ma che davvero i dagos fossero una «razza maledetta», l’Italia di fatto lo accettava. La comunità siciliana non venne difesa dalle accuse tremende che le venivano lanciate e i nostri scienziati contribuirono, consapevoli delle conseguenze delle loro parole, a giustificare moralmente i linciaggi.
Così si esprimeva Cesare Lombroso, rivolgendosi a un pubblico americano, quattro anni dopo l’eccidio di New Orleans, per spiegare l’innata criminalità propria delle popolazioni meridionali:
Come i selvaggi, i criminali manifestano una grande insensibilità al dolore, che spiega la loro longevità, la loro capacità di sopportare gravi ferite, il loro tasso frequente di suicidio. Come per i selvaggi, le loro passioni sono improvvise e violente, la vendetta è considerata un dovere, hanno un forte amore per il gioco d’azzardo, per l’alcool e la pigrizia.
Ognuno portava il suo mattone, contro i dagos. Chi per il sangue, chi per la storia dell’Impero romano, chi per la forma del cranio, chi per l’omertà, per la vendetta, per la mafia. Il tutto in così poco tempo. Una nuova razza era nata.
Alla fine del 1892, come scoprirono i nostri Peppino, Ciccio e Saro, per la Novorlenza siciliana erano finiti gli anni d’oro, ora aveva solo che leccarsi le ferite. Il dago era buono solo per le piantagioni, Little Palermo era misera.
Se ne accorse anche una piccola suora missionaria italiana, arrivata «quando ancora i cadaveri degli immigrati penzolavano dai lampioni». Era una santa, quella suora, si chiamava Francesca Xavier Cabrini, nata a Sant’Angelo Lodigiano, vicino a Milano, missionaria del Sacro Cuore di Gesù. Scrisse, indignata, al papa Leone XIII di aver visto l’infamia perpetrata contro i siciliani, la povertà assoluta della Little Palermo, l’odio che circondava i dagos, lo sfruttamento cui gli emigranti erano sottoposti anche da parte dei loro connazionali diventati padroni. Gli chiedeva di fare qualcosa. Il Papa le rispose laconico: «Sono vittime di uomini senza scrupoli. A causa loro, molta della nostra gente soffre in America». Lei, che girava ovunque ci fosse bisogno, si fermò un po’ a New Orleans, fondò un orfanotrofio e una scuola per ragazze (le scuole furono la sua specialità, e ancora adesso sono ricordate per l’esempio e la tolleranza). Morì a Chicago nel 1917 e venne proclamata, nel 1946, santa patrona degli emigranti, l’unica santa della chiesa cattolica americana. Chissà se i nostri la incontrarono.
Mah, forse no. Erano tre giovani uomini soli e non erano tanto di chiesa. Chissà che cosa gli avrebbe consigliato, la madre Cabrini.
Ma oltre a lei, nessun italiano in Italia sembrò curarsi troppo delle ambasce dei dagos. Che continuavano, piuttosto, ad essere spediti sulle navi. Mille a carico. E ora sul molo c’erano irlandesi disoccupati a gridargli contro, tanto che molti venivano dirottati verso la Florida, ad arrotolare tabacco, che era più sicuro.
(…)
Man mano che i linciaggi crebbero, anche quelli dei siciliani divennero più frequenti: i dagos erano mezzi neri, quindi era logico che subissero lo stesso trattamento. Ed erano diventati tanti, per cui ci voleva qualcosa che ne facesse diminuire le pretese.
A ogni persona impiccata, si consolidava una giurisprudenza. I negri, si era capito, potevano essere linciati. La legge, di fatto, lo permetteva. Di fatto, la pratica veniva interpretata come una forma di snellimento dei tempi della giustizia, una forma di volenterosa attuazione di verdetti che non erano stati eseguiti per mancanza di tempo, di personale o per una certa pigrizia ambientale. Ma quando nel 1891 a New Orleans vennero d’un colpo uccisi e poi esposti al pubblico undici italiani, accusati a vario titolo di omicidio e cospirazione, ma tutti assolti da una corte d’assise, dove stava il diritto?
Nella roboante contesa diplomatica che oppose Italia e Stati Uniti dopo i fatti di New Orleans, il «buco giurisprudenziale» venne coperto con l’istituto della ricompensa.
Alla base della questione c’era un problema importante. L’Italia sosteneva che i linciati erano cittadini italiani, sudditi di Re Umberto I, tutelati nei loro diritti da un trattato tra gli Stati Uniti e l’Italia risalente al 1871, e quindi non potevano essere linciati. Il trattato così recitava, all’articolo due:
Gli Stati Uniti garantiscono ai cittadini italiani emigrati negli Stati Uniti o nei loro territori la più costante protezione e sicurezza per quanto riguarda le loro persone e le loro proprietà, e che essi godranno, a questo proposito, degli stessi diritti e degli stessi privilegi garantiti ai nativi e che saranno sottoposti alle stesse leggi imposte ai nativi.
In quanto al reato, l’Italia sosteneva che si trattava di omicidio. Il segretario di Stato americano rispondeva che il «linciaggio» non era nella lista dei reati federali, ma dipendeva dai singoli stati, nella cui autonomia Washington non poteva entrare. Quanto poi alla fedeltà al Re d’Italia, Washington faceva notare che molti (non tutti in realtà) dei linciati di New Orleans erano cittadini italiani naturalizzati americani, o in procinto di diventarlo. E interpretava la loro richiesta di naturalizzazione come una volontà di non essere più protetti dal Re d’Italia. Diventando americani, o perlomeno non volendo più essere italiani, i futuri linciati diventavano quindi giuridicamente linciabili. Il fatto poi che il trattamento subito fosse riservato in genere solo ai negri e non ai bianchi, era un terreno che il diritto americano non prendeva neanche in considerazione.
Il rompicapo giuridico rivelava in realtà le basi di un pregiudizio razziale. Se il popolo dei linciatori, mai identificato, ma comunque ritenuto una presenza positiva negli avvenimenti, considerava un siciliano alla stregua di un negro, questo significava che aveva diritto a comportarsi così. In sostanza: se una folla non identificata prelevava un negro da una prigione e lo impiccava per sveltire il corso della giustizia, questo non era reato. E non lo era neppure se l’oggetto dell’azione della folla era un siciliano. Per due motivi: il primo è che questi, avendo fatto domanda di naturalizzazione, aveva dimostrato di voler diventare cittadino americano. Il secondo, che la sua natura razziale incerta lo poneva al di fuori dei privilegi della razza bianca.
La natura razziale e giuridica degli immigrati siciliani in Louisiana fu così oggetto di discussione all’ombra di cadaveri penzolanti dalle forche. Ma, stranamente, non si trova mai – tra la cospicua documentazione fornita dai nostri diplomatici – un’indignazione e una condanna per il contesto di continuo vilipendio dei nostri connazionali. Si accetta che essi vengano definiti dagos, che siano considerati a priori delinquenti, che vengano giustificate le reazioni omicide contro di loro, proprio in base alla loro definizione. I nostri diplomatici erano allora conti, baroni, marchesi, e spiace un po’, leggendo centinaia di pagine di retorica italiana, di aulici riferimenti, provenienti dalla conclamata patria del diritto, non trovare mai una parola in favore di questi esponenti di una razza inferiore. E si affaccia una mal sopita certezza, che essi non si indignarono più di tanto, perché non condannavano più di tanto.
Nel caso delle tre impiccagioni a Hahnville, dove persero la vita i poveri Salardino, Arena e Venturella, molti paesani siciliani andarono al consolato a chiedere giustizia, ma con nessun risultato. Il governatore della Louisiana disse che volevano diventare cittadini americani e che pertanto il Re d’Italia non li aveva più tra i suoi sudditi. Disse inoltre che evidentemente non erano buoni cittadini italiani, visto che non mandavano soldi a casa, non erano a disposizione del loro esercito e avevano manifestato più volte la loro intenzione di risiedere negli Stati Uniti, il famoso «animus manendi». Riguardo poi alla possibilità di indennizzo, scrisse che nulla era dovuto per delle persone che in vita non avevano contribuito affatto al benessere economico dell’Italia o alla sua forza militare. Il nostro console portò a testimoniare dieci compaesani (e sono quasi tutte X quelle al posto della firma) che i tre avevano fatto il soldato, erano italiani. Il governatore disse, senza portare prove, che avevano partecipato a elezioni locali, e quindi erano americani. A questo punto, il nostro ambasciatore, barone Saverio Fava, calò una prova forte del pregiudizio contro gli italiani. Raccontò che gli assalitori della prigione di Hahnville cercavano il Salardino per punirlo per la morte di Guermand, ma visto che c’erano presero anche Arena e Venturella, in celle vicine, solo in quanto italiani, per evidente pregiudizio razziale. Arena e Venturella, che stavano in galera e avrebbero potuto essere fuori se solo avessero avuto i mille dollari di cauzione da pagare. Prontamente il segretario di Stato rispose che l’argomento razziale non si poteva applicare, perché oltre ad Arena e Venturella vi erano nella prigione di Hahnville altri tre detenuti italiani. E quindi, se di backlash razziale si fosse trattato, avrebbero preso anche gli altri.
Questo era quello che un siciliano si poteva aspettare, se incappava nella giustizia dell’uomo bianco. Quanto poi a chi era un «bianco», chi era un «nero», chi era un «dago», la scienza e la giurisprudenza americana, proprio in quegli anni lavoravano con alacrità.
Nel 1896, la Corte Suprema degli Stati Uniti legiferò contro il cittadino di New Orleans Homer Plessy, nella causa Plessy versus Ferguson, divenuta storica. Plessy aveva denunciato le ferrovie della Louisiana per non averlo ammesso in una carrozza «per soli bianchi». Plessy aveva ricordato che non esisteva questo divieto fino a quando l’Unione aveva mantenuto la legge in Louisiana, ma che il divieto era entrato in vigore quando l’amministrazione nordista aveva lasciato il potere nelle mani dello stato. Homer Plessy, un giovane ciabattino creolo di pelle particolarmente chiara, aveva volutamente sollevato il caso, sostenuto da un Comité des Citoyens di New Orleans. Fatto scendere dalla carrozza, aveva denunciato il giudice Ferguson della Louisiana che lo aveva condannato. Dopo anni di azioni legali, la suprema legge di Washington sanciva, prima di tutto, che Plessy era solo bianco per sette ottavi del suo sangue (quelli come lui erano detti «octoroon»), stabilendo quindi una differenziazione razziale; e che il divieto era giusto. Aggiunse la corte che negri (anche se solo per un ottavo) e bianchi non potevano usufruire degli stessi locali pubblici. La sentenza fu la base giuridica della segregazione, che durò fino ad un’altra sentenza, nel 1952, che dichiarava illegale la segregazione nelle scuole.
Il caso giuridico dei dagos era invece in via di formazione. Non bianchi, non neri, forse negroidi, discendenti dell’ignobile Annibale che aveva attentato alla grande Roma, sangue hamitico, non ariano, mafiosi, pronti al coltello, erano stimati buone bestie da soma per il lavoro nei campi, cattolici anche se particolari. E tanti, troppi. Il loro futuro, il loro diventare bianchi, dipendeva solo dalla politica. E loro volevano diventare bianchi americani. Nel 1896, appena cinque anni dopo il grande pogrom, sfilarono in massa per le strade di New Orleans sotto le bandiere di Umberto I re di Savoia, chiedendo la «dago clause», ovvero una clausola elettorale che permettesse loro di votare. In sostanza, di non essere trattati come i negri. E loro stessi si definivano «dagos».
Erano tempi incerti. C’erano alluvioni gigantesche, epidemie di febbre gialla, cotone e zucchero crollavano di prezzo ogni anno, piantagioni andavano in rovina. I neri, appena potevano, se ne partivano da quelle terre senza speranza e andavano in Kansas, dove li trattavano meglio, o in Oklahoma, o verso una metropoli lontana che si chiamava Chicago. Lì restava lo zucchero da tagliare, se no marciva; il cotone da raccogliere, se no marciva. E non si trovavano altro che siciliani per spezzarsi la schiena.



