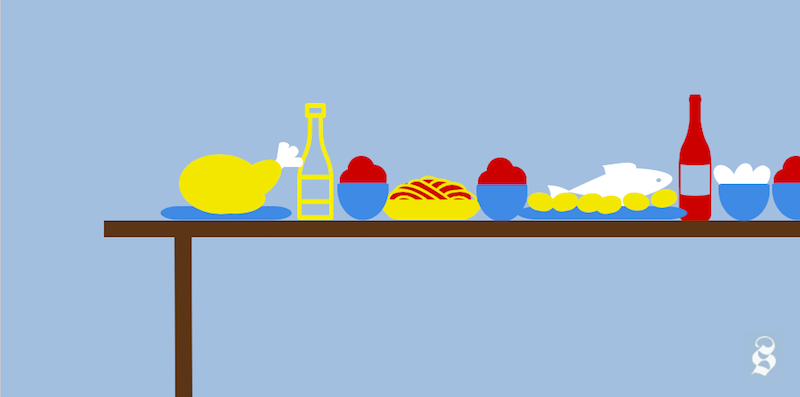Che fine hanno fatto le proteste di Hong Kong?
Sono fallite, in breve: i leader degli studenti sono tornati agli studi e hanno ammesso la sconfitta. Ma hanno dimostrato che qualcosa può cambiare, anche se non subito

Lo scorso 11 dicembre la zona dell’Ammiragliato di Hong Kong – dove da più due mesi si trovava il centro delle proteste dei manifestanti a favore della democrazia – è stato sgomberato dalla polizia: quella notte è stata considerata il momento in cui è simbolicamente finito un grande movimento di protesta che già negli ultimi tempi aveva mostrato alcuni segni di divisione interna e indebolimento generale. La polizia aveva smantellato le barricate, rimosso le tende che formavano il presidio e mandato via i manifestanti che si trovavano nell’area da diverse settimane. Alcuni attivisti, lasciando le loro tende, avevano appeso degli striscioni gialli con scritto “Torneremo”. In totale, durante le proteste che erano andate avanti per circa due mesi e mezzo, erano state arrestate 955 persone – circa 1.900, invece, avevano sporto denuncia contro la polizia. In molti parlano di quello che è successo come di una sconfitta: Hong Kong va verso le elezioni del 2017 con ancora in piedi il metodo deciso dal governo centrale. Altri pensano che un cambiamento, anche se non immediato, sarà comunque possibile.
L’inizio e le proteste
Le proteste di Hong Kong erano cominciate alla fine di settembre: i manifestanti per la democrazia chiedevano maggiori aperture democratiche e autonomie, con il superamento delle pesanti influenze da parte del governo centrale cinese per quanto riguarda l’elezione dei suoi amministratori locali. Chiedevano inoltre che l’attuale governatore Leung Chun-ying, ritenuto troppo vicino al governo centrale, si dimettesse. Il movimento era formato da varie organizzazioni: la Hong Kong Federation of Students, un’altra organizzazione studentesca, “Scholarism”, il cui leader Joshua Wong era anche diventato sulla stampa internazionale il personaggio più raccontato della protesta, e infine gli attivisti di Occupy Central, un movimento locale di disobbedienza civile che nel giugno del 2014 aveva organizzato un referendum non ufficiale per chiedere elezioni libere.
Ad agosto il governo cinese aveva però ufficializzato che alle future elezioni la lista dei candidati sarebbe stata composta soltanto da persone approvate da uno speciale comitato, nominato a sua volta dal governo di Pechino. Dopo settimane di cortei, i giornali internazionali avevano cominciato a occuparsi del movimento a settembre: da quando circa cento persone erano riuscite a entrare in un cortile del palazzo del governo. Inizialmente le manifestazioni erano state piuttosto pacifiche, la polizia locale non aveva usato più di tanto la forza, e le proteste avevano attirato l’attenzione anche di parti più ampie della popolazione che guardavano con curiosità alle iniziative del movimento e alla possibilità del cambiamento. Quei fatti erano stati raccontati fin dall’inizio come il «più tenace atto di disobbedienza civile dal 1997», anno in cui la regione passò dal controllo del Regno Unito – che nel 1841 vi fondò una importante colonia – alla Cina.
Migliaia di persone avevano cominciato a occupare strade e piazze bloccando il traffico, le principali attività e creando dei presidi permanenti. La protesta era stata definita la “Umbrella Revolution” per via dei suoi simboli: oltre agli ombrelli (usati dai manifestanti per proteggersi dagli spray al peperoncino e dai gas lacrimogeni utilizzati dalla polizia) anche nastri gialli, magliette nere, numeri, una canzone, un’app. Erano iniziate delle trattative con il governo, che era riuscito sostanzialmente a sopire le proteste senza repressioni, accettando di avviare dei colloqui sulle richieste del movimento pro-democrazia. I colloqui erano stati però successivamente annullati e la rivolta era entrata in una nuova fase. A metà ottobre, infatti, erano iniziati gli scontri con la polizia: alcuni agenti avevano commesso presunti abusi sui manifestanti ed erano stati temporaneamente sospesi, c’erano stati feriti, arresti, i principali presidi avevano cominciato a essere smantellati.
La crisi
La violenza degli scontri aveva avuto diverse conseguenze: i leader dei partiti che nel LegCo (il parlamento locale) erano all’opposizione avevano cominciato a prendere le distanze dal movimento, accusandolo dell’abbandono della linea non violenta proclamata fino ad allora. Uno dei rappresentanti degli studenti, Alex Chow, aveva ammesso che non erano stati fatti progressi significativi e le diversità tra le organizzazioni che facevano parte del movimento si erano infine essersi trasformate in divisioni. Il 3 dicembre i tre fondatori di Occupy Central si erano consegnati alla polizia di Hong Kong, venendo comunque rilasciati senza accuse. A metà gennaio la polizia di Hong Kong aveva convocato altri quattro leader del movimento, i quattro studenti Joshua Wong, Oscar Lai, Agnes Chow e Derek Lam.
Il primo febbraio
Il primo febbraio a Hong Kong gli attivisti pro-democrazia hanno partecipato alla manifestazione più grande dalle occupazioni dell’anno precedente. Migliaia di attivisti sono tornati a riempire le strade controllati da circa 2 mila poliziotti: molti portavano gli ombrelli gialli e tutto si è svolto pacificamente. L’obiettivo era sempre lo stesso, ma non era prevista alcuna forma di occupazione. La marcia era stata organizzata perché al parlamento di Hong Kong si sta discutendo una riforma per modificare il sistema elettorale, che i parlamentari democratici vogliono boicottare. Alcuni di loro hanno chiesto un incontro con il governo centrale cinese, ma finora non c’è stata alcuna risposta.

Fin dall’inizio, le probabilità di portare il governo di Pechino al tavolo dei negoziati erano molto scarse, ma l’obiettivo dei manifestanti era innanzitutto dimostrare il loro dissenso: «Non è solo una battaglia, è una guerra», aveva detto al New York Times Joshua Wong dopo lo smantellamento del presidio dell’Ammiragliato: «Abbiamo ancora tempo». Per ora i leader degli studenti sono tornati si loro studi: alcuni stanno pensando di dimettersi dalla Hong Kong Federation of Students; altri quando camminano per la strada, scrive il New York Times, vengono riconosciuti, apprezzati da alcuni e rimproverati da altri. Tutti ammettono però la sconfitta della protesta, almeno per quanto riguarda le richieste più immediate.
Salvo sorprese oggi non preventivabili le elezioni del 2017 a Hong Kong si svolgeranno con il metodo deciso dal governo centrale cinese. Niente è cambiato, dunque: «Il governo non ha dato seguito a nessuna delle nostre richieste», ha spiegato uno dei leader delle contestazioni, «ma l’importanza del movimento è stata dimostrare che Hong Kong potrebbe fare di più. Il movimento non ha cambiato la vita quotidiana degli studenti che hanno partecipato alle proteste, ma ha cambiato loro. Attraverso questa rivoluzione hanno dimostrato di saper ragionare con la loro testa e di non non essere politicamente apatici. Un giorno avremo successo. Magari non questo mese o il prossimo anno. Credo che sarà una lunga lotta». Diversi analisti pensano comunque che il movimento dovrebbe cambiare direzione abbandonando l’ipotesi di nuove proteste e occupazioni ed entrando in una fase più programmatica e più efficace nelle trattative politiche.