“Funny girl”, il nuovo libro di Nick Hornby
È la storia di una ragazza che vince un concorso di bellezza e vuole fare l'attrice comica, qui c'è il primo capitolo
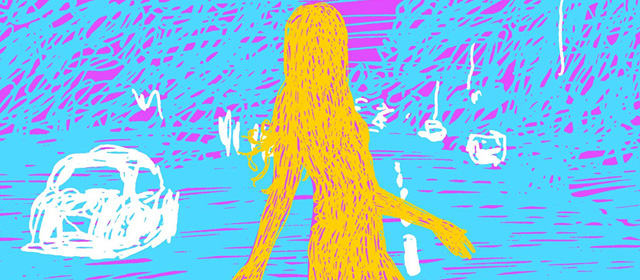
È appena uscito per Guanda Funny girl, il nuovo libro di Nick Hornby, scrittore inglese autore di molti romanzi di successo come Alta fedeltà, Febbre a 90’ e Un ragazzo. Il libro, ambientato negli anni Sessanta, ha come protagonista Sophie Straw, una ragazza di Blackpool che dopo aver vinto un concorso di bellezza decide di lasciare la città dove è cresciuta per trasferirsi a Londra. Lì diventerà la protagonista di una serie della BBC e realizzerà il suo sogno di diventare un’attrice comica di successo imitando il suo mito, Lucille Ball, protagonista della sitcom americana I love Lucy. La traduzione dall’edizione originale è stata curata da Silvia Piraccini.
***
Non desiderava diventare una Miss, ma destino volle che stesse per succedere.
Tra la sfilata e l’annuncio ci fu qualche minuto di inerzia, così amici e famigliari si raccolsero attorno alle ragazze per far loro i complimenti e incrociare le dita. I gruppetti che si formarono ricordavano a Barbara le rotelle di liquirizia Catherine, quelle col cuore colorato: in centro una ragazza in costume da bagno rosa o azzurro caramella e tutt’intorno un vortice di impermeabili neri o marrone scuro. Era una giornata fredda e piovosa di luglio, ai Bagni South Shore, e le concorrenti avevano le braccia e le gambe arrossate e la pelle d’oca. Sembravano tacchini appesi in una vetrina di macelleria. Solo a Blackpool, pensò Barbara, puoi vincere a un concorso di bellezza conciata così. Barbara non aveva invitato amici e suo padre non voleva saperne di mettersi vicino a lei, così era bloccata lì da sola. Lui se ne stava su una sedia a sdraio, a far finta di leggere il Daily Express. Insieme avrebbero formato una rotella Catherine malconcia e sbocconcellata, ma le sarebbe piaciuto lo stesso avere la sua compagnia. Alla fine fu lei ad andare da lui. Allontanarsi dalle altre ragazze la fece sentire mezzo nuda e a disagio, piuttosto che glam e posata, e passando davanti agli spettatori fu costretta a beccarsi le loro espressioni di ammirazione. Quando arrivò da suo padre, fu probabilmente più aggressiva di quanto avrebbe voluto.
«Che cosa fai, papà?» sibilò.
Le persone sedute accanto a lui, annoiate, quasi tutti villeggianti, di colpo si irrigidirono di eccitazione. Una delle ragazze! Lì, davanti a loro! A sgridare suo padre!
«Oh, ciao, tesoro.»
«Perché non sei venuto da me?»
Lui la guardò come se gli avesse chiesto chi era il sindaco di Timbuctù.
«Non hai visto quello che facevano gli altri?»
«Sì. Ma non mi sembrava la cosa giusta da fare. Almeno per me.»
«E in che cosa saresti tanto diverso dagli altri?»
«Un uomo solo, che corre… come un forsennato in mezzo a un mucchio di belle ragazze poco vestite. Mi avrebbero rinchiuso.»
George Parker era un ciccione di quarantasette anni, vecchio prima di averne il diritto. Era solo da più di dieci anni, da quando la madre di Barbara lo aveva lasciato per il proprio superiore dell’ufficio delle imposte, e Barbara capiva che, se si fosse avvicinato alle altre ragazze, in lui si sarebbe acuita la consapevolezza di quella situazione.
«Be’, mica dovevi per forza correre come un forsennato, no?» disse Barbara. «Non potevi startene lì e basta? A parlare con tua figlia.»
«Vincerai tu, vero?» chiese lui.
Lei cercò di non arrossire, ma arrossì. I villeggianti a tiro d’orecchio ormai non fingevano neanche più di leggere il giornale o sferruzzare. La guardavano istupiditi.
«Mah, non so. Direi di no» rispose.
La verità era che lo sapeva. Il sindaco si era avvicinato, le aveva sussurrato un «brava» all’orecchio e le aveva dato una pacchetta discreta sul sedere.
«Ma dai. Sei infinitamente più carina delle altre. Non c’è confronto.»
Chissà perché, considerato oltretutto che era un concorso di bellezza, la sua superiore bellezza pareva irritarlo. Non gli era mai piaciuto che lei si mettesse in mostra, neanche quando faceva ridere amici e parenti con le sue gag in cui recitava la parte dell’imbranata o della svagata o dell’ottusa. Quel giorno, però, quando il punto era proprio mettersi in mostra, sperava di poter essere perdonata; invece niente. Se proprio dovevi partecipare a un concorso di bellezza, sembrava dire suo padre, potevi almeno avere la buona creanza di essere più brutta delle altre.
Lei, per non confondere il pubblico, finse di cogliere nelle sue parole l’orgoglio paterno.
«Che meraviglia avere un papà cieco» disse agli istupiditi. «Tutti dovrebbero avere un papà così.»
Non fu il massimo, come battuta, ma l’aveva pronunciata senza un accenno di sorriso e si guadagnò una risata più fragorosa del dovuto. A volte funzionava la sorpresa e altre volte la gente rideva perché ci si aspettava che ridesse. Lei capiva entrambe le cose, pensò, ma forse era un po’ poco chiaro per chi non prendeva sul serio il ridere.
«Io non sono cieco» disse George, categorico. «Guardate.»
Girò la testa e spalancò gli occhi verso chiunque mostrasse un po’ di interesse.
«Papà, devi smetterla» disse Barbara. «Così spaventi la gente: un cieco che strabuzza gli occhi.»
«Signora, lei ha…» Suo padre indicò maleducatamente una signora in impermeabile verde. «Lei ha addosso un impermeabile verde.»
L’anziana signora sulla sedia a sdraio accanto cominciò ad applaudire, incerta, come se George fosse guarito in quel preciso istante da una disgrazia durata tutta la vita, o stesse facendo chissà quale ingegnoso trucco di magia.
«Come farei a saperlo, se fossi cieco?»
Barbara capì che il padre cominciava a divertirsi. Era rarissimo che si lasciasse convincere a fare da spalla e avrebbe potuto continuare all’infinito a descrivere quel che vedeva, se il sindaco non fosse salito sul palco e non avesse preso in mano il microfono schiarendosi la voce.
Era stata la zia Marie, la sorella di suo padre, a suggerirle di partecipare al concorso per Miss Blackpool. Un sabato pomeriggio Marie, capitata da quelle parti, era passata da loro a prendere il tè e con fare disinvolto aveva buttato lì la notizia del concorso, dopodiché – un’idea improvvisa – le aveva chiesto come mai non ci aveva mai provato, e intanto suo papà se n’era stato lì ad annuire fingendo di essere colpito dalla genialità dell’idea. Per un momento Barbara era rimasta confusa, finché si era resa conto che quei due avevano architettato un piano. E il piano, a quanto aveva capito, era questo: Barbara avrebbe partecipato al concorso e avrebbe vinto, abbandonando così l’idea di trasferirsi a Londra, perché non ce n’era più bisogno. Sarebbe stata famosa nella sua città: chi poteva desiderare di più? Dopodiché avrebbe potuto provare con Miss UK e, se non avesse funzionato, restava la strada del matrimonio, che in fondo era pur sempre un’incoronazione, più o meno. (Anche questo rientrava nel piano del concorso di bellezza, Barbara ne era certa. A Marie non andava a genio Aidan: pensava che Barbara avrebbe potuto trovare qualcuno di molto meglio, o comunque di molto più ricco, e le reginette di bellezza avevano ampia scelta. Dotty Harrison aveva sposato il proprietario di sette negozi di tappeti e si era classificata solo terza.)
Barbara sapeva di non voler diventare reginetta per un giorno, e nemmeno per un anno. Non voleva diventare reginetta e basta. Voleva solo andare in televisione a far ridere la gente. Le regine non facevano mai ridere, o comunque non quelle di Blackpool, e neanche quelle di Buckingham Palace. Ma aveva accettato il piano della zia perché Dorothy Lamour era stata Miss New Orleans e Sophia Loren era arrivata seconda a Miss Italia. (Barbara avrebbe tanto voluto trovare una foto della ragazza che aveva battuto Sophia Loren.) E lo aveva accettato perché non vedeva l’ora di avere la sua vita e aveva bisogno che succedesse qualcosa, qualsiasi cosa. Sapeva che così avrebbe spezzato il cuore a suo padre, ma prima voleva mostrargli di aver almeno tentato di essere felice nel posto in cui era vissuta per tutta la vita. Aveva fatto quel che aveva potuto. Era andata ai provini per le recite scolastiche, aveva ottenuto qualche particina ed era rimasta a guardare da dietro le quinte le ragazze incapaci adorate dagli insegnanti dimenticare battute e rovinare quelle che ricordavano. Aveva fatto la ballerina di fila ai Winter Gardens ed era andata a parlare con uno della compagnia filodrammatica, il quale le aveva detto che il loro prossimo lavoro in programma era Il giardino dei ciliegi, «probabilmente non il suo genere». Le aveva chiesto se voleva cominciare vendendo i biglietti e facendo manifesti. Lei non voleva fare né l’una né l’altra cosa. Voleva che le dessero un copione comico per poterlo rendere ancora più comico.
Sperava di essere felice, era naturale; non avrebbe voluto essere diversa dalle altre. A quanto pareva le compagne di scuola e le colleghe al reparto cosmetici dei grandi magazzini R.H.O. Hills non sgomitavano, non affondavano le unghie, non si davano da fare quanto lei per andarsene da quella città e certe volte avrebbe tanto desiderato essere come loro. E poi non c’era un che di infantile nel voler fare televisione? Non stava gridando: «Guardatemi! Guardatemi!» come una bambina di due anni? Va bene, d’accordo, alcuni, uomini d’ogni età, in effetti la guardavano, ma non come avrebbe voluto. Le guardavano i capelli biondi, il petto, le gambe, ma non vedevano altro. Quindi avrebbe partecipato al concorso e lo avrebbe vinto, e aspettava con terrore lo sguardo negli occhi di suo padre quando si fosse reso conto che comunque non sarebbe cambiato niente.
Il sindaco non arrivò subito al punto, perché non era quel tipo d’uomo. Ringraziò tutti per la partecipazione, fece una battuta inutile sul Preston che aveva perso la finale di Coppa e una battuta crudele sul fatto che quell’anno, per colpa della borsite agli alluci, la moglie non aveva potuto partecipare. Disse che il nugolo di bellezze che aveva davanti – ed era proprio tipo da utilizzare l’espressione «nugolo di bellezze» – lo rendeva ancora più orgoglioso della città di quanto già non fosse. Tutti sapevano che le ragazze erano in gran parte villeggianti arrivate da Leeds, Manchester, Oldham, ma con quelle parole riuscì lo stesso a strappare un caloroso applauso. Siccome non finiva più di parlare, Barbara si mise a valutare le dimensioni della folla contando le teste di una fila di sedie a sdraio e poi moltiplicandole per il numero di file, ma non arrivò mai al risultato perché si perse a guardare una vecchia con un cappello impermeabile e senza denti che macinava all’infinito un boccone di panino. Ecco un’altra ambizione da aggiungere alla sua pila già pericolante di ambizioni: tenersi i suoi denti, al contrario di praticamente tutti i suoi parenti sopra i cinquant’anni di età. Si riscosse giusto in tempo per sentire il suo nome e vedere le altre ragazze rivolgerle un sorriso finto.
Non provò niente. O meglio, si accorse di non avere emozioni, dopodiché sentì una lieve nausea. Sarebbe stato bello credere di essersi sbagliata, di non aver bisogno di abbandonare suo padre e la sua città, credere di aver realizzato un sogno e di poterci vivere dentro per il resto dei suoi giorni. Non volle rimuginare quel suo torpore: temeva di arrivare alla conclusione di essere una stronza odiosa e senza cuore. Quando la moglie del sindaco venne a infilarle la fascia, lei sorrise radiosa, e riuscì a sorridere anche quando il sindaco la baciò sulle labbra, ma scoppiò in lacrime quando suo padre venne ad abbracciarla: un modo per dirgli che praticamente se n’era già andata, che essere proclamata Miss Blackpool non significava neanche lontanamente placare quel prurito che la tormentava come il morbillo.
Non le era mai capitato di piangere in costume da bagno, almeno da grande. I costumi da bagno non erano fatti per piangerci dentro, tra il sole, la sabbia, le grida, i ragazzi con gli occhi fuori dalle orbite. Era singolare sentire le lacrime raffreddate dal vento scorrere giù per il collo e poi tra i seni. La moglie del sindaco l’abbracciò.
«Non è niente» disse Barbara. «Davvero. Sono solo un po’ sciocca.»
«Che tu ci creda o no, so che cosa provi» disse la moglie del sindaco. «È così che ci siamo conosciuti. Prima della guerra. Allora era solo un consigliere comunale.»
«Lei è stata Miss Blackpool?»
Aveva cercato di dirlo senza far trapelare la sorpresa, ma non era certa di esserci riuscita. Il sindaco e sua moglie erano entrambi in carne, ma se nel caso di lui sembrava in qualche modo intenzionale, un segno della sua importanza, nel caso di lei sembrava solo un grande errore. Forse il fatto era semplicemente che a lui non importava e a lei sì.
«Che tu ci creda o no.»
Le due donne si guardarono. Cose che succedevano. Non c’era bisogno di aggiungere altro, ma poi il sindaco si avvicinò e fu lui ad aggiungere qualcosa.
«A guardarla adesso non si direbbe» commentò il sindaco, che non era tipo da lasciare che il non detto restasse tale.
Sua moglie alzò gli occhi al cielo.
«Ho già detto io ’che tu ci creda o no’, due volte. Ho già ammesso di non essere più Miss Blackpool. Ma tu devi intrometterti lo stesso.»
«Non ti avevo sentita dire ’che tu ci creda o no’.»
«Be’, l’ho detto. Due volte. Vero, tesoro?»
Barbara annuì. Non avrebbe voluto essere trascinata in quella discussione, ma almeno questo poteva concederlo, a quella povera donna.
«Bambini e bomboloni alla crema, bambini e bomboloni alla crema.»
«Be’, non che tu sia una bellezza» obiettò la donna.
«No, ma tu non mi hai sposato perché ero una bellezza.» Sua moglie ci pensò e poi su questo punto gliela diede vinta con il silenzio.
«Mentre nel tuo caso, tu eri solo quello» aggiunse il sindaco. «Eri una bellezza. Comunque» disse, rivolgendosi a Barbara. «Lo sai, vero, che questi sono i bagni all’aperto più grandi del mondo? E che oggi, qui, è un grande giorno. Quindi hai tutto il diritto di sentirti sopraffatta dall’emozione.»
Barbara annuì, tirò su col naso e sorrise. Non avrebbe saputo da che parte cominciare per spiegargli che il problema era esattamente il contrario di quello che lui aveva appena illustrato: era un giorno ancora più insignificante di quanto avesse temuto.
«Quella cavolo di Lucy» disse suo padre. «Ne ha, di cose di cui sentirsi responsabile.»
Il sindaco e sua moglie avevano l’aria confusa, ma Barbara sapeva di chi parlava. Si sentì capita, e questo peggiorò le cose.
Barbara si era innamorata di Lucille Ball la prima volta che aveva visto I Love Lucy: tutto quello che provava o faceva arrivava da lì. La domenica, per mezz’ora, il mondo sembrava fermarsi e suo padre sapeva che durante il programma non si poteva cercare di parlarle e nemmeno far frusciare il giornale, perché lei non doveva perdersi neanche una parola. C’erano molti altri comici che amava: Tony Hancock, Sergeant Bilko, Morecambe e Wise. Ma non avrebbe mai potuto essere loro, nemmeno volendo. Erano tutti uomini: Tony, Ernie, Eric, Ernie… Nessuno di loro si chiamava Lucy o Barbara. Non c’erano ragazze che facevano ridere.
«È solo un programma» diceva suo padre, prima o dopo ma mai durante. «Un programma americano. Non è quello che chiamerei umorismo britannico.»
«E umorismo britannico… è la tua personale definizione dell’umorismo originario della Gran Bretagna, vero?»
«BBC e compagnia bella.»
«Capisco.»
Quando smetteva di prenderlo in giro era solo perché si annoiava, non perché lui alla fine ci arrivasse e togliesse alla presa in giro la sua ragion d’essere. Se doveva restare a Blackpool, uno dei suoi progetti era di tener viva una conversazione così per tutta la vita.
«Tanto per cominciare, non fa ridere» disse lui.
«È la donna che fa più ridere di tutte quelle della televisione.»
«Però tu non ridi.»
Era vero che lei non rideva, ma solo perché di solito aveva già visto il programma. Ed era impegnata a rallentare tutto per poter memorizzare. Se ci fosse stato il modo di guardare Lucy tutti i giorni della settimana lo avrebbe fatto, ma il modo non c’era, così poteva solo concentrarsi con tutte le sue forze, nella speranza che qualcosa le restasse impresso nella mente.
«E poi, scusa, tu mi fai stare zitta quando leggono i risultati di calcio alla radio» disse.
«Sì, per la schedina. Uno di quei risultati potrebbe cambiarci la vita.»
Quello che non riusciva a spiegare senza passare per matta era che I Love Lucy era esattamente come la schedina. Un giorno, una delle espressioni o una delle battute di Lucy le avrebbe cambiato la vita, e forse l’avrebbe cambiata anche a lui. Lucy le aveva già cambiato la vita, anche se non in positivo: il programma l’aveva isolata da tutti – amici, parenti, le altre ragazze sul lavoro. Certe volte aveva la sensazione che fosse un po’ come la religione. Prendeva tanto sul serio l’impegno di guardare i programmi comici alla televisione che gli altri la consideravano un po’ strana, così aveva smesso di parlarne.
Il fotografo dell’Evening Gazette si presentò e accompagnò Barbara verso i trampolini.
«Lei è Len Phillips?» gli chiese suo padre. «Non mi prende in giro, vero?»
Conosceva il nome di Len Phillips perché lo aveva visto sul giornale, così ne era rimasto abbagliato. Dio santo, pensò Barbara. E non capisce perché voglio andarmene da qui.
«Ci credi, Barbara? Il signor Phillips è venuto qui ai bagni personalmente.»
«Chiamami pure Len.»
«Davvero? Grazie infinite.» George sembrava un po’ a disagio, però, come se non si fosse ancora meritato l’onore.
«Sì, be’, non avrà migliaia di assistenti» disse Barbara.
«Sono solo io. Più un ragazzo, certe volte» disse Len. «E oggi è un gran giorno per Blackpool. Sarei stato scemo a mandare il ragazzo.»
Fece segno a Barbara di spostarsi un po’ indietro.
«Fai cheese» disse suo padre. «O è roba solo per dilettanti?»
«No, lo usiamo anche noi. Anche se certe volte, tanto per cambiare, io grido ’Slip!’»
George rise e scrollò la testa incredulo. Era il grande momento della sua vita, Barbara lo capiva.
«Niente fidanzato?» chiese Len.
«Non ha potuto prendere un giorno di permesso, Len» rispose George. Fece una breve pausa, evidentemente per chiedersi se si era preso troppe confidenze, troppo presto. «Pare che il personale scarseggi per via delle ferie. Neanche sua zia Marie è potuta venire: è andata a farsi due settimane all’isola di Man. La sua prima vacanza dopo sette anni. È solo una vacanza in roulotte, ma sai com’è, cambiare aria fa bene quanto il riposo.»
«Dovresti scriverle, queste cose, Len» disse Barbara. «La roulotte. L’isola di Man. Cambiare aria fa bene quanto il riposo. Sono solo lei e lo zio Jack, papà? O sono andati anche i ragazzi?»
«Sono cose che non gli interessano» disse il padre.
«Dove lavora?» chiese Len, con un cenno del capo in direzione di Barbara.
«Non lo so. Potremmo chiederlo a lei» disse Barbara.
«È al reparto cosmetici degli R.H.O. Hills» rispose suo padre. «E Aidan è all’abbigliamento da uomo. È così che si sono conosciuti.»
«Be’, non ci resterà ancora molto, vero?» disse il fotografo.
«No?» disse George.
«Io fotografo sempre le Miss Blackpool. Ospedali, spettacoli, feste di beneficenza… Hanno molte responsabilità. Sarà un anno impegnativo. Ci vedremo un bel po’, Barbara, quindi dovrai abituarti al mio brutto muso.»
«Oddio» disse suo padre. «Hai sentito, Barbara?»
Ospedali? Feste di beneficenza? Per un anno intero? Ma che cosa credeva? La zia Marie le aveva detto delle inaugurazioni di negozi e delle luci di Natale, ma lei non aveva pensato che la gente ci sarebbe rimasta male se fosse scomparsa nel nulla, e non aveva pensato che sarebbe stata Miss Blackpool per altri trecentosessantaquattro giorni. In quel momento capì di non voler essere Miss Blackpool neanche per un’ora.
«Dove va?» chiese Len.
«Dove vai?» le chiese suo padre.
Quindici minuti dopo, la seconda classificata, Sheila Jenkinson, una spilungona di Skelmersdale rossa di capelli e un po’ addormentata, aveva in testa la tiara, e Barbara e suo padre erano in taxi e stavano tornando a casa. La settimana dopo, Barbara partì per Londra.
@Nick Hornby 2014
@Ugo Guanda Editore s.r.l



