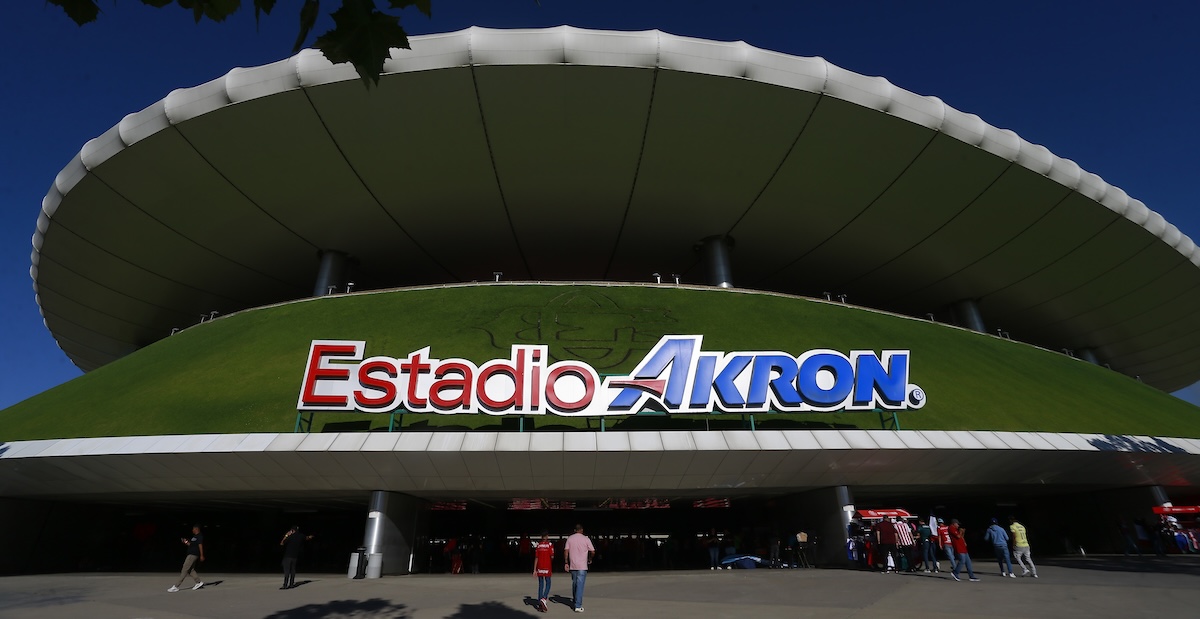Arriva la sentenza su Ferguson
Nella città del Missouri si decide se incriminare il poliziotto che lo scorso agosto uccise Michael Brown: il governatore Jay Nixon ha dichiarato lo stato di emergenza

Il governatore del Missouri, Jay Nixon, ha dichiarato da lunedì 17 novembre e per trenta giorni lo stato di emergenza in attesa della decisione sul caso dell’uccisione di Michael Brown. I 12 giurati del cosiddetto grand jury – una giuria chiamata a stabilire se le prove sono sufficienti per un’accusa formale e dunque per procedere con il processo – dovranno infatti decidere se incriminare o meno il poliziotto Darren Wilson che è bianco e che il 9 agosto scorso sparò e uccise il ragazzo nero di 18 anni. Nel suo ordine esecutivo, Nixon ha fatto riferimento alla «possibilità di estesi disordini», ha ordinato il dispiegamento di un numero maggiore di agenti e ha parlato della possibilità di chiamare la Guardia Nazionale dopo la lettura della sentenza. Le indagini sono state portate avanti sia dalla polizia del Dipartimento di St. Louis sia dall’FBI: entrambi hanno presentato le prove al gran jury, che ha iniziato a valutare il caso a metà agosto. Il procedimento è avvenuto a porte chiuse.
Nella città di Ferguson – contea di St. Louis, Missouri, Stati Uniti – le proteste proseguono da allora con maggiore o minore intensità, ma comunque quotidianamente: si è costituito un gruppo molto esteso a cui partecipano circa 50 organizzazioni che pianifica le manifestazioni e che ha anche raggiunto con la polizia locale un accordo che prevede diverse regole per evitare scontri e violenze. Tra queste regole è previsto anche un preavviso di 48 ore prima della lettura della sentenza. Le proteste, ha precisato più volte in questi mesi il comitato, vanno comunque al di là della vicenda di Michael Brown e hanno a che fare con il razzismo in generale, con le condizioni in cui vive la comunità afro-americana nella contea e con l’atteggiamento spesso discutibile della polizia.
Al di là di questa evoluzione, le proteste sono nate e sono state alimentate dalla prima ricostruzione dei fatti diffusa a poche ore dall’uccisione dello scorso agosto: Brown stava camminando con un amico in mezzo alla strada, tenendo in mano alcuni sigarilli che aveva rubato poco prima in un negozio. L’agente Darren Wilson li aveva fermati – non sapeva del furto – e li aveva invitati a camminare sul marciapiede. Era cominciata a quel punto – ancora non si sa per certo come né perché — una rissa tra Brown e Wilson: nel giro di pochi minuti Wilson aveva sparato sei volte a Brown, che era disarmato e aveva alzato le mani in segno di resa, e lo aveva ucciso. E i manifestanti hanno usato proprio il gesto delle “mani alzate” come simbolo delle loro proteste.
Nel corso di questi mesi, quella prima ricostruzione dei fatti è stata però molto ridimensionata: stando al rapporto del medico legale (che ha mostrato la presenza nel corpo di Brown dell’ingrediente attivo della marijuana) e a una serie di testimonianze dirette, al momento del primo sparo Brown non era con le mani alzate in segno di resa, come si pensava, o comunque aveva appena lottato con il poliziotto cercando di prendergli la pistola.
Il Washington Post – che si è occupato estesamente della ricostruzione – ha raccolto diverse testimonianze che di fatto coincidono con la versione data dal poliziotto: la notte dell’uccisione di Brown, Darren Wilson avrebbe accostato il SUV di servizio e avrebbe aperto la porta per parlare con Brown. Brown a quel punto avrebbe usato entrambe le mani per sbattere la porta del veicolo, di fatto intrappolando nella sua macchina Wilson. A quel punto Brown avrebbe cominciato a colpire in faccia il poliziotto, che a sua volta avrebbe cercato di raggiungere la pistola per difendersi. Brown avrebbe cercato di sottrarre l’arma e Wilson avrebbe poi sparato.