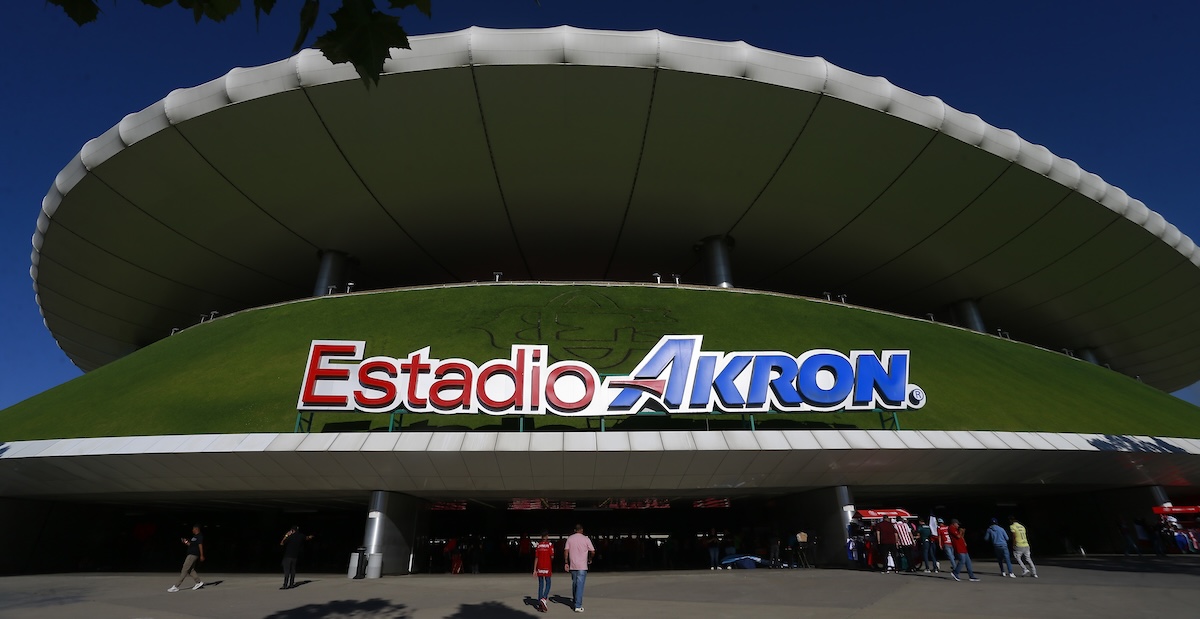Cos’è peggio delle dittature?
Secondo la giornalista Christine Hoffmann la storia recente ci ha insegnato che a volte rimuovere un regime autoritario può causare più danni della dittatura stessa

Questa settimana sul settimanale tedesco Spiegel la giornalista Christine Hoffmann ha cercato di rispondere a una domanda che si è sentita spesso negli ultimi anni: i dittatori sono davvero la cosa peggiore che può capitare a un paese? Si tratta di un problema molto attuale visto che negli ultimi dieci anni abbiamo assistito alla caduta di diversi regimi indubbiamente odiosi, autoritari e violenti. Spesso i dittatori sono stati rimossi direttamente o indirettamente con l’aiuto dei paesi occidentali, con operazioni animate dalla speranza che dopo la deposizione del dittatore di turno arrivasse democrazia, stabilità e crescita economica. Purtroppo, spesso alla fine dei regimi autoritari è seguita l’anarchia che in molti casi ha prodotto più morti e più sofferenza del regime precedente.
L’esempio più noto di questo fenomeno è sulle prime pagine dei giornali internazionali dall’inizio dell’estate: l’Iraq. Nel 2003 il dittatore Saddam Hussein fu deposto a seguito di un’operazione militare americana. Nei dieci anni successivi nel paese ci sono state due violente guerre civili (la seconda è ancora in corso). Tra una e l’altra, ha detto l’ex primo ministro britannico Tony Blair, ci sarebbe potuta essere la possibilità di costruire una società stabile e prospera. Le cose però non sono andate così, e il risultato è che oggi l’Iraq – o almeno una buona parte – è di fatto un paese in guerra. Possiamo confrontare l’Iraq di oggi con quello prima del 2003? Secondo le stime più ampie, tra il 1979 e il 2003 il regime di Saddam causò direttamente la morte di un milione di iracheni (in gran parte a causa della guerra con l’Iran che si combatté dal 1980 al 1988, della repressione dei curdi alla fine degli anni Ottanta e di quella degli sciiti dopo la Prima guerra del Golfo). Secondo l’Iraq Body Count, negli ultimi undici anni – cioè da quando è stato deposto Saddam Hussein ad oggi – circa 200 mila persone sono morte nei combattimenti e nelle violenze che ci sono stati nel paese. Il meglio che si può dire è che la caduta di Saddam Hussein non ha reso l’Iraq più sicuro.
La Libia dopo la caduta dell’ex presidente Muammar Gheddafi è in una situazione simile. Il governo centrale non esercita il controllo su quasi nessuna parte del suo territorio, mentre milizie più o meno indipendenti – ribelli islamisti e fazioni dell’esercito – si affrontano per il controllo del gas e del petrolio. In Siria, anche se il regime non è ancora caduto, la sua presa totalitaria sul paese si è sfaldata e da tre anni è in corso una delle più sanguinose guerre civili degli ultimi decenni. Come scrive Hoffmann, ci sono tutti i motivi per essere felici quando un dittatore cade: in genere significa la scomparsa di un violento criminale sociopatico. E c’è la possibilità che la sua caduta apra la porta alla democrazia, alla stabilità e alla crescita economica (è quello che, almeno per ora, sembra che stia succedendo in Tunisia). Non tutto comunque è meglio di una dittatura.
Il punto, come fanno notare molti scienziati politici, è che le dittature, anche quelle più sanguinarie, sono per definizione molto abili nel mantenere l’ordine e nel conservare il monopolio della violenza. In altre parole, affinché una dittatura funzioni è necessario che abbia un’efficace forza di sicurezza. Certamente questi poliziotti saranno impiegati per reprimere il dissenso, per rapire e probabilmente uccidere gli oppositori politici. Ma molto probabilmente saranno utilizzati anche per evitare, ad esempio, che le varie componenti etniche del paese inizino guerre civili. Un croato bosniaco spiegò così come erano riuscite a convivere le varie etnie jugoslave durante la dittatura di Tito: «Vivevamo in pace e armonia perché ogni cento metri c’era un poliziotto che si assicurava che ci amassimo a vicenda». Nel libro “Il declino della violenza“, lo psicologo evoluzionista Steven Pinker ha raccolto numerose statistiche che confermano questa tesi. I paesi dove è più probabile che scoppi una sanguinosa guerra civile non sono le democrazie e nemmeno le dittature vere e proprie. Sono le vie di mezzo: stati in cui il governo non è in grado controllare il proprio territorio, dove non ci sono efficaci forze di polizia.
Secondo Hoffmann può sembrare una posizione incredibilmente cinica, ma in questi giorni sembra difficile non ammettere che una dittatura oppressiva sia a volte migliore per la popolazione che la subisce rispetto all’anarchia e al fallimento dello stato. Secondo Hoffmann, in Europa siamo oramai abituati a dare per scontato l’esistenza di uno stato funzionante (stati efficienti esistono in Europa oramai da centinaia di anni). Il collasso dell’Unione Sovietica avrebbe rafforzato questa nostra convinzione. Negli anni Novanta in Europa orientale non c’è stata un’anarchia di tipo mediorientale: i vecchi regimi sono stati più o meno pacificamente sostituiti da democrazie più o meno funzionanti (con la parziale eccezione della Jugoslavia). Questo ha creato l’illusione che i dittatori fossero l’unico ostacolo sulla strada della democrazia. Eliminato il regime, libertà e prosperità sarebbero arrivate come conseguenza naturale. La storia del Medio Oriente negli ultimi dieci anni ha mostrato che non è così. La domanda di Hoffmann quindi diventa: la stabilità è un bene di per sé?
La risposta è ovviamente complicata. Non può essere un “sì” a qualunque costo, ma bisogna riconoscere che è un valore: in moltissimi casi nel corso della storia gli esseri umani hanno rinunciato a una parte delle loro libertà proprio in cambio della stabilità. La storia del Novecento è ricca di dittatori (Mussolini, Stalin, Hitler) arrivati al potere dopo un periodo di disordine. Il mondo occidentale deve fare molta attenzione quando decide di intervenire per rimuovere una dittatura, dice Hoffmann, sia che lo voglia fare con i bombardamenti, le sanzioni o l’appoggio alle forze d’opposizione. È fondamentale considerare cosa accadrà dopo che il regime sarà stato rimosso. Secondo Hoffmann questo è esattamente il pensiero dietro la reticenza di Obama a impegnarsi in Siria e negli altri conflitti cominciati in Medio Oriente in questi ultimi anni: «Si tratta», ha spiegato Obama, «di una lezione che applico ogni volta che mi pongo la domanda: “Dovremmo intervenire militarmente? Abbiamo un piano per il giorno dopo?”».