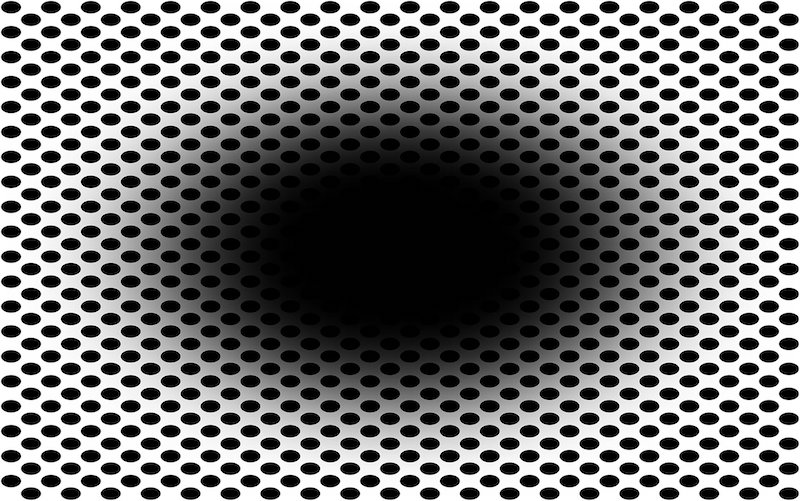Dodici giorni in Liberia, senza toccare nessuno
Li racconta un giornalista del Washington Post, insieme alle tristi e quotidiane complicazioni prodotte dal tentativo di ridurre la diffusione di ebola
di Lenny Bernstein – Washington Post @LennyMBernstein

Stavo facendo lo scemo con un gruppo di ragazzini fuori dalle loro case, in una strada fangosa e piena di buche a New Kru Town, una baraccopoli a nord della capitale Monrovia, in Liberia. Ho fatto una smorfia spaventosa, per scherzo, e loro sono corsi a nascondersi ridacchiando dietro a un muretto. Da lì hanno continuato a sbirciarmi, sperando che continuassi. Alla fine la più furba del gruppo, una bambina di forse cinque anni, è venuta vicino a me avvicinando la mano: «stringimela!», mi ha chiesto calorosamente.
«Non posso toccarti», ho risposto, tenendo le mani sui fianchi, e cercando di nascondere la mia tristezza. «Non posso toccarti».
Non puoi toccare nessuno, in Liberia. Né bambini, né adulti, nemmeno quelli occidentali – i colleghi coi quali sei arrivato. È la regina delle regole: nonostante tutte le precauzioni che si possano mantenere, non sei mai sicuro di dove si annidi l’invisibile e letale virus ebola. Una volta che finisse sulle tue dita, per esempio, sarebbe spaventosamente facile grattarsi l’estremità di un occhio ed essere infettato.
Nei 12 giorni in cui sono stato in Liberia a raccontare la diffusione di Ebola, ho toccato solo due persone (escludendo alcune occasionali strette di mano liberiane, un delicato colpetto fra gomiti, entrambi coperti da vestiti). Una volta ho dimenticato completamente il protocollo e ho stretto la mano tesa di un volontario appena arrivato. Alcuni giorni dopo ho chiesto a un fotografo del Washington Post di sfiorarmi la fronte per capire se avessi o meno la febbre, uno dei primi sintomi dell’infezione da Ebola. Temevo che il mio termometro non funzionasse.
Tutto qui. Nessun abbraccio, pacca sulla spalla, o dammi-il-cinque. Un braccio attorno a una spalla? Impensabile.
La maggior parte dei liberiani, ovviamente, non può permettersi il lusso di queste prudenze. È come se ogni giorno giocassero alla roulette russa con le proprie vite. Premono l’uno contro l’altro nelle file alle fermate dell’autobus, lo sguardo in avanti. Si affollano e spintonano ai centri di distribuzione di cibo. Maneggiano i loro stessi morti. Nella capitale – Monrovia, una città di 1,5 milioni di abitanti – vivono uno sopra l’altro, molti di essi in case fatiscenti che spesso non dispongono di acqua corrente, servizi igienici ed elettricità.
Sono fra le persone più povere al mondo. Pochi, in città, possiedono una macchina. Si stringono dentro a taxi malconci anche solo per andare al mercato, o in qualsiasi altro posto, senza sapere mai se l’ultimo occupante del proprio sedile è stato una persona che stava per morire di ebola, o una che ha disperso il virus nell’ambiente prima di essere portata in un centro sanitario. Nonostante il virus continui a diffondersi, non hanno scelta.
La mia guida e autista, Samwar Fallah, a un certo punto mi ha detto: «il paese sta sopravvivendo per grazia di Dio». Eravamo appena fuori da un centro sanitario per il trattamento dell’epidemia, e stavamo osservando il direttore del posto – un eroico medico di nome Jerry Brown – che cercava di capire se una donna sofferente seduta su una panchina fosse stata infettata dal virus oppure avesse le doglie. Nel caso sia possibile riassumere l’orrore dell’epidemia di ebola in una singola frase, Sam ci era appena riuscito.
Dal numero sempre crescente di morti ed infezioni nell’Africa occidentale non lo direste, ma il virus ebola è piuttosto difficile da contrarre. Al contrario di quello della SARS, non è trasportato dall’aria. Per essere contagiato è necessario entrare in contatto con i fluidi di una persona a sua volta infetta: sangue, vomito, feci, urina, sudore, saliva. E questo, inoltre, deve accadere mentre la persona in questione presenta i sintomi della malattia: febbre alta, vomito, diarrea, occhi arrossati. È per questo che il virus ha causato più di tremila morti fra liberiani e operatori sanitari, e non giornalisti.
Ne ero a conoscenza quando all’inizio di settembre mi sono offerto per andare in Africa a raccontare la più importante storia del momento dal punto di vista sanitario. Il primo agosto avevo scritto un post sul mio blog intitolato «Perché non potrete contrarre Ebola negli Stati Uniti», cosa che al tempo poteva essere un po’ prematura poiché ebola era appena entrata nei nostri radar. Lo avevo scritto in risposta al tweet di Donald Trump il quale chiedeva che a Kent Brantly, il volontario che aveva lavorato vicino a Monrovia ed era in punto di morte per via di ebola, fosse impedito di entrare negli Stati Uniti perché avrebbe potuto importare il virus nel paese. Avevo intervistato esperti in malattie infettive e letto cose su ebola, ed ero abbastanza sicuro del mio giudizio.
Ciò nonostante, ho fatto ancora qualche ricerca prima di dare l’assenso per partire. Mi sono confrontato col giornalista del Washington Post Todd Frankel, che aveva coperto la diffusione di ebola in Sierra Leone. Ho contattato via mail Norimitsu Onishi, il corrispondente del New York Times che – cosa notevole – era in Liberia da settimane, e Nurith Aizenman di NPR, un ex giornalista del Washington Post che aveva scritto da lì. Ho parlato con Claire MacDougall, una collaboratrice freelance del Times che vive a Monrovia, e con un amico di mia moglie che vive lì e lavora per l’agenzia di Sviluppo Internazionale degli Stati Uniti. Il fotografo del Washington Post Michel duCille, che era stato in Liberia altre tre volte prima di allora, si è offerto di venire con me.
Il consiglio era sempre lo stesso: segui alcune regole, e sarai a posto.
Qui, negli Stati Uniti, la reazione alla mia decisione non è stata esattamente composta. Mio padre, un professore di medicina in pensione con decenni di esperienza nel campo delle malattie infettive, mi definì «un gran ****». Il mio migliore amico ha sostenuto che stessi avendo una crisi di mezza età e che non potessi dare un gran contributo mettendo in pericolo me stesso. Un mio amico dell’università mi ha chiamato per dirmi che non si sarebbe più sentito a suo agio a sedersi accanto a me per la partita di football dell’11 ottobre. Aveva fatto due conti, e scoperto che sarebbero passati meno di 21 giorni dal mio ritorno: di conseguenza, avrei potuto avere ancora il virus in incubazione. Mi ha detto che mi riteneva «fottutamente fuori di testa».
Solo mia moglie e mia figlia maggiore, comprendendo all’istante perché volessi seguire questa storia, hanno ascoltato attentamente i pro e contro del viaggio e mi hanno dato il proprio sospettoso benestare.
Le regole di cui sopra sono diventate chiarissime non appena arrivati al decrepito aeroporto liberiano. Alcuni dipendenti, con i guanti di gomma, hanno misurato la nostra temperatura corporea con termometri a infrarossi prima di entrare nel primo edificio della struttura. Il nostro hotel, come qualsiasi altro posto che possa permetterselo, aveva una specie di barilotto con una valvola a rubinetto appena fuori dall’entrata: una di quelle che si usano in campeggio per conservare e dispensare tè freddo. Conteneva una soluzione di acqua e cloro, che uccide il virus. Tutti erano tenuti a lavarsi le mani prima di entrare in hotel o nel ristorante a fianco. I dipendenti spazzavano continuamente i pavimenti con candeggina. Ad ogni ingresso c’era una postazione per sciacquarsi le scarpe con lo stesso liquido. Ce lo portavamo anche in macchina in contenitori spray, applicandolo su mani e scarpe.
Un autista è venuto a prenderci in aeroporto. Un altro ci avrebbe portato in giro per i dodici giorni seguenti (tranne quando ho usato una macchina dell’ONU, assieme a un autista dell’hotel o a un altro giornalista occidentale). Nessun occidentale sano di mente salirebbe su un mezzo pubblico in Liberia, se anche solo esistessero.
Una volta abbiamo offerto un passaggio a Massa Kanneh, una giornalista del quotidiano locale Front Page Africa che mi aveva aiutato a trovare una persona che volevo intervistare. Non preoccuparti, mi ha risposto, prendo un taxi.
Kanneh ha 26 anni, uno in meno della mia figlia maggiore. «Un taxi?» ho chiesto incredulo, «non puoi prendere un taxi. Non hai idea di chi possa esserci salito prima di te». Devo andare a lavorare, mi ha risposto come se niente fosse.
Un’altra volta ho chiesto a un tizio che guidava una motocicletta come facesse a comprare cibo per la sua famiglia. La maggior parte delle persone in Liberia non sta lavorando: posti di lavoro, scuole e altri luoghi dove la gente si raduna – eccetto le chiese – sono chiusi, per rallentare la diffusione del virus. Mi ha risposto che dava passaggi alla gente in cambio di qualche dollaro. Non è molto sicuro, gli ho detto, potresti contrarre il virus. Ha scrollato le spalle e mi ha detto che esaminava attentamente i suoi passeggeri.
Il primo giorno ci hanno portato nei centri sanitari di Monrovia. Erano tutti pieni, o quasi. Fuori c’era della gente malata che non era riuscita a entrare. Intervistandoli, stavo a qualche passo di distanza, come mi aveva suggerito MacDougall, nel caso la persona con cui parlavo starnutisse, tossisse, sputasse, o peggio ancora vomitasse. Prima di partire, avevo chiesto a un esperto la quantità di virus che può contenere una goccia di fluido corporeo. Al momento della morte, quando la diffusione è più alta, mi disse che era compresa fra 500mila e un milione di particelle. Gli ho domandato quante particelle di virus sono necessarie per contrarre la malattia. Fra una e dieci.
I liberiani amano gli occidentali, soprattutto gli americani. La loro nazione, che ha 4,1 milioni di abitanti, fu fondata da schiavi americani liberati. La loro bandiera assomiglia a quella americana. La moneta è il dollaro liberiano, sebbene molto del commercio di tutti i giorni si svolga in dollari. Sono contenti che li stiamo finalmente aiutando, e molti ci hanno avvicinato per parlarci, spesso per lamentarsi di come è stata gestita la crisi ebola e di molto altro. Quando però si facevano troppo vicini, mi allontanavo. All’inizio temevo se ne offendessero, ma poi non ci ho più fatto caso.
All’interno dei centri sanitari per il trattamento della malattia e di un piccolo ospedale nel quale sono entrato una volta, le regole diventavano ancora più severe. Lì dentro, non puoi toccare nulla: neanche un muro, un tavolo o un pezzo di carta. Sebbene il virus si trovi a suo agio nel nostro sangue, soprattutto mentre abbiamo la febbre, può sopravvivere anche su superfici esterne. Nessuno sa con certezza per quanto tempo possa farlo, però. Alcuni studi hanno dimostrato che può rimanere in vita in un periodo compreso fra due ore e due giorni. Mantenere alta la soglia di vigilanza, specialmente quando indossi vestiti a manica lunga nonostante l’umidità liberiana, è stressante. Lo è altrettanto assistere all’aumento costante del numero dei morti. Una volta mi sono appoggiato a un corrimano di legno all’entrata del un centro sanitario diretto da Jerry Brown. «Non toccarlo», mi ha detto immediatamente, ma in modo calmo. Poi mi ha detto di lavarmi le mani.
DuCille non si comportava alla mia stessa maniera. Nonostante si lavasse le mani col cloro tanto spesso quanto me, aveva perso da tempo l’istinto umano di autoconservazione: probabilmente era accaduto quando aveva passato sette mesi a fare foto in posti dove si commerciava droga – o dove era costretto a schivare pallottole – in Afghanistan. In Liberia, è entrato in un ex ospedale di Monrovia che fungeva da centro di trasferimento per i malati e i morti della città, dove i corpi invadevano il pavimento. Questo ha richiesto che si attrezzasse coprendo ogni centimetro della propria pelle con un “kit per la protezione personale”, quelle specie di tute da astronauta che sono diventate un simbolo dell’epidemia. Indossarla e poi togliersela di dosso è un processo lungo e complicato. Un solo errore nella procedura, e rischi che il virus venga a contatto con la pelle. Mi sono rifiutato di andare in qualsiasi posto dove fosse richiesto di indossarlo.
DuCille aveva un’attrazione per i morti simile a quella di una falena per la luce. Il corpo di una persona morta sotto a dei panni stesi ad asciugare è un’immagine forte. Per quanto riguardava me, però, non volevo averci nulla a che fare. Per prima cosa, non c’era nessuno che potessi intervistare. Inoltre non potevo sapere dove quella persona avesse sanguinato, vomitato o defecato mentre stava morendo. Ecco perché gli operatori sanitari devono spruzzare estesamente soluzioni di cloro quando una persona viene trovata morta in pubblico o a casa propria (cosa che sta diventando sempre più comune).
All’inizio della nostra visita, l’UNICEF e il governo liberiano ci hanno portato dentro a un piccolo edificio dove si trovavano bambini rimasti orfani e altri i cui genitori erano sotto osservazione. I maschi dormivano in un singolo stanzone, le femmine in uno diverso. Tutti i ragazzi erano risultati negativi all’ebola, e dunque non dovevamo preoccuparci di rimanere infetti. Abbiamo passato lì circa tre ore, facendo foto e interviste. Pochi giorni dopo, ci ha chiamato uno dell’UNICEF per dirci che c’era stato un errore e che uno dei ragazzi aveva presentato sintomi di ebola: una ragazzina vivace alla quale avevamo dedicato un po’ della nostra attenzione. Era in corso un’indagine per capire cosa fosse successo.
Non avevamo toccato nessuno, ovviamente, ma ho iniziato a farmi tutto un viaggio mentale. Mi ero seduto al suo stesso posto? Mi ero avvicinato eccessivamente? Quando l’avevamo vista, ancora non presentava tutti i sintomi della malattia, e quindi eravamo probabilmente a posto. Ma potevamo dire lo stesso degli altri bambini e adulti che erano lì? E degli altri liberiani e africani che restano vulnerabili al virus? Ancora oggi, non c’è risposta.
Un operatore sanitario disinfetta il corpo di un uomo morto di ebola all’interno di una ex scuola, ora utilizzata come centro per malati, Manrovia, 15 agosto 2014 (John Moore/Getty Images)
©Washington Post 2014