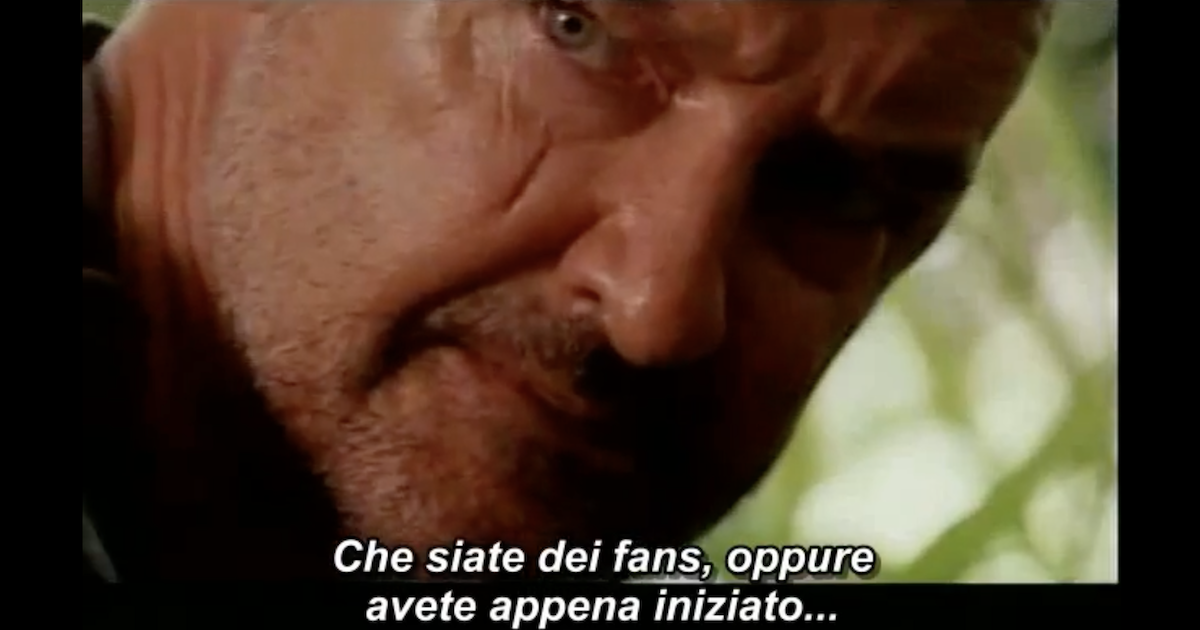«Il desiderio di essere come tutti»
Il racconto del funerale di Berlinguer dall'ultimo romanzo di Francesco Piccolo, da oggi in libreria

Esce oggi per Einaudi Il desiderio di essere come tutti, il nuovo libro di Francesco Piccolo, sceneggiatore, autore televisivo e autore fra l’altro di Momenti di trascurabile felicità e di Allegro occidentale. Nel libro Piccolo racconta la sua formazione personale e politica, e ripercorre in modo personale la storia italiana degli ultimi quarant’anni, dal rapimento di Aldo Moro, ai funerali di Enrico Berlinguer all’entrata in politica di Silvio Berlusconi. Il libro si compone di due parti, La vita pura: io e Berlinguer e La vita impura: io e Berlusconi.
In questo estratto Piccolo racconta gli ultimi giorni di Berlinguer, dalla sua partecipazione al congresso del Partito Socialista a Verona fino al suo funerale.
***
L’11 maggio 1984, nel momento in cui è entrato nel palazzetto dello sport di Verona, e tutto il pubblico ha cominciato a fischiare, io sono diventato Enrico Berlinguer. È stato il momento esatto in cui il mio sentimento pubblico e il mio sentimento privato, che in quei mesi di scontro avevano aderito ogni giorno, sono balzati via da me per infilarsi dentro lo sguardo perduto del segretario del mio partito – che stava davanti a quella gente con la stessa incapacità di organizzare un’espressione che avevo avuto io davanti a Elena che strappava la carta da regalo; ho sentito che mi riguardava così tanto, mi faceva soffrire così tanto, richiamava così precisamente il dolore mio personale, che non ci poteva essere più nessuna distanza tra me e lui; guardavo il suo viso teso, sperduto, e sentivo che con lui c’ero anch’io, anche se non ero lì.
Ho fatto come Mario (Vittorio Gassman) ne La terrazza: guardando giù verso il congresso, ho subito immaginato di essere al posto di – insieme a – Berlinguer; solo che invece di essere applaudito, mi fischiavano.
Non ci hanno fischiato soltanto, hanno cominciato a scandire «sceemooo, sceemooo», mentre braccia si levavano per mostrare garofani rossi e il segno delle corna. Noi avanzavamo seguendo le indicazioni di una signora, avevamo tanta gente intorno che faceva in modo di proteggerci, ma in realtà nessuno stava tentando di aggredirci. Ero Berlinguer per la tristezza e la rabbia che provavo, per l’impotenza identica che sentivamo, là in mezzo a un palazzetto gremito di gente. Non trovavamo la strada, come inebetiti, mentre uno speaker urlava che eravamo loro ospiti e bisognava accoglierci come degli ospiti. Ma i fischi diventavano più forti, anche per coprire la voce dello speaker, e si sentiva anche, insieme, altrettanto limpido, il suono ritmato di sceeemoooo urlato da una specie di coro. Noi eravamo il segretario del Partito comunista, eravamo la persona più amata da tutti, anche dagli avversari, e ci dicevano sceemooo e ci fischiavano in modo assordante. I fotografi intorno scattavano foto per cogliere un’incrinatura del nostro sguardo, ma c’era solo un’aria persa, non del tutto visibile, e poi sembrava che l’unica domanda che arrivasse dai nostri movimenti e occhi interrogativi, fosse: dove ci dobbiamo sedere.
Finalmente arriviamo in una specie di lungo banco – ci hanno indicato il posto, ci siamo diretti lì. Alziamo lo sguardo solo un attimo, in modo quasi distratto, perché a quel punto abbiamo tutta la gente di fronte, un semicerchio tonante, ma è sufficiente per vedere garofani e corna agitarsi di più. Per sentire anche «venduto», «buffone». Poi ci sediamo. Senza aver fatto un solo gesto di insofferenza, di sfida, di accusa. Siamo stati impassibili, anche se scioccati. Perduti.
Craxi parlò tre giorni dopo, nel discorso di chiusura dei lavori. «Mi dispiace che il congresso del partito sia venuto meno ad un dovere di ospitalità nei confronti del segretario del Partito comunista compagno Berlinguer e della delegazione comunista». E qui l’assemblea applaude convinta, come se il segretario la stesse spingendo a delle scuse. Lui se ne rende conto e allora va subito con voce serena contro gli applausi, li copre con uno scandito però – che zittisce tutti.
«Però quando una norma così ben conosciuta anche da noi viene violata, il che è un fatto grave, vuol dire che avviene per una ragione grave». La posizione di Craxi sta deviando verso un’altra conclusione, ma continuando a simulare la denuncia dell’accaduto. Dice: «So bene» – e qui fa una di quelle pause sue, famose, molto lunghe, che sembrano (o vogliono realmente) riacchiappare la chiarezza del pensiero per esporlo in modo ordinato, in quel modo – bisogna ammetterlo – inimitabile, in cui la complessità del giro di frase e la chiarezza del significato, sono inequivocabili. C’è silenzio totale dopo quel «So bene» detto indicando tutti e poi guardandosi intorno come per godersi il conforto della sua gente e fermandosi con lo sguardo fisso in un punto, nel vuoto, come se non dovesse continuare più – poi riprende all’improvviso, rivolgendosi a tutta la platea, di nuovo con il braccio sinistro steso verso l’alto, il dito indice puntato verso qualcuno…
«… che non ci si indirizzava ad una persona» – e qui un’altra pausa, guardando dritto negli occhi tutti, davanti a lui; e poi il braccio e il dito fanno un giro largo, inclusivo: «ma ad una politica che questa persona forse interpreta con maggiore tenacia di altri e non sappiamo fino a che punto convincente anche per tutto il suo stesso partito, una politica che noi giudichiamo profondamente sbagliata». Qui nessuno applaude, perché la virata è forte, violenta. Sorprendente, nonostante l’inimicizia. Ma manca ancora l’affondo teatrale, plateale: ruotando sul posto lentamente, tenendo il braccio largo a includere non più tutti, ma ognuno, per spingerli all’attenzione per ciò che sta per dire, che sembra voglia dire da tre giorni, Craxi conclude:
«E se i fischi erano un segnale politico che manifestava contro questa politica, io non mi posso unire a questi fischi solo perché non so fischiare».
Mentre la sua gente scoppia in un boato entusiasta, lui incurante non la guarda, come se non avesse detto quello che ha detto, con tanta sfrontatezza, ma con altrettanta sfrontatezza abbassa lo sguardo verso il bicchiere d’acqua, lo prende, e beve. Come se la pausa non fosse per il boato di approvazione, ma solo perché aveva sete.
Non si è unito ai fischi che ci hanno fatto, solo perché non sapeva fischiare. Una frase che non è stato mai possibile accettare. Un punto fermo della mia divaricazione, da cui non era più possibile tornare indietro: l’amore per (l’identificazione con) Berlinguer, l’odio per Craxi.
Prima, una collettiva dimostrazione di inimicizia, violenta, mai prima espressa nei confronti di Berlinguer (nostri), da nessuno schieramento avversario. Poi la frase di Craxi. Da uomo libero e autonomo, dico con serenità che non ho (non abbiamo) mai perdonato e che non perdonerò (perdoneremo) mai. Per me Craxi, da quel momento, rimarrà per sempre quello che dice che non ha fischiato solo perché non sa fischiare. Non c’era ancora il crescendo sfacciato del finanziamento ai partiti, il dilagare del potere senza controllo, Tangentopoli, l’esilio di Hammamet e tutto il resto. Tutto quello che è venuto dopo, e che riguarda Craxi e il suo disfacimento personale e politico, non mi ha più toccato nel profondo; certo, mi sono indignato come quasi tutti gli italiani, mi è stato chiaro che i modi di fare politica erano inaccettabili – ma nulla di tutto questo mi ha davvero più toccato. Il mio rapporto con Craxi, di simpatia o antipatia, di speranza per un’alleanza tra socialisti e comunisti, e il resto che (non) ne conseguì, è finito nell’attimo in cui ha detto, studiando così bene le pause, che non aveva fischiato anche lui soltanto perché non sapeva fischiare.
Dopo Verona, Berlinguer cambia tono. Nel direttivo del 5 giugno propone con forza il referendum abrogativo della legge sulla scala mobile, e spinge con altrettanta forza verso una decisione rapida. È evidente, da una parte e dall’altra, che non c’è soltanto una questione di principio, in cui entrambi credevano – sì alla scala mobile, basta con la scala mobile – ma una sfida politica nella quale uno deve uscire vincitore e l’altro perdente.
Due giorni dopo, Berlinguer va a Padova per un comizio per le elezioni europee. Mentre parla si ferma. Non ce la fa, sta male. Il pubblico lo applaude, gli urla «Enrico» per incoraggiarlo. Lui si toglie gli occhiali, beve dell’acqua, poi ricomincia, continua ad asciugarsi le labbra con un fazzoletto, va avanti ma la voce si perde, gli urlano «basta» perché non ce la fanno a vederlo così. Lo fanno smettere con applausi e urla, scandiscono «Enrico-Enrico». Lui riesce a dire una frase finale e poi va via, spinto dalle insistenze delle persone intorno. Arriva in albergo, si stende sul letto dicendo che ha mal di stomaco. Non riprenderà mai più conoscenza.
Il giorno dopo, l’8 giugno, Gerardo Chiaromonte annuncia al Senato che il Pci comincia immediatamente a raccogliere le firme per il referendum abrogativo dell’articolo 3.
Craxi arriva all’ospedale di Padova il 10 giugno. Il fratello di Berlinguer, Giovanni, è sceso in strada a chiedere a tutta la gente di accogliere il presidente del Consiglio con compostezza. Quando l’auto di Craxi si ferma davanti all’ospedale, passa tra due ali di folla silenziosissima. Lo stesso, quando esce.
Berlinguer è in coma. Sono in molti che vanno a omaggiarlo e però anche a osservarlo, e a giudicare dalla sua vita e dalla sua timidezza, non ne sarà stato contento (di nuovo tanti Atteone che vogliono guardare Diana). La famiglia cerca di arginare la processione dei politici, in rispetto del padre e degli altri malati nella sala rianimazione, ma non può opporsi più di tanto. Craxi chiede poi di salutare la moglie e i figli di Berlinguer; ma gli viene fatto sapere che preferiscono non incontrarlo.
Berlinguer muore il giorno dopo, l’11 giugno. Un mese esatto dopo i fischi di Verona.
TUTTI è l’enorme titolo rosso che l’Unità dedica ai funerali in piazza San Giovanni; parla di una folla immensa, forse due milioni. È l’amore per Berlinguer a essere immenso, quel tipo di amore che ho provato io quando ho voluto essere lui per accompagnarlo e proteggerlo al congresso socialista di Verona. Ecco perché il mio sentimento è feroce, digrigno i denti e sento una specie di rabbiosa felicità quando Nilde Iotti ringrazia Pertini e dalla folla parte un lunghissimo applauso, e poi, dopo una pausa breve e faticosa, quasi sospira ringraziando «il presidente del Consiglio» – senza dire Craxi, non si sa se per non aizzare la folla, o per un sentimento di contrasto anche da parte sua; ma è più probabile la prima ipotesi.
La folla di San Giovanni, che riempie la piazza e tutte le strade intorno, comincia a fischiare senza freni.
Qui, durante il funerale, durante questi fischi, la separazione tra due mondi, che era già evidente, diventa definitiva. C’è un mondo che si identifica pienamente con Enrico Berlinguer, con il suo cammino e con quell’ultima fase di resistenza contro un cambiamento che giudicava come l’annullamento di conquiste fatte grazie al suo partito. C’è un altro mondo che appare spietato, vincente, che vuole modernizzare il Paese con disinvoltura, anche con arroganza. Questi due mondi si sono divisi.
Tutti. Sono partiti tutti per piazza San Giovanni, chiunque fosse comunista, chiunque avesse la possibilità di prendere un pullman, un treno, un’auto.
Io, invece, sono rimasto a casa.
A Caserta, a casa mia, da solo.
Quello che so è che avevo deciso di restare solo per una strana pigrizia che mi prendeva sempre, quando sentivo un disagio poco chiaro. E il disagio è stato il sentore che mi ha allarmato. E poi l’ho, appunto, schiacciato.
«Non volevo andare in un posto triste per sentirmi più triste ancora».
«E che c’era di male a sentirsi più triste?»
«Tanto il presidente non può resuscitare. E la cosa non è successa a te. Tutto quello che succede nel mondo non succede a te personalmente».
Sono seduto su una poltroncina larga e scomoda, in camera da letto dei miei genitori. Sto guardando un televisore piccolo, di là ci sono i miei fratelli – i miei genitori sono al lavoro, probabilmente. Mi sono chiuso di qua perché potrei essere osservato mentre guardo le immagini del funerale di Berlinguer. Non voglio. E mentre guardo, qualcun altro è di sicuro entrato in casa, perché nel momento in cui, senza poterne fare più a meno, ho cominciato a piangere senza freni, e ho alzato il pugno verso l’alto, lì, solo nella camera da letto dei miei genitori, seduto su una poltroncina larga e scomoda, mentre a piazza San Giovanni c’erano TUTTI (tutti tranne me, a quel punto) – mi ricordo che ho pensato: speriamo che nessuno apra la porta (più sinceramente: speriamo che mio padre non apra la porta).
E non perché mi sarei vergognato, ma solo perché sarebbe stato un intruso tra noi, noi tutti che eravamo comunisti e amavamo Berlinguer e odiavamo chiunque gli avesse fatto del male – Craxi più di ogni altro. Ma anche mio padre e mia madre, che non erano tutti noi.
Adesso leggo quell’ADDIO rosso a caratteri cubitali tenuto alto dalle braccia di tantissimi per mostrare al mondo di far parte di TUTTI. Provo un dolore precisissimo. E a quel dolore reagisco, sia con disperazione, sia con commozione: piango e alzo il pugno verso l’alto mentre la bara di Enrico Berlinguer avanza lentamente nella strada e io lo saluto da casa dicendo con disperazione che ci sono anch’io, che anch’io sono parte di TUTTI.
Eravamo, probabilmente, l’Italia civile e moderna a cui si rivolgeva Berlinguer l’anno prima, in un discorso che sembrò definitivo. In cui ribadiva l’alternativa alla politica come si andava svolgendo, e l’alternativa per come si stavano caratterizzando quegli anni. Chiunque legga il discorso del congresso dell’83, lo unisca a quello sull’austerità, alla scelta di andare all’opposizione solitaria e all’intervista sulla questione morale e contro i partiti, si identifica con facilità. Perché Berlinguer e il suo popolo avevano una simbiosi, una sensibilità comune; e non c’è dubbio che avevamo molte ragioni. Una proposta all’Italia civile e moderna è un ritratto nero dei tempi, tutto negativo sui valori nuovi. È un appello a una parte del Paese, quella comunista. E anche alla parte migliore non comunista: lasciar perdere quella politica e quei modelli di vita, e unirsi a noi per ricostruire l’Italia dalle fondamenta. La relazione del congresso, in fondo tra le meno interessanti della lunga carriera di Enrico Berlinguer, si caratterizza per una scelta definitiva: non far parte del mondo dominato da potere, cinismo, egoismo, e infine superficialità. Nella sostanza, Berlinguer non soltanto si rifiuta di far parte di governi democristiani e socialisti (a cui nessuno gli aveva chiesto di far parte), ma intraprende un atteggiamento più ampio: questo non è il nostro mondo, noi ce ne tiriamo fuori, per farci custodi di valori che non devono essere perduti. È il gesto che ha già fatto nel 1980, quando comincia a fondare i due valori guida che poi si delineano nella conversazione con Eugenio Scalfari del 1981: noi siamo un altro Paese, migliore di quello che vediamo, noi vogliamo difendere e conservare la purezza dell’etica e della volontà che ci caratterizza. Tutti i valori a cui teniamo non si vedono più nel mondo che è cambiato, quindi noi erigiamo una barriera a difesa di quei valori.
Ovviamente, decidere di tenersi fuori e di difendere i valori perduti vuol dire non partecipare più al presente, in qualche modo nemmeno occuparsi più di comprenderlo.
Nella sostanza le caratteristiche erano diventate due: essere diversi dagli altri – in un modo che è possibile definire: la purezza; frenare il forsennato ammodernamento della società – un atto che è impossibile non definire: la reazionarietà.
Se io stavo in mezzo, se cioè seguivo tutte le idee di Berlinguer da quando ero diventato comunista, e se allo stesso tempo vivevo una vita borghese e allegra che adesso veniva identificata con il cinismo e il godimento craxiano, dovevo scegliere. O meglio, è chiaro che avevo già scelto – o ancora meglio: non avevo scelta. Adesso dovevo fare di più: dovevo strapparmi a una parte di me. Quando Berlinguer cerca e trova la purezza, io devo accoglierla e prenderla insieme a lui, tutta, come gli altri.
Il sentimento della purezza – parlo di sentimento perché in tutti e due gli episodi si tratta di emotività, non di pensiero – appare incontestabile in me, spazzando via ogni esitazione e anche il pudore di ciò che ero stato fino ad allora, insieme a Berlinguer, entrando con lui – come se fossi lui – nel palazzetto dello sport di Verona. Ecco cosa ho fatto: mi sono messo accanto alla purezza, e ho sfidato tutti quei fischi impuri che arrivavano. Non era merito mio, molto probabilmente, ma colpa della violenza e del senso di ingiustizia che sentivo verso di noi. Entravamo in quel palazzo con la testa alta perché difendevamo le persone giuste e rifiutavamo di cambiare le cose. Io e Berlinguer avevamo lo stesso orgoglio, in quel momento, l’identica convinzione di stare dalla parte della ragione.
In quel momento, quindi, ho avuto la possibilità di riscattare la mia vita impura fino ad allora. In questo ciclo di conseguenze che derivavano da San Valentino, avevo però compiuto un movimento davvero strano: mi ero mosso dal punto in cui ero, di fronte a Elena sul motorino e con lo Snoopy nella tasca, ed ero salito sul motorino con lei, indignato come lei: però, in questo modo, di fronte a noi, a me ed Elena, non c’era più nessuno. Cioè, non c’ero più io.
Ero diventato comunista perché sentivo ripetere dal segretario del partito e dalla sua gente, di continuo, la parola progresso, la volontà di cambiare il mondo. Erano contraddizioni che con tutta evidenza si addensavano nella mia testa a formare quel groviglio che poi sarebbe stato difficile sciogliere. Presa coscienza di questa diversità, misi in campo la superficialità che avevo imparato in altre occasioni: e scalciai tutto questo alzando il pugno e piangendo lacrime sincere e piene di dolore per la morte di Enrico Berlinguer.
Ho espiato, mi sono detto, non andando al funerale. Mi sono purificato. Sono pronto. E il giorno dopo, quando ho letto TUTTI sulla prima pagina dell’Unità, mi sembrava che ormai ci potevo essere anch’io. Che ce l’avevo fatta. E l’aggrovigliato malessere che era salito su per le ossa, era sotterrato, non sapevo nemmeno dove.
Noi a quel funerale eravamo l’Italia civile e moderna (lo eravamo senza alcun dubbio) e avevamo la percezione che il cambiamento in atto portava verso il peggio. Quel TUTTI si diffonde e materializza. Tutti a sinistra diventiamo così: puri e reazionari.