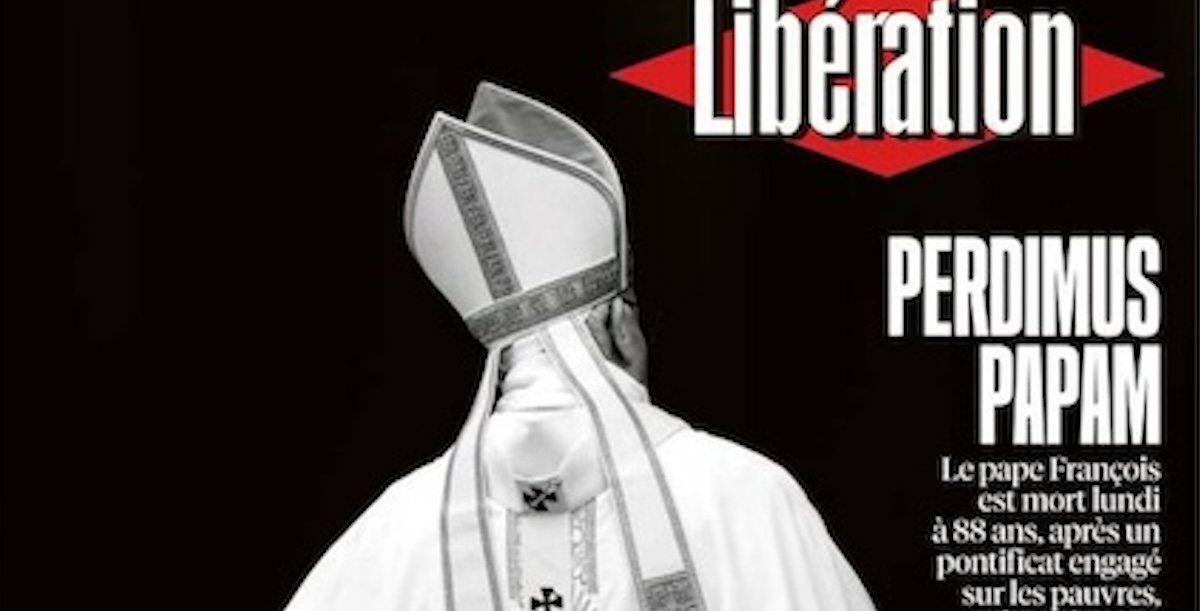«È finita qui»
L'ultimo editoriale nella storia dell'Europeo racconta un giornale di grandi inchieste e grande qualità che nell'informazione contemporanea non ci sarà più
di Daniele Protti
Da oggi è nelle edicole l’ultimo numero del mensile L’Europeo, introdotto da questo editoriale del direttore Daniele Protti che annuncia la chiusura del giornale.
Il 22 febbraio 1995 uscì l’ultimo numero de L’Europeo settimanale. Questo era il titolo di copertina:
1945-1995
Grazie e arrivederci
L’editoriale del direttore “terminale” (il sottoscritto) spiegava che il consiglio di amministrazione di RCS aveva deciso di «sospendere le pubblicazioni», dopo 50 anni, e concludeva: «È un arrivederci. Già, perché non è finita qui». Due giorni dopo usciva in edicola anche un Europeo speciale: stessa carta e stesso formato (più grande dei quotidiani di oggi) del primo numero, quello del 4 novembre 1945, tutto in bianco e nero, con la riproposizione dei protagonisti di quella straordinaria storia di giornalismo (iniziata con Gianni Mazzocchi come editore, cui subentrò Angelo Rizzoli). Titolo dell’editoriale: Ultima edizione. Ma non finisce qui.
In quello speciale si raccontava la storia di un giornale unico, soprattutto nella prima fase. Grandi direttori come Arrigo Benedetti (il fondatore), Giorgio Fattori, Tommaso Giglio, Mario Pirani, Lamberto Sechi. Giovani cronisti, scrittori e collaboratori poi diventati grandi firme: Camilla Cederna, Tommaso Besozzi, Oriana Fallaci, Giorgio Bocca, Eugenio Scalfari, Mario Pannunzio, e successivamente Lina Coletti, Enzo Magrì, Massimo Fini, Mino Monicelli; era anche il giornale di Salvatore Giannella, Roberto Leydi, Lanfranco Vaccari e di tanti altri. Nella redazione iniziale figuravano personaggi come Luigi Barzini, Renzo Trionfera e Vittorio Zincone; poi arrivarono autori-fotografi indimenticabili come Gianfranco Moroldo, Ferdinando Scianna, Gianni Roghi, Duilio Pallottelli, Fedele Toscani (sì, il padre di Oliviero, che poi pubblicò il suo primo servizio su don Lorenzo Milani proprio sul settimanale), Evaristo Fusar, Stefano Archetti, Piero Raffaelli, Enzo Luceri, Maurizio Bizziccari, e quel Francesco Zizola che proprio al settimanale iniziò a farsi le ossa, prima di vincere nove premi al World Press Photo come autore Magnum e prima di fondare l’agenzia Noor.
L’Europeo era un giornale al quale collaboravano intensamente scrittori come Alberto Moravia, Anna Maria Ortese, Ennio Flaiano, Manlio Cancogni, Alberto Ongaro (poi assunto definitivamente e protagonista, con Moroldo, di straordinari reportages), Carlo Bo, Achille Campanile. Si potrebbe continuare a lungo citando i cronisti/reporter che hanno realizzato inchieste di prim’ordine. La redazione (soprattutto dagli anni cinquanta all’inizio degli ottanta) era ammirata e invidiata dalla concorrenza. senza contare che su L’Europeo di quella fase comparivano anche scritti di John Steinbeck, Jack Kerouac, Malcolm X, John Huston, Indro Montanelli (che firmava una rubrica come Marmidone), il cardinale Jean Daniélou, Curzio Malaparte, Oreste del Buono e altri ancora.
Per capire la “filosofia” informativa e culturale di quel giornale è illuminante leggere questo articolo del direttore/fondatore Arrigo Benedetti, apparso sul n.31 del 30 luglio 1950, dal titolo I giornali non sono scarpe:
Cari amici, il cinque luglio nelle prime ore del mattino la Radio italiana comunicava che Salvatore Giuliano era stato ucciso in un cortile di Castelvetrano. Il nostro redattore Tommaso Besozzi raggiungeva la Sicilia, interrogava carabinieri e cittadini, faceva sopralluoghi nel cortile dove il capitano Antonio Perenze aveva cercato acqua per dare da bere al bandito morente, e concludeva con una logica rigorosa e brillante che Giuliano non poteva essere stato ucciso nelle circostanze indicate dal comunicato ufficiale. Intanto, mentre il nostro inviato speciale seguitava la sua inchiesta tra Castelvetrano e Palermo, tra Palermo e Montelepre, un’altra indagine veniva svolta dal capo della nostra redazione romana Nicola Adelfì. Il titolo di questo secondo articolo sulla morte di Giuliano suonava clamorosamente: «Lo uccise nel sonno Gaspare Pisciotta». E i riflessi che supponevamo numerosi non sono mancati. Il nostro compito almeno per il momento era esaurito. Tirate le somme potevamo concludere d’avere svolto un discreto lavoro, non tanto per i risultati raggiunti quanto per avere vinto quella fatale sonnolenza che invischia la vita italiana durante la stagione estiva. Ma possiamo mettere sul conto di questa pigrizia estiva il modo con cui i risultati del nostro lavoro sono stati ripresi dalla stampa quotidiana? «Un settimanale di Milano afferma», «un settimanale settentrionale dice», «un giornale milanese ha scritto… ». In Italia non si va più in là, costume che, a mio giudizio, non deve essere criticato riferendoci alle norme della cortesia. Infatti, pretendere che una amministrazione editoriale faccia pubblicità a un’altra amministrazione editoriale sarebbe troppo. Certi favori non se li scambiano tra loro i fabbricanti di scarpe ed è quindi giusto che non se li facciano i fabbricanti di giornali. Un paio di scarpe certo non ha vita lunga: dopo il servizio scompaiono. Anche i giornali passano di mano in mano finché caduti a pezzi vanno a raggiungere le vecchie scarpe; ma qualche cosa resta di loro. Oh, lo sappiamo, non molto! Ma il fatto che l’Europeo sia stato il primo a dare notizia del flirt cominciato nel settembre del 1948 tra Tito e gli americani, e che per primo avesse scoperto che il colonnello Valerio e il ragioniere Walter Audisio erano la stessa persona (l’Europeo del 9 marzo 1947) può far sì che domani uno storico curioso di analizzare le fonti di certi avvenimenti storici ricorra alla collezione del nostro settimanale. Cari direttori dei quotidiani italiani, ve la immaginate l’irritazione di quello storico di là da venire quando, capitatogli su un quotidiano della scorsa settimana un riferimento abbastanza importante alla morte di Giuliano, si trova costretto a perdere tempo per stabilire il titolo del settimanale citato con tanta avarizia? No, cari amici, i nostri giornali non hanno il sospetto di poter servire domani allo storico del secolo XX. O almeno, dal modo con cui sono compilati, paiono non averlo. Tutti presi come siamo a contenderci la penna di articolisti brillanti per i quali la realtà è solo un pretesto, tutti fedeli ad un giornalismo di tradizione floreale, appena succede qualche cosa che ci costringa a citarci ce la caviamo sempre con un «giornale di sinistra», con un «confratello del mattino», con un «organo d’estrema destra». Chissà quali saranno le supposizioni dello storico di domani, se quel galantuomo, vinta la prima reazione, vorrà considerare il fenomeno e scoprirne le intime ragioni. Penserà: « Lo facevano per ragioni di concorrenza commerciale… No, per polemica politica…». E quale che sia la conclusione, troverà in questo nostro atteggiamento un tantino di meschinità. No, cari amici, i giornali non sono come le scarpe. Possono finire al macero, ma qualche cosa di loro resterà. Certe volte ho l’impressione che noi giornalisti, così spesso accusati di superbia, si sia troppo modesti e quasi si creda che i libri di storia si facciano soltanto con i libri di storia.
Suggerisco ai lettori una riflessione proprio sull’ultima frase
«… quasi si creda che i libri di storia si facciano solo con i libri di storia».
Storia è la parola chiave per comprendere l’ispirazione dei 105 numeri di questa rivista dal 2001 a oggi. storia: raccontare l’attualità ma legandola sempre al passato. In altre parole non un flash, ma una sequenza. Perché parlare dell’oggi senza conoscere ciò che è accaduto ieri porta a comprendere poco e male proprio l’attualità. In questi 12 anni L’Europeo rivista (nel 2001 numero unico, poi trimestrale, bimestrale, mensile) ha sempre cercato di seguire questa ispirazione culturale ed editoriale, sia attingendo allo straordinario tesoro del settimanale sia arricchendolo con nuovi contributi di reporter, autori e fotografi (ne cito solo una parte, per limiti di spazio: Davide Monteleone, Luigi Baldelli, Massimo Mucchetti, Antonio Calabrò, Valerio Evangelisti, Predrag Matvejevic, Livio Senigalliesi, Carlo Verdone, Valerio Pellizzari), oltre ai colleghi e amici del Corriere della Sera (Sergio Rizzo, Gian Antonio Stella, Ettore Mo, Antonio Ferrari, Marco Imarisio, Lorenzo Cremonesi, Aldo Cazzullo, Paolo Valentino, Beppe Severgnini, Massimo Nava, Gianluigi Colin) e ancora Claudio Carabba, Sandro Provvisionato, Claudio Lazzaro, Claudio Rinaldi (che era stato direttore agli inizi degli Ottanta).
Ogni numero di questa rivista ha sempre cercato di sviluppare un tema. I grandi casi di cronaca nera, la storia della nazionale di calcio o della Rai, il design italiano (in un numero oversize realizzato in collaborazione con la Triennale di Milano proprio per l’apertura del Museo del design), il cinema (declinato in vari modi, dalla storia della Mostra di Venezia a quella degli Oscar, fino ai tre recenti numeri sulle icone: attrici, attori, registi che hanno fatto grande il cinema italiano del Novecento), la chiesa cattolica, le grandi questioni internazionali (la vicenda del Muro di Berlino, dagli inizi alla caduta, le guerre balcaniche, il “vento del Maghreb”, le storie di Israele e della Cina, a 60 e a 50 anni dalla loro fondazione), la mafia e le mafie compresa la ’ndrangheta che si è sviluppata al Nord e poi le vicende di Cuba e del Sudafrica, della Germania postbellica fino ad Angela Merkel, la Grecia, dai colonnelli alla crisi attuale, la storia della Fiat, dal fondatore Giovanni Agnelli senior a Sergio Marchionne.
Fino ad arrivare al tema più caldo di questo periodo: il Deficit Italia, la vicenda dimenticata del debito pubblico. argomento sul quale spesso si leggono interventi (sulla carta stampata e sul web) che si limitano alla fotografia dell’oggi e che ignorano come il debito si sia formato e con quale profondità (nel sempre più stretto rapporto tra pubblico e privato, largamente assistito) abbia inciso sul tessuto sociale economico-politico del Paese. È un problema di quella che si può chiamare la “cultura di massa” di questa fase storica. che spesso si traduce in incultura, proprio perché esiste una diffusa ignoranza dei percorsi precedenti.
Nel suo piccolo questa rivista per 12 anni ha cercato di sviluppare un itinerario di conoscenza utilizzando immagini e testi selezionati e realizzati in nome della qualità. È un ingrediente che dovrebbe essere al primo posto in tanti settori della vita sociale, culturale e produttiva (compresa quella editoriale: informazione e comunicazione). Ma spesso viene sacrificato sull’altare «di nuove religioni che promettono scorciatoie», come ha scritto Pier Luigi Vercesi nel suo editoriale su Sette (il settimanale del Corriere della Sera) del 24 maggio scorso, dal titolo Se il web non è tutto. così spiegava Vercesi:
«La diffusione del web ha spostato in massa capitali e capacità di moltiplicarli da molti settori dell’economia e della società verso i produttori di tecnologie e i venditori di connessione… per i tecnocrati meno illuminati tutto ciò, vale a dire l’obiettivo finale a cui la tecnologia dovrebbe facilitare l’accesso, è definito “contenuti”, generici figli di un dio minore che non meritano remunerazione: i “contenuti” si trovano e si rubano in rete, quindi sono gratis. Perché la ricchezza deve rimanere tutta a chi produce tecnologie e le innova con i tempi decisi dagli uffici marketing.
Ne consegue l’illusione momentanea (poi la pagheremo cara) che la professionalità, la cura, la dedizione, l’invenzione e la creatività sono argomenti fasulli messi in campo dalle diverse caste che mirano a proteggere i loro privilegi. Basta un nulla, un clic, per illudersi di saper fare qualsiasi cosa, dall’informazione a un’opera letteraria, dall’amministrazione di un’azienda all’organizzazione dello Stato. Ai produttori di tecnologie va benissimo: più i consumatori credono che basti acquistare i loro prodotti per essere qualcuno, più i loro fatturati fioriscono. La religione del click-tivism, l’attivismo digitale, ci fa sentire grandi senza aver dedicato un giorno a imparare qualcosa. e così prendono forma le nuove superstizioni di cui è invasa (e a volte invasata) la rete… Detto questo, se internet è, come sicuramente è, il nostro futuro, dobbiamo educarlo ed educarci alla convivenza. Deve essere realmente un mezzo che ci migliora la vita, non il fine che la peggiora. Qualcosa che unisce, non divide, che rende tolleranti, non insofferenti… così mi chiedo: è davvero assurdo immaginare che le multinazionali si facciano carico di un acculturamento della rete che tanto li arricchisce?».
Vercesi (che nel 2000 aveva fondato il primo giornale su internet, Il Nuovo) coglie perfettamente, a mio parere, le due falsificazioni/esagerazioni sempre più diffuse: il business è lì, sul web; il sapere è lì, sul web. Il business: chi oggi lo realizza (a parte Apple, Samsung, Aamazon, il proprietario di Facebook, ecc.)? Gli esempi che vengono dal New York Times e da alcune aziende editoriali tedesche (e non solo) dimostrano che un percorso “virtuoso” è possibile, ma comporta investimenti mirati (cioè pensati: strategicamente e con i tempi dovuti), affiancando – vedi il NYT – prodotto editoriale/cartaceo all’edizione online, ma con una diversa offerta di notizie, servizi (a pagamento) e chiavi di lettura (grazie agli archivi).
Esempi recentissimi dimostrano che il mantra del “business è ormai solo nel web” è una bufala o forse una profezia, comunque non è la indiscutibile fotografia del presente. Il settimanale americano Newsweek nel 2012 decise di chiudere l’edizione cartacea quando aveva più di un milione e 400mila abbonamenti, oltre alle vendite in edicola. Un mese fa ha chiuso anche quella online, perché aveva raccolto poco più di 400mila abbonamenti: aveva quindi perso ben più di un milione di copie (tra abbonamenti ed edicola). Negli Stati Uniti diversi quotidiani locali (anche di città con oltre mezzo milione di abitanti) sono tornati all’edizione cartacea perché hanno verificato che il business (o almeno i conti in pareggio) non era venuto dal web, anzi. Il francese Le Monde ha rinnovato splendidamente l’edizione cartacea e l’ha affiancata ad altre offerte, compresa l’edizione online.
Il nuovo comandamento del “business solo sul web” rischia di essere fallace e pericoloso su due fronti: la reale remuneratività da una parte (il che significa fare e comunicare conti precisi e veritieri, non propagandistici), l’informazione e il sapere dall’altra. Già, il sapere. La cultura. Cultura diffusa, intendo. Non il cinguettio di Twitter (che diventa quasi sempre scambio di battute più o meno tranchant in 140 click). Capisco che affrontare questi problemi possa essere frainteso come un atteggiamento resistente, ma perdente, alla Fort Alamo. Non si tratta di questo. È semplicemente una questione di buon senso. Non si governa la rivoluzione digitale con un click sulla tastiera. Ci sono tempi e valori da considerare, in qualsiasi trasformazione. Altrimenti si cade nell’antica, e perniciosa, suggestione miracolistica.
Perché anche nell’esaltazione di quella che, con una battuta, si potrebbe considerare la “cultura sincopata” del mondo Twitter (e comunque di tutta la frenetica messaggistica con i telefonini), si rischia di perdere il valore anche economico di una parola chiave: qualità. Parola che spesso insospettisce qualche manager, soprattutto quelli digiuni di esperienza in settori come la comunicazione. Quindi esposti al pericolo di cadere in fallaci sicurezze o, almeno sinora, indimostrate o comunque – nella migliore delle ipotesi – parziali verità (business = web). Il quadro complessivo è più frastagliato, e non aggiungo nulla a quanto scriveva Pierluigi Vercesi su chi, ieri e oggi, fa davvero, conti alla mano, business sul web (i produttori di tecnologie).
Questa rivista (dal notevole prezzo di copertina, distribuita a malapena nel 15-20% delle edicole italiane) ha cercato di essere all’altezza del suo prestigio e della storia di una grande casa editrice come la Rcs Rizzoli Corriere della Sera. Ora si chiude (never say never, mai dire mai, riaffiora nel cuore, più che nella mente). Alla splendida e sparuta squadra che – in periodi diversi – nei 12 anni ha contribuito a realizzare questa rivista (Valeria Palumbo, Valentina Strada, Antonio Meda, Lucia Pisciotti, Leda Balzarotti, Barbara Miccolupi, Sara Brusamolino, Alessia Tinelli, Lorenzo Franculli, Anna Maria D’Urso, Giulio Saetta, Fabrizio Zeri Guerra e altri collaboratori) va un profondo ringraziamento che spero non sia solo mio. Ora non posso ripetere un arrivederci e scrivere nel titolo “non è finita qui”. È stata una straordinaria avventura professionale, umana e culturale. Ma si conclude per quello che ritengo un errore di strategia culturale ed editoriale. Purtroppo.