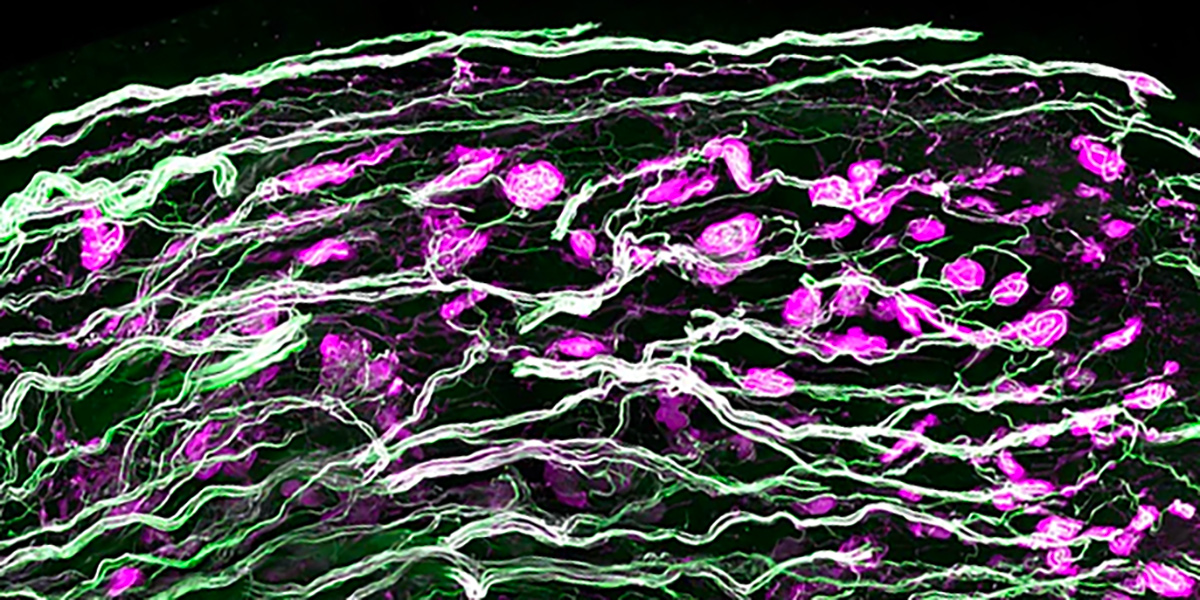Cate, io
Il primo capitolo di un romanzo di formazione che ha per protagonista una ragazzina obesa: è scritto da Matteo Cellini ed è tra i 12 finalisti del Premio Strega
di Ilaria Gozzi - Caffeina

Cate, io, romanzo d’esordio di Matteo Cellini, pubblicato nel 2013 da Fazi Editore nella collana “Le strade”, è la storia di Caterina, un’adolescente cresciuta a Urbania, una piccola città nelle Marche. Caterina è una ragazza obesa, la sua esistenza è una lotta continua, con una corazza di diffidenza e ostilità verso gli altri. È costretta ad affrontare gli sguardi e le cattiverie della gente, di quelle “persone” normali in guerra con le “non-persone” come lei, condannate dalla massa per un difetto fisico. L’unico luogo in cui Cate è a suo agio è quello delle mura domestiche, con la sua grassa famiglia che la circonda: la madre e il padre; Gionata, il fratello genietto del web; il piccolo di casa Oscar e la nonna, che condivide con la nipote la passione per i libri. Per Cate gli unici contatti con la realtà esterna sono la sua professoressa d’italiano, che incoraggia l’amore per la letteratura della giovane e Anna “l’annoievole”, amica sempre pronta ad ascoltarla e sostenerla.
Cellini racconta una storia di ordinaria anormalità in una società dell’immagine ossessionata dalla perfezione, coniugandola con il romanzo di formazione. “Cate, io” è tra i dodici finalisti del Premio Strega e, in occasione della rinnovata collaborazione con il Festival Caffeina Cultura, pubblichiamo le prime pagine del libro.
***
Uno
Mi chiamo Caterina mentre mio fratello attorciglia elastici alle cose nell’altra camera e mia madre chiama. È freddo come di regola ogni mattino, sarebbe da cucirsi il piumone addosso ma me ne sto così, col pigiama solamente. Scendo dal letto, e sono ancora Caterina. Sento le cose di là strette tra gli elastici staccarsi, immagino l’infinità di nodi sciogliersi e la gioia del lieto fine. In cucina è appena più caldo, papà già da un pezzo è ai fornelli e il caffè macchia di un odore forte l’aria come un cane dalmata. Sulla tavola è pieno di cose che non mi appartengono, molte sono di mio padre. Ha gli abiti da lavoro coi segni dei pennelli e tutto il resto; Oscar siede già tutto sporco di latte e biscotti intorno alle labbra, ha un naso rotondo come un bottone da cappotto, rosso come un pulsante per la distruzione del mondo, e mi viene da spingerlo, e mi viene da dire pulisciti, non è un trogolo quello, ma ci rinuncio. Mia mamma scende le scale in vestaglia, impreca contro gli elastici, dice mangiamo senza di lui che non può proprio lasciare. Mangiamo e siamo noi misura di tutte le cose, mangiamo e sembriamo noi una famiglia normale; le sedie sembrano solo più strette, le posate un po’ piccole e nient’altro. E io sono ancora Caterina, e le cose sono le cose, o lo rimangono appena più che fuori di qui, oppure non ci si pensa, ecco tutto.
Cogli occhi nella tazza sento il rumore del latte che scivola nelle gole, il respiro non è affannato perché è di tutti affannato, e finisse il mondo tra le pareti di questa casa nessuno lo definirebbe affannato, ma normale. Oscar canticchia sigle di cartoni animati e mio padre tace, mamma riepiloga le cose del giorno fissando il vuoto come non fosse veramente vuoto ma pieno di fogli di block notes, io dalla mia posso starmene tranquilla, godermi la discesa bollente del latte come fossi un termosifone, contentarmi di essere semplicemente Caterina.
Mi alzo e bacio babbo immobile sulla sedia, come un punto e virgola; ha come sempre una reazione da punto a capo: preme un bacio maiuscolo su di me, poi raggiunge Oscar e mamma e si china su di loro; dice «Buona giornata a tutti!» e scompare nel suo quotidiano paragrafo di lavoro. Io intanto afferro Oscar per una mano e lo trascino su fino in camera.
Mentre mi vesto si raggomitola nel mio letto e mia madre disotto sparecchia. Oscar si addormenta di nuovo come ogni mattino, oltre la porta Gionata armeggia con dei riflettori molto forti e io incomincio a soffrire piano come se questi pantaloni e questa felpa mi soffocassero, come fossero una camicia di forza. In bagno copro le occhiaie e spazzolo i capelli fissandomi allo specchio fino a non vedere più niente, ritorno in camera, scuoto mio fratello che si sveglia, «i vestiti da mettere sono quelli sulla sedia, non quelli nel tuo cassetto, ricordati», poi lo bacio e sparisco con lo zaino sulle spalle, e sparisco davvero, ogni gradino una lettera del mio nome, ogni passo un colpo di gomma. Sono irriconoscibile quando saluto mamma sulla porta, e non perché ho mezza faccia sotto la sciarpa, semplicemente, come il più triste dei supereroi, la mia identità scompare appena esco di casa, appena supero la cancellata – e non sono più Caterina.
Mi chiamo Caterpillar ora, mi chiamo Cate-ciccia. Anche se non c’è nessuno.
Cammino e ho il mio costume indosso: un panneggiato, indolente, fluttuante manto di grasso. Sono una supereroina e risolvo problemi. Salvo il mondo.
Sono la possibilità ambulante di un paragone che salva; che toglie dalle mani la palma della più brutta, della più grassa, della più sola. Sono Cate-bomba, un residuo bellico inesploso dai tempi delle medie.
Cammino per Urbania, ottomila anime appena, attraverso il piazzale del cinema, la scalinata delle Poste e penso a New York, o Gotham City: una fuga di grattacieli, il buio di un vicolo lunghissimo e sei lontano, di nuovo alla tua identità; una ragnatela, un colpo di mantello e sei sopra gli occhi di tutti, tra le nuvole.
Ti sottrai al vestito e sei di nuovo te, mentre io rimango, perduro, in posa costante per tutte, tutte le fotografie. Io non posso mutarmi d’aspetto, posso solo trovare rifugio, frapporre qualcosa, un muro, una porta, un cancello, un taglio di capelli a forma di sipario, un trucco da imbianchino, una dieta portentosa, una dieta a zona, una dieta di soli frutti, una dieta senza carboidrati.
La mia vita è stata sin qui nient’altro che il tentativo di togliermi questo costume da supereroe.
Sul pullman arrivo tra i primi per non comparire di fronte alla platea, per non percorrere il corridoio tra i sedili, come una ridicola passerella; mi siedo in seconda fila tra i primini, rivolta al finestrino. Non ho compiti da copiare, non ho appunti da ripassare, non ho amiche con cui condividere qualcosa. Mi hanno confinata qui, murata in me stessa. Avranno pensato che grassa come sono potevo ricavare da me un’amica o due con cui chiacchierare, trascorrere il tempo; che fossimo più persone in una.
Il rumore della strada e la controffensiva del sonno, le parentesi quadre dell’iPod rendono quasi piacevole, dimentico il viaggio fino a Urbino. All’apertura delle porte cigolanti del pullman i giorni peggiori immagino guardie giurate e il refrain dead woman walking fuoriuscire dagli altoparlanti.
Scendo invece nel silenzio oggi e mi accompagno ad alcune che sono colleghe, nient’altro. Oggi l’Annoievole Anna è assente, c’è Angela invece, e Giulia. Fino all’uscita dal pullman non vedo nessuno dei miei, perché entrano in fondo, perché siedono in fondo, nel presbiterio, dove non ho mai chiesto spazio.
 «Ciao, Cate», dice Giulia mentre Angela mi fa un segno con la testa mozzata dalle volute di fumo; saliamo insieme perché andiamo nello stesso posto, qualche volta parliamo della prof di lettere “che ci capisce”, dei compiti e dell’esame che si avvicina.
«Ciao, Cate», dice Giulia mentre Angela mi fa un segno con la testa mozzata dalle volute di fumo; saliamo insieme perché andiamo nello stesso posto, qualche volta parliamo della prof di lettere “che ci capisce”, dei compiti e dell’esame che si avvicina.
Spesso taciamo però e per me sarebbe niente male, ma debbono sentirsi in colpa in qualche modo, pensano forse che la vita giusta e desiderabile scorra attraverso le loro vite e non attraverso la mia, così dicono, ad esempio: «Allora, come va?», che invece di stabilire un contatto mi spedisce a migliaia di anni luce, annerendo il vuoto che dovrebbe non esistere tra coetanee e compagne di classe. Io fieramente rispondo un «bene» armato di tutto punto, risentito quasi: non sono malata e non lo sono stata, non vengo da nessuna convalescenza.
Chissà se qualcuno mai avrà ironizzato, le volte che manco, sulla possibilità ridicola di incasellare la mia assenza in uno spazio così piccolo, come bastasse una minuscola a corsiva a cancellare tutta questa ciccia. Se qualcuno, in quei giorni, avrà mai indicato la mia sedia esclamando: «Oggi riprenderai fiato!» o tutta la classe: «Non vi sembra vuota, oggi?». Chissà.
Per evitare che si parli di me non manco mai. Ci sono sempre, per tenermi vicini i nemici, per evitare che la situazione mi sfugga di mano. Per non dover chiamare qualcuno per i compiti. Cosa che non faccio mai, se non in vista di una verifica: senza domandare studio le dieci pagine successive, faccio tutti gli esercizi. Faccio terra bruciata. Ma non manco mai e sono sempre avanti sul programma.
E sì: sono la migliore della classe.
Difficile a credersi. Di solito una palla di lardo è vittima di una catastrofica educazione alimentare, sbagliata in tutti i campi della vita per l’irresponsabilità di genitori amanti prematuri e sposi giovani – partiti male e finiti peggio.
Invece no. Nel mio mare di trigliceridi nuotano un sacco di neuroni, e con molto agio per giunta. Perderei tutte le gare di corsa, ma se si tratta di ragionamenti non sbaglio una partenza e non manco mai il traguardo. Non manco mai nulla. Sono sempre presente, sono la prima della classe.
Saluto nessuno con nessun cenno, mi siedo. Gli altri mi salutano invece perché se non lo facessero sembrerebbero indelicati nei confronti di tanta supereroica diversità. Ed è come non vivere, il senso di estraneità così forte da spingere involontariamente il piede contro il banco occupato da Anna e spostarlo appena più in là, ché non tocchi.
Oggi non c’è bisogno, l’Annoievole è assente. Oggi senza Stati cuscinetto guardo Carlo, oggi guardo Charles a un banco di distanza: attento, penso, il revanscismo è mio, non vostro, sono Guglielmo II e tutto il suo Impero, sono tutti questi chili pronti ad attaccare. Ti cado sopra a peso morto ed è fatta: valgo da sola mezza Europa.
Penso spesso di essere utilizzata come arma di distruzione di massa, o palla da cannone; ma non nel cuore delle lezioni: i miei appunti non si distraggono mai, sono una lama sulla gola della spiegazione, che messa così alle strette confessa avvenimenti, date e concetti essenziali. Infallibilmente.
Il prof Masello, il precario di Genova che si divide anche le ore di filosofia, racconta della prima guerra mondiale quando diventa guerra di trincea con l’offensiva russa e la resistenza sulla Marna. Ha un rubinetto al posto del naso, una piccola proboscide. Dice che la battaglia della Somme causò un numero spaventoso di vittime, che Napoleone quel numero se lo sognava, ma io resto indifferente perché quelle persone non me le figuro – se solo ci leggesse un verso di Ungaretti tutto cambierebbe o forse nemmeno –, come un record del mondo che poi sarebbe stato superato dalle prestazioni del Terzo Reich.
Come tutte le ragazze fuori moda sorveglio l’intervallo dai cardini della porta. Non esco fuori della classe, appena scostata divoro un pacchetto di cracker integrali e poi in un sorso lunghissimo un cartoncino all’albicocca.
Ogni tanto qualcuno entra o guarda con la coda dell’occhio perché si compiano le scritture della Bibbia Marvel sul supereroismo – «E loro verranno e si sentiranno belle di fronte a te». Qui, la Suscettibile e l’Analfabeta attendono che la campanella riporti tutti ai nostri posti, ristabilendo un ordine che torni a coprire l’amara verità: che socialmente, cioè, siamo paria, intoccabili, iloti e altre cose così.
Oggi nemmeno l’Annoievole c’è a portarmi un po’ di conforto, l’Annoievole che come Ermes esce ed entra negli inferi a raccontare quello che succede alla luce dei riflettori – in bagno, sulle scale. In superficie.
Suona la fine della scuola.
Cammino il più possibile tra le altre mentre scendiamo fino a Mercatale, dove ci attende la corriera. Urbino è discese e salite con qualche pianerottolo qua e là, come piazza della Repubblica o il quadrato di pietre all’ingres- so del Palazzo Ducale.
Accendo il radar: individuo tutte le possibilità della lingua, tutte le immagini che potrebbero sorgere nelle menti e nelle bocche di chi mi guarda. Come delle piccole dosi di veleno le assumo, parole come valanga e slavina e palla di neve e strike e bowling, poi guardo scorrere i cortometraggi di me che rotolo giù e colpisco e travolgo e diverto: soprattutto diverto.
Mi anniento, disinnesco tutte le parole sulla mia pel- le, come quando ti fai un livido sul braccio e per evitare che a ogni contatto causi ancora dolore ci premi sopra il pollice finché non senti più niente, finché è soltanto una forma di niente.
Sono a casa, sono quasi le due. Mi trascino per la fame, spossata dal mio supereroismo e avvelenata dai tanti identici vaccini – mamma sulla porta mi raccoglie come ogni giorno: «Ciao, stella!»; e non penso alle supernove, alla stella polare, al fatto che il sole, in una recita sulla via lattea, non potrei interpretarlo; ora basta, ora che sono nuovamente Caterina.