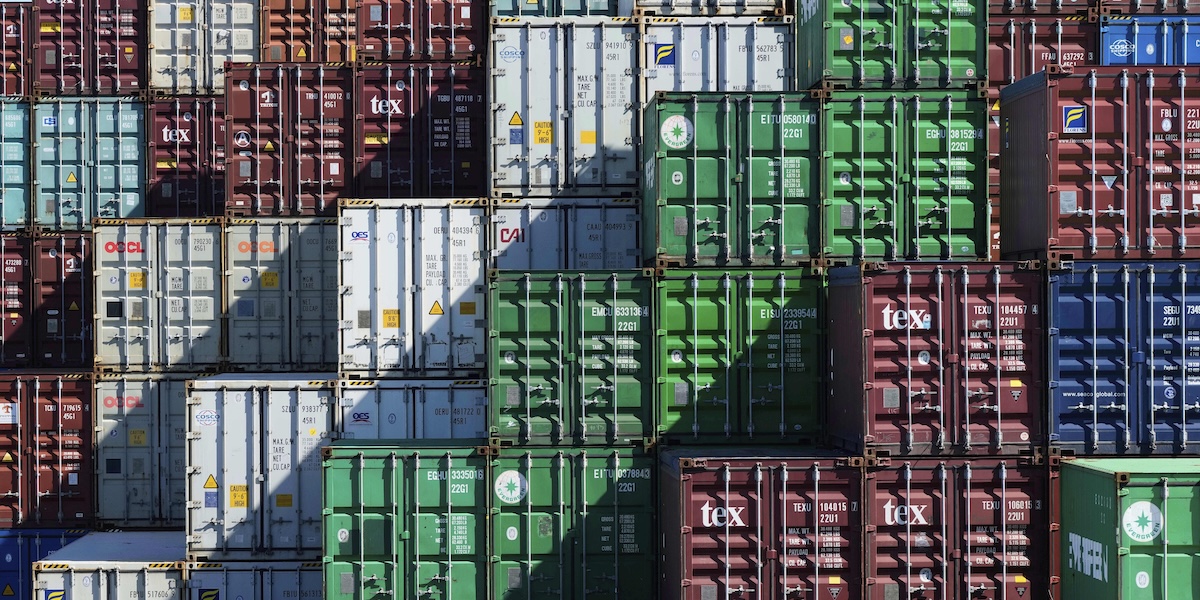Il primo capitolo di “Apnea”
Il libro di Lorenzo Amurri è tra i dodici finalisti del Premio Strega

In occasione della collaborazione con il Premio Strega, Caffeina pubblicherà le prime pagine dei dodici finalisti del premio.
Apnea è il primo romanzo di Lorenzo Amurri, uscito il 24 gennaio per Fandango Libri. Amurri è nato a Roma nel 1971, ed è musicista, produttore musicale e scrittore. Ha suonato e collaborato, tra gli altri, con i Tiromancino, Asia Argento e Franco Califano. Scrive sul blog Tracce di ruote e ha pubblicato uno dei suoi racconti nella raccolta Amore Caro (a cura di Clara Sereni). In Apnea racconta il grave incidente avvenuto mentre sciava sul Terminillo che l’ha reso tetraplegico, e la storia di quel che è avvenuto dopo.
***
È quasi l’ora di pranzo.
Sto sciando insieme alla mia fidanzata, in realtà la precedo perche è troppo lenta. È quasi l’ora di pranzo. Ho la faccia immersa nella neve. Non sento più niente, come fossi dentro un batuffolo d’ovatta. Non riesco a respirare. Qualcuno mi prende la testa tra le mani e la gira: respiro.
Ora sono in un garage, sembra l’officina di un meccanico. Ho la sensazione di avere una persona davanti girata di spalle e una dietro che mi tocca la testa, ma non le distinguo chiaramente.
Ho sete. Qualcuno mi fa bere. Sento il liquido fresco scendere giù fino allo stomaco e oltre; lo sento nella vescica e non posso trattenerlo dentro; lo sento fluire in mezzo alle gambe: è bellissimo, paragonabile a un orgasmo.
Il garage è l’elicottero che mi sta trasportando d’urgenza in ospedale. Sono sveglio ma la mia coscienza vaga scioccata, costruendo una difesa visionaria che confonde quello che in realtà sta succedendo. Mi diranno in seguito che in molti, trasportati in elicottero dopo gravi incidenti, raccontano di essere stati in un garage; mi diranno anche che all’arrivo al pronto soccorso ho detto che qualcuno mi aveva dato da bere, scatenando un attimo di panico generale. Se qualcuno l’avesse veramente fatto, non sarei qui a scrivere.
Mi sorprende vedere che sul lungomare di Ostia hanno costruito un ospedale americano. Anche le ambulanze sono americane: grosse, quasi quadrate e piene di luci e lucette intermittenti. Sono sdraiato sul cofano di una macchina proprio davanti all’ingresso, intorno a me infuria una battaglia. Truppe di marines statunitensi affrontano guerriglieri di un’etnia africana non meglio definita: fumo, proiettili, esplosioni. Non riesco ad alzarmi.
Non credo di essere ferito, ma ho grosse difficoltà a muovermi, posso solo essere uno spettatore passivo di ciò che accade. Gli africani stanno tentando un colpo di stato, di quale stato non saprei, e si fanno esplodere. Ma non come i terroristi islamici carichi di tritolo, questi diventano incandescenti come la lava e saltano in aria. Sembra una reazione chimica, una specie di autocombustione esplosiva. Sopra l’ingresso del pronto soccorso c’è una grata rettangolare color oro. Nascosto dietro, un guerrigliero sta gradualmente cambiando colore: dal nero all’arancione, fino al rosso fuoco. Mi agito e cerco di avvertire i marines, ma non riesco a gridare, dalla mia bocca non esce alcun suono.
Mi giro di lato e vedo un grande pullman di quelli da gita turistica. È fermo davanti a me e si divide a metà: grazie a qualche congegno, la coda si separa dalla testa rimanendo comunque attaccata. La carrozzeria si divide mentre la scocca si allunga. Di lato fuoriesce una pedana quadrata bucata nel mezzo, con un guerrigliero appeso e incandescente. Sotto la pedana, dove un minuto prima c’era asfalto, si apre una profondissima voragine.
La scena ricorda vagamente una nave pirata col suo trampolino sul mare infestato dagli squali. Infatti, l’uomo nero viene fatto precipitare nella buca prima di esplodere.
Di colpo mi ritrovo all’interno del pullman. Sono seduto davanti con lo schienale del sedile completamente reclinato.
In piedi accanto a me, un uomo con i capelli bianchi mi parla:
“Tu sei figlio di Antonio e Milvia?”.
“Sì.”
“Allora devi stare tranquillo che non ti succederà niente.”
La voce dell’uomo è ferma e rassicurante, ma io ho paura: è lui il capo dei guerriglieri.
L’operazione alla colonna dura nove ore, la lesione è molto grave. Per non parlare della frattura al polso, della lussazione alla spalla, del naso rotto e dei tagli in testa. Sostituiscono una vertebra disintegrata con un pezzo di cresta iliaca, l’osso del fianco; in realtà ci vorrebbero le placche di titanio, ma non sono disponibili e non posso aspettare che arrivino. L’unica controindicazione e che devo stare immobile, il collo deve rimanere dritto per tre mesi. Devono montarmi addosso un halo-vest: una corona avvitata a quattro assi di ferro, a loro volta avvitate al cranio. Il tutto assicurato a un busto di plastica dura che copre spalle e petto, arrivando alla bocca dello stomaco. Anche per l’halo bisogna aspettare qualche giorno, ma io il collo lo muovo. E l’unica parte del corpo che riesco a comandare in questo momento, e mordo i tubi che immettono aria nei miei polmoni. Decidono di farmi una tracheotomia. Decidono anche di farmi cadere in un coma pilotato, un coma farmacologico.
È buio e c’è silenzio, ma non sono solo. Quattro fari bianchi si accendono all’unisono e formano un cerchio. Uno è in verticale sopra la mia testa, gli altri illuminano rispettivamente: John Paul Jones con il suo basso; Jimmy Page con la sua chitarra e una batteria con una figura che non riesco a mettere a fuoco. Percepisco la presenza di altre persone, ma non le vedo. È come se fossimo su un palco circolare con le gradinate intorno piene di ombre silenziose. All’improvviso mi ritrovo una chitarra in braccio e iniziamo a suonare. Sto suonando con due leggende del rock, ma non sono emozionato; mi diverto come un pazzo, sono felice. Le mie mani si muovono agilmente sulla tastiera e le note di canzoni che non ho mai studiato volano e disegnano il cielo, come uno stormo di uccelli prima di migrare. Non so quanto sia durata la jam session – anche perché il tempo in questo momento non è un fattore rilevante; e una jam così, se durasse in eterno, sarebbe sempre troppo breve – e non ricordo con esattezza cosa abbiamo suonato. Sono seduto sul sedile della batteria con le bacchette in mano. Intorno non vedo più nessuno, neanche i musicisti: io non la so suonare la batteria. Un bagliore accecante mi investe. Sono nell’aeroporto di Londra, devo tornare a casa, a Roma. Sono sull’aereo e mi guardo da fuori; vedo me stesso parlare con la hostess, ma sono seduto a qualche fila di distanza. Sono a Fiumicino, sto uscendo dall’aeroporto. Piove a dirotto e nessuno è venuto a prendermi. Non ho soldi e non so come tornare a casa. Vedo un pullman blu dell’esercito italiano, sembra vuoto.
Salgo su e sul sedile del guidatore trovo un cappello da carabiniere: me lo sistemo in testa come travestimento e cerco di accendere il mezzo, sicuro di non essere notato. Il pullman è pieno di carabinieri, i vetri appannati dall’umidità mi avevano tratto in inganno. Ne arrivano subito due che mi bloccano e mi ammanettano. Inizio una trattativa per il mio immediato rilascio:
“Quanto volete per lasciarmi andare? Vi firmo subito due
assegni?”.
Alla fine ci accordiamo per un milione a testa. Senza far capire agli altri colleghi la situazione, mi tolgono le manette e mi lasciano libero sotto la pioggia.
L’halo-vest e arrivato e me l’hanno già montato addosso, e venuto il momento di farmi riemergere dal coma. Apro gli occhi e la prima cosa che noto è una grata sul muro davanti a me, identica a quella dove si nascondeva il guerrigliero africano. La fisso con sospetto cercando di intravedere se dietro c’è ancora il tipo inesploso.
“Bentornato”, un uomo con camice e capelli bianchi sta in piedi accanto al mio letto, “sono il dottor Mammini.” Lo guardo in faccia, è il capo dei guerriglieri.
Ma che ci fa qui? E soprattutto, dov’è “qui”?
In realtà so dove mi trovo, ma la coscienza evita di rendersene pienamente conto.
Sopra la mia testa una struttura quadrata penzola attaccata a una catena, ricorda quella che fuoriusciva dal pullman durante il colpo di stato. Arrivano due infermieri:
“Ciao, di nuovo tra noi eh?”. Anche loro mi ricordano qualcuno. Forse sono attori, magari li ho visti in qualche film. Sono cosi familiari e allo stesso tempo totalmente sconosciuti.
Non parlo. Ancora non lo so, ma anche se ci provassi non uscirebbe alcun suono, per via della tracheotomia e del respiratore a cui e collegata. Uno dei due infermieri si avvicina: “Preparati, stanno arrivando i tuoi”.
In un attimo le vetrate che costeggiano la rianimazione si riempiono di persone. Non li vedo bene, sono ombre ma ci sono. L’altro infermiere mi porta un citofono e me lo lega all’halo all’altezza dell’orecchio. Ha il viso contratto in una smorfia, ma sembra gentile. Controlla l’attacco del respiratore alla tracheotomia e per un attimo mi manca l’aria.
“Pronto Lo, mi senti?”, una voce esce dal citofono e invade il mio orecchio, è molto familiare, è mia sorella:
“Mi senti Lorenzo?”.
Sì, ti sento Valentina. Ma dove sono? Chi sono tutte queste persone che mi sembra di conoscere? Cosa sta succedendo? Sarebbero tante le cose da chiedere, ma dal mio labiale esce quello che non ti aspetti: “Devi andare in banca a bloccare due assegni che ho fatto a due carabinieri che mi volevano arrestare”.
Silenzio.
Immagino mia sorella, poverina, alle prese con l’interpretazione del mio ordine. Intelligentemente indaga con l’unica arma a sua disposizione:
“Stai tranquillo, il mutuo di casa tua l’ho pagato io”.
“Non hai capito, blocca gli assegni che non li voglio pagare!”, le rispondo alterato.
Ancora silenzio. A questo punto la paura generale, sospesa nell’aria stantia del corridoio visite della rianimazione, si sta concretizzando: ci sono danni cerebrali. Paura spazzata via pochi istanti dopo, dalla prima domanda della mia nuova coscienza: “Non posso più camminare vero?”.