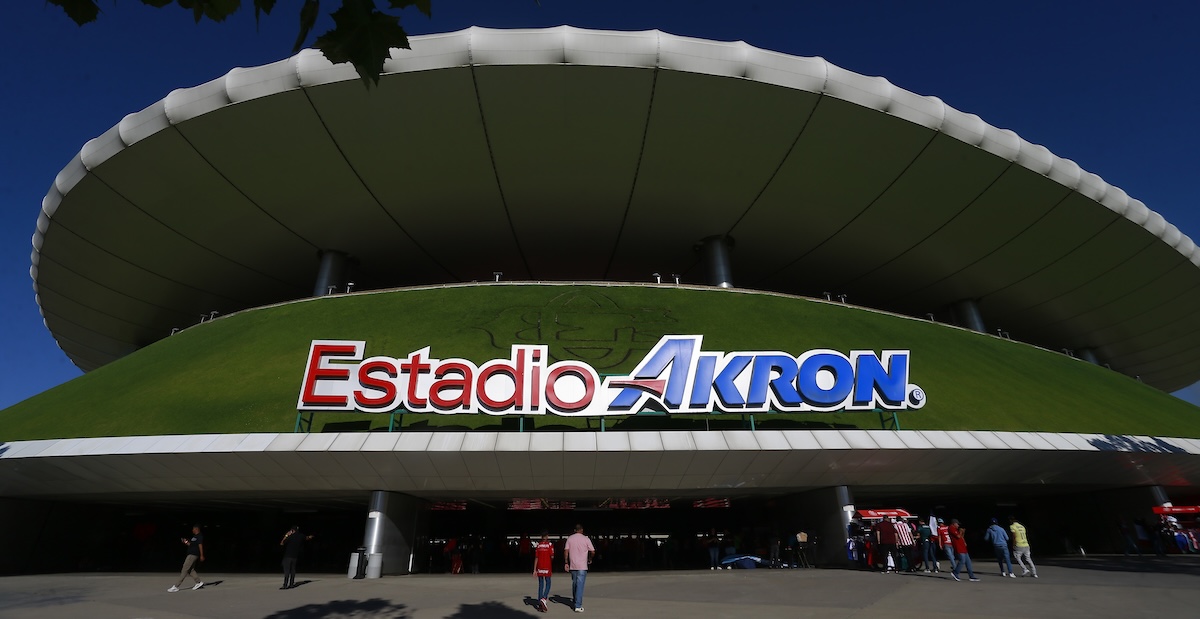La Siria e la linea rossa
Perché gli Stati Uniti e la comunità internazionale non intervengono? Cosa potrebbero fare? Le armi chimiche sono il punto di non ritorno?

altre
foto
Le prime proteste contro il regime alawita di Bashar al Assad iniziarono in Siria il 15 marzo 2011. Quella siriana sembrava essere solo un’altra delle cosiddette “primavere arabe” che stavano costringendo diversi dittatori della regione a lasciare la guida dei loro paesi dopo decenni di potere: col passare dei mesi, tuttavia, gli scontri tra forze governative e ribelli si sono trasformati in una delle guerre civili più violente e brutali degli ultimi decenni. Con l’aumento della violenza sono aumentati anche i gruppi coinvolti nel conflitto – islamisti, estremisti islamici, rappresentanti delle diverse etnie del paese – molti dei quali mandati a combattere in Siria per sostenere gli interessi di uno o dell’altro Stato della regione.
Di fronte alle oltre 80 mila persone uccise nella guerra, stando ai dati dell’ONU, in molti hanno cominciato a chiedere alla comunità internazionale e soprattutto agli Stati Uniti di fare qualcosa per fermare le violenze, soprattutto dopo che varie fonti autorevoli hanno parlato di uso di armi chimiche nel conflitto: questo è un punto molto importante, perché Barack Obama in passato aveva dichiarato che l’uso di armi chimiche rappresentava la “linea rossa”, superata la quale gli Stati Uniti sarebbero intervenuti in Siria con la forza.
Il giornalista Dexter Filkins si è occupato sul New Yorker di raccontare cosa sta succedendo in Siria, di capire quale sia oggi la posizione dell’amministrazione Obama su un possibile intervento e quali siano le opzioni percorribili dagli Stati Uniti nella guerra siriana: sono sostanzialmente tre, e tutte molto insidiose. Prima di esaminarle, però, bisogna sapere alcune cose fondamentali per capire le difficoltà della situazione.
Chi combatte in Siria, esattamente?
Il paradosso di questi mesi di guerra in Siria è che gli Stati Uniti e gli altri stati schierati a favore dei ribelli siriani, sia occidentali che mediorientali, da ormai un anno si sono ritrovati a stare dalla stessa parte degli estremisti di al Qaida, che hanno rinforzato i ribelli. Inoltre da una parte diversi stati mediorientali, come la Turchia, l’Arabia Saudita e il Qatar, stanno armando e finanziando alcune fazioni dei ribelli, contro la volontà degli Stati Uniti. Dall’altra parte gruppi di combattenti legati all’Iran, il più grande alleato mediorientale di Assad, si sono schierati a fianco delle milizie del regime (armate tra l’altro anche dalla Russia).
La prima difficoltà, insomma, è capire quanti gruppi stiano combattendo in Siria: secondo un articolo del marzo scorso pubblicato sul sito del National, quotidiano degli Emirati Arabi Uniti, l’opposizione ad Assad è composta da circa 1000 gruppi diversi. Ogni fotografia spiega le caratteristiche di quelli considerati i gruppi principali.
La guerra in Siria ha raggiunto un livello di violenza allarmante. In rete da mesi girano video e fotografie che mostrano crimini di guerra compiuti da entrambe le parti: la diffusione crescente di questi filmati ha fatto parlare della guerra civile siriana come della prima guerra della storia su YouTube. Nonostante questo il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, unico organo in grado di autorizzare un intervento internazionale, non è ancora riuscito a trovare un accordo, a causa dell’opposizione di Russia e Cina ad un possibile intervento. Da diverso tempo l’amministrazione statunitense studia delle possibili opzioni di intervento unilaterale, ma finora il presidente Obama si è mostrato riluttante a impegnare militarmente l’esercito in Siria. E qui bisogna fare un altro doloroso passo indietro.
La lezione della Bosnia
Nel maggio del 1993, quattro mesi dopo l’insediamento di Bill Clinton alla Casa Bianca, l’amministrazione degli Stati Uniti aspirava a ridurre il suo impegno militare nel mondo. Un alto funzionario del Dipartimento di Stato disse che gli Stati Uniti non avevano «i soldi per ottenere dei risultati positivi in breve tempo». L’economia degli Stati Uniti era in pessime condizioni ed erano passati solo 18 mesi da quando i soldati americani erano tornati dalla Guerra del Golfo contro l’Iraq, e questo influì molto su come gli Stati Uniti affrontarono quello che stava accadendo nei Balcani.
Quando iniziò la guerra nell’allora Jugoslavia, il governo di Washington decise di non intervenire. Anche quando l’ex presidente serbo Slobodan Milosevic ordinò alle sue milizie di fare “pulizia etnica” in Bosnia Erzegovina, Clinton non cambiò idea. Fu solo dopo il massacro di Sebrenica del luglio 1995, che uccise più di 7mila civili bosniaci in un territorio formalmente sotto il controllo internazionale delle Nazioni Unite, che iniziarono i bombardamenti della NATO contro le forze serbe in Bosnia.
Quell’intervento, scrive Dexter Filkins sul New Yorker, sembra avere dato due lezioni agli americani. La prima era che gli Stati Uniti – che erano indispensabili per la comunità internazionale, almeno quando bisognava fermare un disastro umanitario delle dimensioni di quello che stava accadendo in Bosnia – non volevano più fare tutto da soli, come era successo durante la Guerra Fredda.
La seconda lezione, molto importante alla luce della situazione in Siria, la spiega bene Gary Bass, professore di Princeton che ha scritto molto sugli interventi umanitari: ogni volta che un presidente manda dei soldati all’estero per salvare delle vite rischia un disastro politico; quando ne sta fuori, anche di fronte a calamità enormi, ha poco da perdere. La reputazione di Clinton, per esempio, venne duramente colpita quando un elicottero americano fu abbattuto in Somalia durante una delle battaglie di Mogadiscio dell’ottobre 1993: l’operazione di salvataggio che ne seguì, che ispirò anche il popolare film di Ridley Scott Black Hawk Down, causò la morte di 18 soldati americani. Al contrario, la reputazione di Clinton non si deteriorò troppo (almeno negli Stati Uniti) in occasione del genocidio in Ruanda del 1994, quando l’amministrazione decise di non intervenire in un massacro che causò la morte di centinaia di migliaia di persone.
Cosa ha fatto Obama in Siria
La posizione di Obama sulla guerra in Siria sembra essere stata parzialmente condizionata anche dalle cose imparate dagli Stati Uniti durante l’intervento in Bosnia di vent’anni fa, senza contare ovviamente i recenti complicatissimi interventi militari in Afghanistan e in Iraq. Gli Stati Uniti si sono limitati a fornire ai ribelli siriani circa 650 milioni di dollari in aiuti non militari, e secondo alcune fonti mai ufficialmente confermate la CIA avrebbe iniziato ad addestrare piccoli gruppi di siriani che a loro volta dovrebbero addestrare altri ribelli. Per mesi Obama ha sperato che questa strategia potesse essere sufficiente a costringere Assad a negoziare una resa.
Obama ha ripetuto più volte in pubblico che un intervento militare degli Stati Uniti in Siria sarebbe uno sbaglio. Durante una conferenza stampa nel 2012, Obama disse: «L’idea che il modo per risolvere tutti questi problemi sia dispiegare i nostri soldati non è stata vera in passato e non può essere vera ora». Durante un’intervista data quest’anno a New Republic, Obama ha detto che intervenire in Siria potrebbe obbligare in futuro gli Stati Uniti a intervenire dovunque ci sia una catastrofe umanitaria.
Il New Yorker racconta un’altra cosa notevole, e poco conosciuta, su come Obama si sia trovato isolato all’interno del suo stesso staff sulla questione dell’intervento in Siria. A febbraio l’ex Segretario della Difesa, Leon Penetta, e il capo di stato maggiore, Martin Dempsey, testimoniarono di fronte alla Commissione sui Servizi Armati del Senato. In quell’occasione il senatore repubblicano John McCain chiese: «Vorrei chiedere di nuovo a entrambi quello che avevo già chiesto lo scorso marzo, quando 750 cittadini siriani erano stati uccisi. Ora siamo a più di 60mila. Quanti ancora devono morire prima che voi ordiniate un’azione militare?». Sia Panetta che Dempsey risposero che lo avevano già fatto, riferendosi a una proposta di inviare armi ai ribelli, che era sostenuta anche dall’ex Segretario di Stato Hillary Clinton, dal direttore dell’intelligence, James Clapper, e dall’ex capo della CIA, David Petraeus. La proposta era stata presentata a Obama, che però l’aveva rifiutata. McCain commentò la risposta di Panetta e Dempsey dicendo: «Può essere che sia successo un’altra volta nella storia che l’intero team della sicurezza nazionale raccomandasse al presidente di intraprendere un’azione e che lui abbia rigettato la proposta, ma se è successo io non ne sono a conoscenza».
Le opzioni di Obama, a parte non fare niente
Secondo Filkins sono tre: imporre una no-fly zone, simile a quella che fu imposta in Libia nel 2011 e che portò alla caduta di Mu’ammar Gheddafi; armare i ribelli utilizzando come punto di smistamento un comando che ha la sua base in Turchia; distruggere in qualche modo l’arsenale chimico di Assad, distribuito in decine di siti diversi sparsi per il paese.
1. La no-fly zone
Creare una no-fly zone vuol dire stabilire che una certa porzione di territorio non può essere sorvolata, e che gli aerei che lo fanno possono essere abbattuti. La no-fly zone è stata richiesta molto dai ribelli siriani, che credono che impedendo i bombardamenti aerei dell’aviazione siriana il regime di Assad cadrebbe dopo un solo mese. Lo scorso marzo Moaz al-Khatib, allora presidente della Coalizione Nazionale Siriana, l’autorità che rappresenta i ribelli, chiese a Obama di usare i missili Patriot per imporre una no-fly zone sulle aree controllate dai ribelli nelle zone al nord della Siria. L’obiettivo non doveva essere solo colpire l’aviazione del regime siriano, ma anche rimuovere gli Scud che Assad sta usando contro i civili – un arsenale che si stima comprenda parecchie centinaia di missili. La no-fly zone permetterebbe anche ai membri dell’opposizione siriana, che oggi si trovano al Cairo, di poter tornare in Siria senza essere colpiti dai bombardamenti del regime.
Le cose non sarebbero però così semplici. Le difese aeree siriane, che sono state pensate per proteggersi da un attacco israeliano, sono tra le più fitte del mondo, con moltissimi radar e missili terra-aria. Una no-fly zone comporterebbe rischi molto alti in termini di perdita di vite umane, oltre al fatto che potrebbe non essere sufficiente a fermare i massacri: una parte consistente dei bombardamenti di Assad, infatti, avviene via terra.
2. Armare i ribelli
Gran parte delle armi dei ribelli arrivano dal Qatar, dalla Turchia e dall’Arabia Saudita: si tratta di missili, fucili e milioni di munizioni, spesso comprate in Croazia e trasportate fino alle basi dei ribelli ai confini con la Turchia e la Giordania. Finora Obama non ha autorizzato nessun trasferimento di armi ai ribelli, come confermato ad aprile dal nuovo Segretario di Stato John Kerry: il motivo è la poca fiducia nei confronti dei ribelli siriani, che secondo il presidente sarebbero divisi ideologicamente e impossibili da controllare.
Sembra però che le armi di Qatar, Turchia e Arabia Saudita siano comunque finite nelle mani dei ribelli più estremisti: ad aprile il gruppo Al Nusra, legato ad al Qaida, ha pubblicato online un video di propaganda che mostra alcuni suoi membri che imbracciano delle armi fabbricate in Croazia, identiche a quelle che erano state inviate ai ribelli una settimana prima dai tre stati mediorientali. Elizabeth O’Bagy, analista dell'”Institute for the Study of War” e che ha viaggiato diverse volte nelle zone controllate dai ribelli, ha detto: «Noi possiamo indirizzare le armi con un certo grado di sicurezza, ma una volta che sono in Siria perdiamo essenzialmente il controllo di come vengono usate». Gli Stati Uniti non vogliono correre il rischio di ritrovarsi dopo la caduta del regime con un esercito di estremisti islamici armati fino ai denti proprio dagli Stati Uniti, un po’ come accadde in Afghanistan durante la Guerra Fredda.
Recentemente gli Stati Uniti hanno subito molto le pressioni dell’Arabia Saudita, che vorrebbe iniziare ad armare i ribelli con missili terra-aria. I missili terra-aria sono considerati potenzialmente decisivi per la guerra, non solo per colpire Assad ma anche per indebolire i sostenitori del regime iraniano, con i quali i sauditi hanno iniziato un intenso conflitto per dominare l’area mediorientale del Golfo. Gli Stati Uniti finora si sono messi in mezzo per i motivi di cui sopra, ma non è detto che i sauditi aspetteranno un sì degli americani per sempre.
3. Distruggere l’arsenale chimico di Assad
La questione delle armi chimiche è la più delicata per l’amministrazione Obama. Gli Stati Uniti non hanno mai specificato con esattezza in cosa consista questa “linea rossa”, a parte richiamare un uso “sistematico” di questo tipo di armi: sistematico significa ripetuto, e non solo episodico su piccola scala. Joseph Holliday, ex ufficiale dell’intelligence militare che ha studiato il conflitto siriano per l'”Institute for the Study of War” a Washington, sostiene che il regime di Assad stia usando le armi chimiche in modo da terrorizzare i ribelli, ma non da superare la “linea rossa”. Un aumento graduale e non casuale della violenza. «Prima c’è stata l’artiglieria. Poi le bombe. Poi gli Scuds. Un anno fa [Assad] non uccideva 100 persone ogni giorno. Ha introdotto le armi chimiche gradualmente, per farci abituare al loro uso».
Gary Samore, che fino a febbraio era il consigliere capo sulle armi di distruzione di massa per il presidente Obama, ha detto che il programma di Assad sulle armi chimiche è difficile da eliminare con la forza militare. Bombardare i siti in cui si trovano le armi potrebbe creare molti danni ai civili a causa del rilascio nell’aria di sostanze chimiche nocive. Oltretutto, aggiunge Samore, non è garantito che un bombardamento aereo su questi siti sia sufficiente per distruggerli tutti.
Un’altra opzione potrebbe essere conquistare i siti senza bombardarli, ma anche questa sembra molto difficile: i soldati americani dovrebbero intervenire via terra e potrebbero dover combattere non solo contro i soldati di Assad ma anche contro i gruppi ribelli, come Al Nusra, che potrebbero volersi impossessarsi delle armi chimiche. Il Dipartimento della Difesa americano ha stimato che mettere in sicurezza le armi chimiche siriane richiederebbe circa 75mila truppe di terra, più di quelle che gli Stati Uniti hanno mantenuto in Afghanistan da quando Obama si è insediato alla presidenza.
La guerra in Siria vista dall’America
Il senatore John McCain, uno dei sostenitori più convinti di un maggiore coinvolgimento in Siria, ha detto la scorsa settimana che gli Stati Uniti dovrebbero essere “preparati con una forza internazionale per andare in Siria e mettere in sicurezza le armi chimiche, e magari anche quelle biologiche”. McCain è radicalmente contrario, però, a inviare delle truppe di terra, e sembra immaginare un intervento come quello in Bosnia, o uno simile a quello libico – breve, e con poche perdite per gli americani.
Per Obama la situazione siriana è più complessa, come spiega un membro dello staff della Casa Bianca al New Yorker: «La pressione che c’è ora su di noi per intervenire in Siria è enorme. Ma il giorno dopo che fai qualcosa le pressioni vanno in un’altra direzione. In Libia prima che intervenissimo tutti dicevano: “Ma perché non fate niente?!”. Il giorno dopo che siamo intervenuti, tutti sono passati a: “Ma che diavolo avete fatto?!”». Obama vuole liberarsi di Assad e interrompere i massacri, scrive il New Yorker, ma teme di impelagarsi in un vuoto di potere come quello che si aprì a Baghdad dopo l’intervento americano del 2003: quel vuoto venne riempito dal caos e dagli estremisti islamici. Difficile pensare che quelli che governeranno dopo Assad, se succederà, saranno amici degli Stati Uniti.