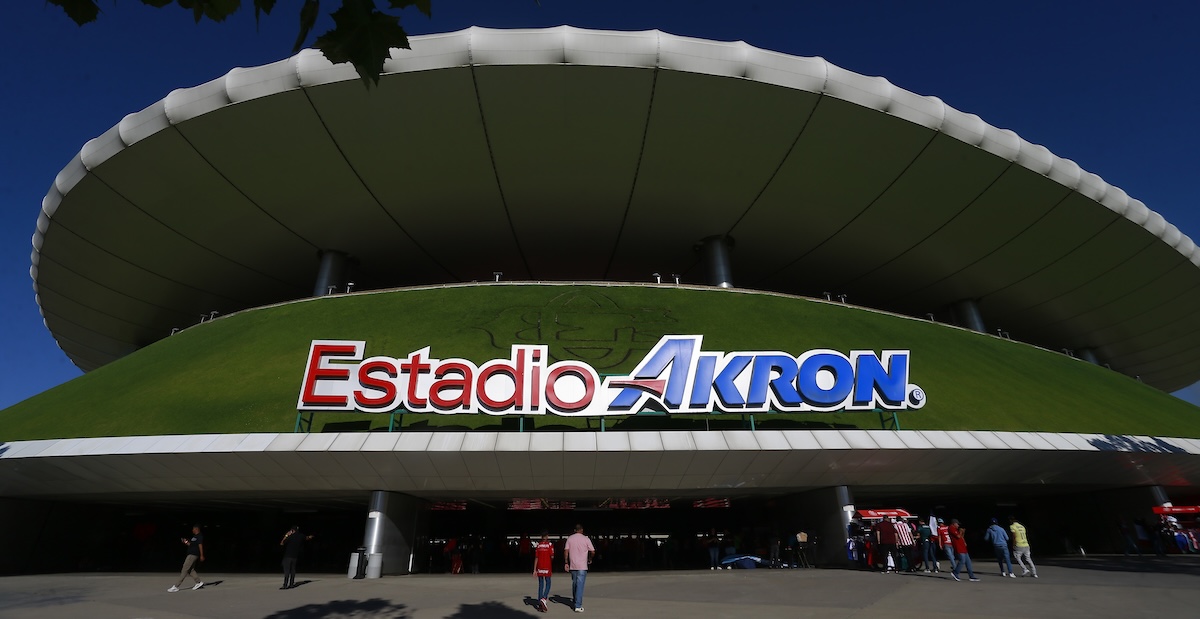I rohingya e la nuova Birmania
Cosa c'è intorno agli scontri tra buddisti e musulmani nel paese in cui molte cose stanno cambiando
di Alex Franquelli – @alexfranquelli

«Qualsiasi cosa facciate, fatela da nazionalisti. Quando mangiate, mangiate da nazionalisti. Quando viaggiate, fatelo da nazionalisti e, cosa ancora più importante, quando comprate, comprate da veri birmani». Le parole del piccolo monaco buddista Wirathu hanno cessato d’essere solo minacce quando, il 20 marzo scorso, una rivolta le ha trasformate in violenza. Siamo a Meikthila, in Birmania.
A far scoppiare la rivolta sarebbe stato un episodio ancora poco chiaro: un orefice di religione islamica avrebbe rifiutato di acquistare dell’oro falso da una coppia di locali. Nelle violenze, che hanno radici lontane nel tempo e nello spazio, sono morte almeno 20 persone, e sette case e due moschee sono state distrutte.
Sayadaw (“maestro venerabile”) Wirathu è un monaco buddista con una lunga scia di episodi d’intolleranza alle spalle. Il suo nome è da dieci anni dietro le maggiori manifestazioni d’islamofobia nel paese. Tutte culminano, quasi irrimediabilmente, in sanguinosi attacchi come quello a Mandalay nel 2003 o a Meikthila, appunto, pochi giorni fa. Alla base di questi episodi, in un paese che solo ora inizia ad aprirsi a dinamiche simil-democratiche, c’è la questione del Rakhine, una regione costiera popolata da quasi 800.000 musulmani.
«Controllano l’economia e mirano a cancellare il buddismo e la cultura birmana in pochi anni», dice il monaco nella tradizionale veste arancione. E lo dice guardando alle imprese di costruzione finanziate da fondi arabi che sorgono oramai un po’ dappertutto nella vecchia capitale Rangoon, ma anche e soprattutto a ovest, dove nel Rakhine vive quella che è conosciuta come “la minoranza più oppressa del mondo”, i rohingya.
Di origine indoariana, i rohingya sono una popolazione poverissima proveniente dal vicino Bangladesh, del quale conservano in parte i costumi, ma anche e soprattutto il credo religioso islamico. La giunta militare al potere da mezzo secolo in Birmania ha cercato di sradicare questo popolo dalla sua terra, riuscendo a decimarlo senza tuttavia eliminarlo del tutto.
Il nazionalismo di Wirathu è la continuazione di quello furbamente offuscato della vecchia leadership birmana, che oggi è comodamente asserragliata nella capitale Naypyidaw (“residenza dei Re”, come si traduce, senza ironia alcuna, il nome della nuova, nuovissima metropoli). Privati di qualsiasi diritto, i rohingya a oggi non sono considerati cittadini birmani ma è intorno a loro che si giocano, volenti o meno, le elezioni del 2015 e con esse il destino della nuova Birmania.
La National League for Democracy (NLD) – il partito della Lady, come viene affettuosamente e rispettosamente chiamata l’attivista Aung San Suu Kyi – non si schiera per non inimicarsi l’élite religiosa del paese, e rischiare così di perdere le prossime elezioni. Ma è proprio la leadership buddista, nelle sue frange più estremiste, ad accusare lei e la NLD di avere stretto rapporti con la minoranza rohingya. Il regime, nel frattempo, non interviene, e se da un lato ha tutto l’interesse perché si mantenga questa fase di stallo, dall’altro non fa nulla per evitare che la situazione degeneri.
Il porto di Sittwe, che si trova nel Rakhine settentrionale, attrae da anni investitori: per lo più indiani, che stanno contribuendo alla costruzione di strutture di ricezione merci adeguate per poter espandere il proprio commercio nel sudest asiatico. Ma le complicazioni cominciano ora, con la recente proposta del governo di Pechino di costruire un oleodotto che porti nel meridione della Cina il petrolio del Medio Oriente attraverso il porto di Sittwe. Lo Stretto di Malacca è considerato ad alto rischio per via della presenza di pirati nell’area, e un oleodotto che tagliasse in due il fragile equilibrio – sia geografico che politico – birmano dimezzerebbe i tempi e dunque i costi di trasporto del petrolio.
Da parte sua, però, la Cina ha bisogno di garanzie di stabilità sul piano politico e sociale. Diversi osservatori hanno avanzato qualche sospetto sul suo ruolo nel recente inasprimento dei rapporti non solo con la minoranza rohingya a occidente, ma anche con quelle della regione del Kokang, a oriente, proprio al confine cinese.
Non esistono molte speranze che i problemi si possano risolvere, in modo o nell’altro, prima delle elezioni parlamentari del 2015, il cui esito, e con esso quello delle varie minoranze, è ancora molto incerto. A Moulmein, intanto, è in corso la cosiddetta “guerra dei bus”. La popolazione è stata esortata a non usare quelli della società Yarzarmin in quanto “foraggiata da soldi sauditi” e dunque “musulmana”, col risultato che il prezzo del biglietto Yarzarmin è più basso di quello dei concorrenti considerati “buddisti e birmani” di circa 2.500 kyat (2,20 euro). Gli autobus della Yarzarmin sono diventati quindi troppo convenienti per potervi rinunciare. «Noi buddisti dovremmo considerare 2.500 kyat una giusta donazione o un piccolo sacrificio per la sopravvivenza della nostra razza, della nostra religione e della nazione», tuonava pochi giorni fa Sayadaw Wirathu.
Il monaco buddista Wirathu parla con i giornalisti il 30 marzo 2013.
Foto: Soe Than WIN/AFP/Getty Images