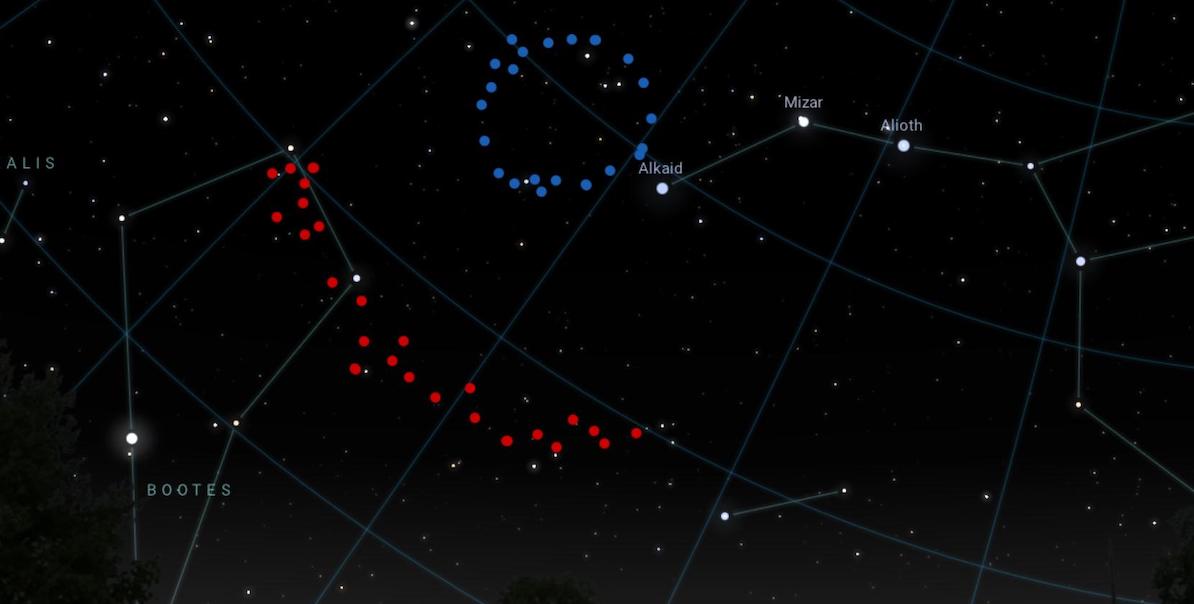Sulle fotografie dei morti
Dal ricco libro di Grazia Neri, fondatrice di una delle più celebri agenzie fotografiche del mondo, le riflessioni su quali immagini pubblicare e quali no
di Grazia Neri

Mentre scrivo queste parole (è il 6 maggio 2011) ho sul tavolo una serie di articoli nazionali e internazionali, tratti da quotidiani cartacei e online, sull’opportunità di mostrare la foto di Bin Laden morto. Quando, il 2 maggio mattina, ho visto le prime immagini del compound di Osama (si dice che il presidente degli Usa le abbia ricevute attraverso il nuovissimo sistema video body-on, del quale sembra che siano dotati i corpi speciali: tutte le immagini in tempo reale), mi sono subito chiesta se ce ne fossero altre, perché la notizia del cadavere gettato in mare e le fotografie della squallida abitazione, del sangue sui pavimenti e dell’elicottero schiantato fuori dalla costruzione sembravano non essere esaustive.
Nei giorni a seguire la Casa Bianca ha annunciato che non avrebbe distribuito le immagini del cadavere per tante ragioni che ritengo valide, tra cui il rischio di offrire spunti per creare l’iconografia di un eroe. Accanto alle poche fotografie rilasciate, la stampa internazionale ha ripubblicato quelle dell’11 settembre 2001 e alcune immagini della folla che esulta davanti alla Casa Bianca. Tutti documenti storici, che riassumono visivamente una lunga tragedia.
Mi pare che in questo caso le fotografie rilasciate dalla Casa Bianca siano sufficienti: è facile per ognuno di noi immaginare il resto. Capisco però che, di fronte al desiderio di governi, stampa e opinione pubblica di avere la certificazione dell’evento, il cadavere rappresenterebbe la “chiusura” della storia. In questa direzione si muove per esempio beppe Severgnini sul Corriere della Sera del 6 maggio 2011: «Stavolta ci sarebbe un motivo – forse più di uno – per mostrare la pessima fine di uno stragista seriale. Di quattro parole ha bisogno il mondo malato di cinismo: senza-ombra-di-dubbio. Perché è nell’ombra dell’incertezza che le fantasie crescono e i complottisti si moltiplicano».
Di diverso parere Harold Evans sul sito Dailybeast. La pensa come me: non serve questo cadavere. In queste situazioni, per riassumere il suo testo, il fotografo o chi per lui deve chiedersi prima di tutto se la foto agghiacciante e violenta aggiunga qualcosa alla storia, poi se possa farci cambiare idea sugli eventi, se la persona fotografata acconsentirebbe (e qui non è il caso), se la foto possa far parte della memoria dell’umanità. Tra i commenti all’articolo pubblicato me ne piace uno breve che dice: «Non vorrei vederlo più, ne vivo né morto».
Le persone vogliono storie con un finale preciso. Film e libri senza un finale lasciano delusi. Ma se la certificazione della fotografia aiuta la storia, di sicuro non la fa.
Sfoglio ancora i giornali. Vedo il lavoro compilatorio dei quotidiani che pubblicano tutti i cadaveri celebri del passato, di rivoluzionari o di dittatori, da Che Guevara a Saddam Hussein. Torno alla mia esperienza. Premetto che sono profondamente pacifista e che non è stato facile dover veder scorrere davanti agli occhi migliaia di fotografie di guerra e di sofferenza planetaria. Da giovane mi aveva impressionato la fotografia della salma imbalsamata di Lenin.
Soprattutto per una stana luce arancione che l’accompagnava costantemente e per le mani, che sembravano ancora piene di energia. L’altro cadavere che mi ha colpito è stato quello di Marcel Proust, fotografato sul letto di morte da Man Ray. Non so perché la foto sia stata scattata. Si usava fotografare i morti; per me è una cosa inutile, che pone problemi etici nei confronti della persona che abitava quel corpo: avrebbe voluto essere fotografata in quella situazione? Non sarebbe meglio ricordarla quand’era nel pieno della sua vitalità? Perché allora da giovane ho guardato tante volte la fotografia di Proust?
Forse per fissare bene nella mia mente il suo viso, così sensibile. Ricordo foto di cadaveri che non ho voluto distribuire (tra questi Moro all’obitorio), ma soprattutto quelle che ho distribuito: ancora Moro all’interno della Renault. Importante fotografia d’attualità, era cronaca ed era storia. Nessuna esitazione. Mi pentii invece di aver distribuito le immagini del cadavere di Herbert Kappler, ufficiale tedesco delle SS, autore dei più crudeli crimini contro gli ebrei a Roma. Ero esitante, ma me lo chiedevano con insistenza: forse era un sollievo per i parenti delle vittime vederlo finalmente morto? O così lo si faceva vivere di più?
Ora, con il trionfo del digitale, tutta l’etica e la cura nel distribuire le foto svaniscono. Sms e web hanno trasmesso in tempo reale le fotografie del cadavere di Gheddafi – e qualche anno fa la morte in diretta di Saddam Hussein. In quest’ultima occasione pregai la direttrice di Donna Moderna, femminile intelligente e di pratica utilità, di non mostrare l’immagine del cadavere del dittatore iracheno in una rubrica che tenevo ogni fine anno sulle fotografie significative dell’anno appena trascorso. Lei acconsentì e le sono grata. Una foto inutile da pubblicare, nella quale manca la pietas.
I cadaveri durante le insurrezioni. Ha senso pubblicarli? In certi casi sono eroi: se li “guardiamo” (dove “guardare” significa concentrarsi sull’immagine, così come si fa con una poesia), mi sembra che si possa dare un senso alla loro vita fissandola nella storia. Penso, per esempio, a una foto di una donna morta in Cecenia che, se fosse avulsa dalla storia che racconta, rientrerebbe nella categoria “beautiful Suffering”, la compiaciuta ricerca estetica nel fotografare la morte e il dolore. Scattata da Stanley Greene, noto fotografo americano, e parte di un lavoro durato una decina di anni, mostra il cadavere di una donna vestita sdraiata nella neve.
La violenza e la guerra sono così. Non ho mai distribuito questa immagine al di fuori del suo contesto: all’interno del servizio ha un grande valore, da sola diventa ostaggio dell’eventuale didascalia. Anche la fotografia del cadavere di una giovane donna a Sarajevo potrebbe scadere nel “beautiful Suffering”, ma nel libro e nella mostra Bosnia di Roger Hutchings è l’epilogo inevitabile e rigoroso di una tragica sequenza. Accarezzare ancora con gli occhi la bellissima ragazza è come avvolgerla della nostra pietà e del nostro amore. Un richiamo fortissimo alla pace.
Ho ceduto diverse volte la foto del cadavere di Che Guevara (47). È una foto eccezionalmente “bella”. Il cadavere sembra quello di un martire cristiano. Andava distribuita? Credo di sì. Se non lo avessi fatto io per l’Italia, cercando di darla a giornali non ostili al Che, lo avrebbe fatto qualcun altro con meno rigore e passione. Ricordo una fotografia che fece grandissimo scalpore, scattata da Kenneth Jarecke durante la guerra del Golfo (2 agosto 1990 28 febbraio 1991), guerra estremamente censurata: mostra il cadavere di un soldato iracheno morto carbonizzato mentre cercava di uscire da un carro armato in fiamme (48). Questa immagine non venne pubblicata subito, i primi a farlo furono i tabloid inglesi, poi i giornali di fotografia; infine uscì anche in Italia, mi pare su Panorama. È sicuramente una fotografia scioccante. Mentre in genere i filmati sulle guerre non si fissano nella mente, fotografie sconvolgenti come questa non ci lasciano più. Aveva forse ragione Marcel Duchamp che aveva scritto che un’immagine non è nulla se non è scioccante?
Tra i cadaveri che ho censurato, quello di una giovane francese che un giapponese aveva fatto a pezzi e messo in freezer, forse per mangiarlo. Le foto furono pubblicate su un giornale di fotografia francese. Mi rifiutai di venderle in Italia. Trovo curioso che nella stessa giornata in cui si chiedono le fotografie della morte del più celebre talebano, Giuliana Scimè, bravissima critica di fotografia, scriva una recensione alla mostra del World Press Photo 2010 (tenutasi alla Galleria Sozzani nel 2011) criticando drasticamente la scelta delle fotografie: “I visitatori usciranno devastati dall’orrore”.
Sì, l’anno è più cupo del solito, ma gli avvenimenti tragici hanno effettivamente subito un’impennata nel 2010, e non sottoscrivo, e anzi trovo ingiustificata e crudele la frase: “Questo non è fotogiornalismo, ma orripilante informazione visuale fine a se stessa, e nemmeno di qualità”. Ci sono dolore, sangue, violenza, ma le foto di cronaca e d’attualità (dal Messico ad Haiti) sono validissime, e come Giuliana stessa scrive la mostra andrà in Messico, così la popolazione potrà vedere le guerre messe in atto dal narcotraffico nel suo paese.
Christian Caujolle (che ama la fotografia come la vita) ha scritto testi straordinari. Nel suo libro Circostances particulières Souvenirs (Actes Sud) segnala come una delle sue foto preferite sia quella, molto violenta, scattata in Messico da Manuel Álvarez Bravo, che rappresenta un operaio ferito a morte durante una manifestazione. Braccia distese lungo i fianchi, un fiume di sangue dalla testa, il viso pacato. «Il fotografo – scrive Christian, – ha reso eterna l’immagine e noi non possiamo darle un’origine. L’operaio sanguinante è un nostro contemporaneo». Il titolo della fotografia è Operaio che sciopera, assassinato. Ed è il titolo, la scelta del termine “assassinato”, che esprime il punto di vista e la riprovazione, la rivolta di un fotografo che sa che la fotografia da sola non potrebbe testimoniare ciò che non può dire.
(Nella foto, il corpo di Che Guevara esposto in Bolivia nel 1967, MARC HUTTEN/AFP/Getty Images)
Grazia Neri è la fondatrice della prima agenzia fotografica italiana – che si chiamava come lei e ha chiuso nel 2009 – divenuta negli anni una delle più note al mondo. Ha appena pubblicato per Feltrinelli il libro di ricordi e riflessioni sul suo lavoro La mia fotografia, da cui è tratto questo capitolo.