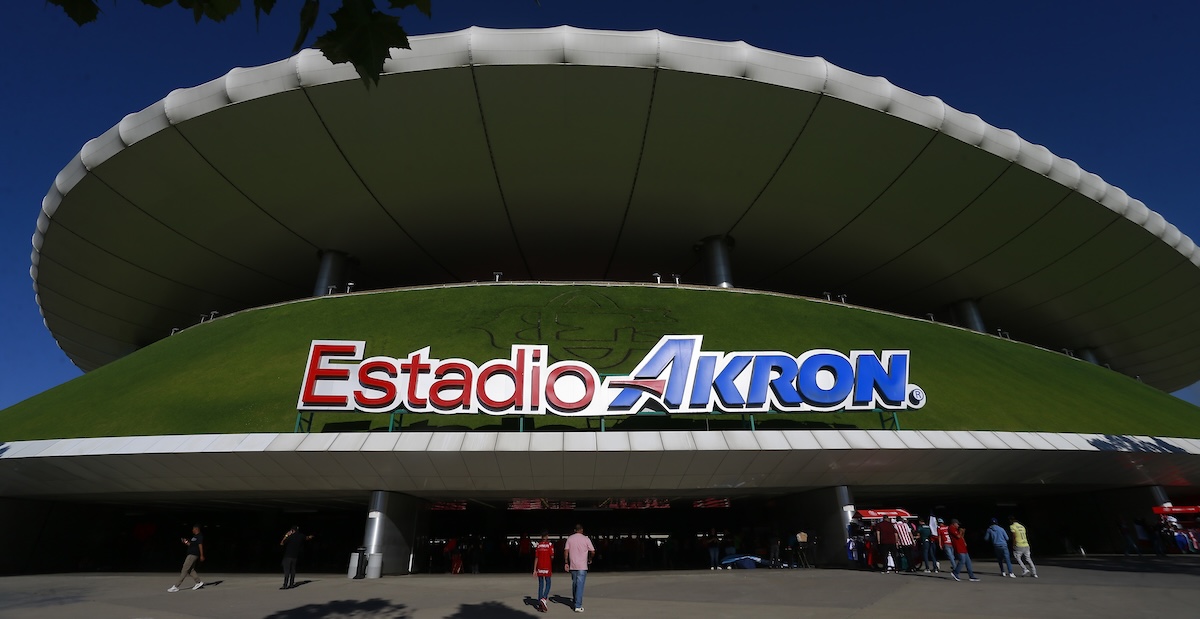Il problema con le elezioni a Taiwan
Il voto del prossimo 14 gennaio pone nuovamente la questione dei complicati rapporti tra "Repubblica di Cina" e "Cina Popolare" (che differenza c'è?)
di Matteo Miele, Royal University of Bhutan

altre
foto
La storia è piena di scherzi e paradossi. La vita politica di Taiwan ne è un esempio. Poco più di sessant’anni fa, nel 1949, Mao Tse-tung proclamava la nascita della Repubblica Popolare Cinese, volendo mettere sostanzialmente fine alla turbolenta vita della Repubblica Cinese, nata nel 1912. In realtà però Chiang Kai-shek e i suoi seguaci del Guomindang, il partito nazionalista, trovavano rifugio in un’isola a 120 chilometri di distanza dal continente, Formosa ovvero Taiwan, tornata da poco sotto la sovranità cinese dopo mezzo secolo di dominazione giapponese. Laggiù continuarono a chiamarsi “Repubblica di Cina” lasciando al mondo la facoltà di decidere quale dei due governi fosse il legittimo detentore del Mandato Celeste, chi fosse la vera Cina.
In un pianeta diviso in blocchi, i regimi comunisti si affrettarono a riconoscere Pechino mentre l’Occidente, sebbene più articolato, mantenne per diversi anni il sostegno al regime di Chiang Kai-shek, che riuscì così a conservare finanche il seggio riservato alla Cina nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L’asimmetria politica di un tale gioco diplomatico tenne duro, con alcune nobili defezioni (il Regno Unito per esempio inviò un incaricato d’affari a Pechino fin dal 1950 mentre la Francia riconobbe il governo comunista nel 1964), fino all’inizio degli anni ’70 quando l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione 2758 del 1971 accolse la Cina Popolare e decise di «espellere immediatamente i rappresentanti di Chiang Kai-shek». L’Italia aveva riconosciuto Pechino nel 1970 e a spingere Roma in tal senso vi era stato in primo luogo il socialista Pietro Nenni, ministro degli Esteri fino all’anno precedente.
Chiang Kai-shek morì il 5 aprile 1975 e quattro anni dopo, nel 1979, gli Stati Uniti, che già con Nixon avevano chiarito un nuovo modo di intendere la realtà asiatica, sotto la presidenza Carter riconoscono Pechino auspicando una soluzione pacifica e promettendo di continuare a difendere Taiwan da un’eventuale aggressione. Oggi qualche diplomazia superstite del vecchio sistema rimane in America centrale e meridionale, in Africa, in Oceania e in più la Santa Sede in Europa (per questo motivo a Roma, in Via della Conciliazione, vi è un’ambasciata della Repubblica di Cina). Il riconoscimento dell’una esclude necessariamente l’altra.
Taiwan rimaneva comunque una dittatura, filo-occidentale, ma pur sempre un regime autoritario di una minoranza arrivata dal continente alla fine degli anni Quaranta e che controllava la maggioranza locale. Il parlamento, l’Assemblea Nazionale, era stato “congelato”, non essendo possibili elezioni sul continente. Solo nel 1991 si arrivò infatti a una riforma costituzionale e a delle vere elezioni, tre anni dopo la morte del figlio ed erede politico di Chiang Kai-shek. A scontrarsi c’era da una parte il Guomindang, che aveva disegnato il destino dell’isola per più di quattro decenni, e dall’altra parte il Partito Democratico Progressista, nato nel 1986, prima con l’obiettivo di raggiungere la democrazia, poi con lo scopo di una piena indipendenza dell’isola. Dunque questo è il cuore della questione. Il Guomindang è diventato infatti il pilastro che tiene ancora in piedi questo confuso gioco politico. I nazionalisti, continuando a reclamare la propria legittimità sul continente, protraggono la propria identità nell’universo cinese. I democratici progressisti invece portano avanti l’idea di un paese diverso, di una Taiwan indipendente, non più Repubblica di Cina. I primi, nonostante la storia, sono ormai i più vicini a Pechino, mentre i secondi sono i nemici assoluti. L’indipendentismo taiwanese è figlio del crollo del Muro di Berlino e della rinascita economica della Cina continentale. In queste condizioni qualsiasi velleità nazionalista sui vicini è diventata solo inutile retorica.
I democratici progressisti raggiunsero la presidenza nel 2000 e poi nuovamente nel 2004, con Chen Shui-bian che nel 2007 chiese invano all’ONU l’ingresso di Taiwan rinunciando così al seggio cinese. Nel 2005 la Cina Popolare aveva approvato una legge anti-secessione che prevede anche soluzioni “non pacifiche”. Nel 2008, con il ritorno della presidenza nelle mani dei nazionalisti, la tensione si allenta. Ma Ying-jeou è eletto presidente della Repubblica. Hu Jintao incontra il presidente del Guomindang Wu Poh-hsiung e si apre un collegamento aereo diretto tra Cina continentale e Taiwan.
Le elezioni del prossimo 14 gennaio potrebbero segnare un ulteriore passo nel riavvicinamento, ma le logiche politiche dovranno continuare ad interrogarsi su quale status un’eventuale unificazione possa garantire a Taiwan. Il modello “un paese due sistemi” sperimentato con un relativo successo ad Hong Kong e a Macao (tornate alla Cina rispettivamente nel 1997 e nel 1999) è naturalmente la via obbligata, ma rimane il dubbio dell’applicabilità ad una “provincia” con oltre ventitre milioni di abitanti e con una recente ma sostanzialmente autonoma via alla democratizzazione, seppur culturalmente e socialmente installata nel mondo cinese.
Qualunque sia il risultato delle elezioni e dei successivi rapporti, Taiwan rimane comunque (come Hong Kong e Macao) la prova della possibilità di una via democratica cinese, in grado cioè di coniugare i capisaldi della democrazia liberale con l’immensità della civiltà del Celeste Impero.
foto: aaron tam/AFP/Getty Images