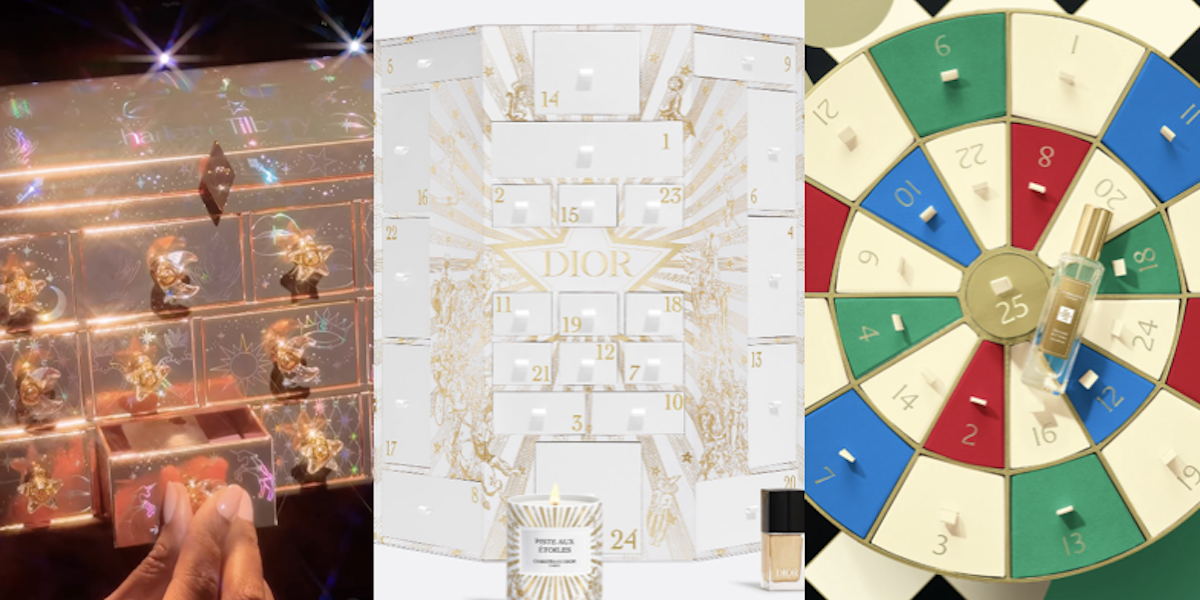Marta Dassù e il mondo
Il sottosegretario agli Esteri nominata ieri ha una lunga esperienza di politica internazionale, e la raccontò in un bel libro due anni fa

Nel nuovo governo Monti lunedì è stata nominata sottosegretario agli Esteri Marta Dassù, direttrice della sezione italiana dell’Aspen Institute e grande esperta di politica internazionale, che nel 2009 raccontò se stessa e molte sue esperienze e viaggi in un bel libro intitolato “Mondo privato” (Bollati Boringhieri), immaginandosi davanti a un analista. Questa è la descrizione che fa nel libro di un viaggio americano come consigliere del ministro D’Alema, nel 2006.
L’Airbus del governo italiano stava arrivando a Washington, il 16 giugno 2006, per il primo incontro fra Massimo D’Alema e Condoleezza Rice. Avevamo letto carte e appunti durante tutto il volo. Il ministro degli Esteri, di cui ero allora consigliere, doveva trovare le parole giuste per convincere il segretario di Stato americano che l’Italia del centro-sinistra sarebbe stata comunque un buon alleato. Diverso da Berlusconi ma un buon alleato.
Strane le circostanze della vita, pensai guardando dal finestrino il profilo del corso del Potomac. Nel marzo del 1999, sette anni prima circa, avevo accompagnato Massimo D’Alema, allora presidente del Consiglio, nella sua prima visita alla Casa Bianca. Nel 1999, D’Alema era andato a dire a Bill Clinton che l’Italia sarebbe stata dalla parte della Nato, nella guerra annunciata per il Kosovo. Non era stato facile, per lui. Durante la colazione alla Casa Bianca, l’ex comunista italiano aveva detto al presidente democratico americano: «Conosco bene Milosevic ́. Non penso proprio che si piegherà facilmente. La signora Albright dice che basteranno due giorni di bombardamenti. Non basteranno. Cosa farete se non basteranno?». Clinton aveva esitato, lasciando che fosse Sandy Berger, il suo consigliere alla Sicurezza nazionale, a rispondere. «Cosa faremo Sandy?». «Continueremo a bombardare, presidente». D’Alema aveva scosso la testa ma non aveva ribattuto, pensando che ormai fosse inutile. La decisione era stata presa. E Roma l’avrebbe appoggiata. Ma se dovessi spiegare perché D’Alema non ha mai avuto particolare fiducia nella lungimiranza delle presidenze americane, non partirei da troppo lontano. Partirei da lì. Da quel «We will keep bombing» di Sandy Berger.
Mi tirò fuori dai ricordi la voce del ministro degli Esteri, stavamo quasi atterrando. «Cosa pensi, Marta: meglio la camicia azzurra o la camicia bianca?». Mi sarebbe piaciuto essere il consigliere alla Sicurezza nazionale, sospirai. Ma ero solo una donna italiana: «La camicia bianca, no doubt».
Ci fu la solita rissa al Dipartimento di Stato. Intendo la rissa fra noi italiani, fra chi entra e chi sta fuori da un incontro. Al fischio dell’arbitro eravamo schierati così: Gianni Castellaneta, ambasciatore a Washington e il suo vice di allora, Stefano Stefanini, oggi rappresentante permanente dell’Italia alla Nato; Ferdinando Nelli Feroci, capo di gabinetto del ministro; Giulio Terzi di Santagata, direttore degli Affari politici; Claudio Bisognero, direttore generale per le Americhe alla Farnesina, più io e Chiara Ingrao, da anni interprete di D’Alema. Il ministro esordì in inglese mettendo subito sul tavolo il messaggio principale: verremo via dall’Iraq, come abbiamo annunciato nel programma elettorale, ma resteremo impegnati sul piano economico e civile; manterremo la nostra presenza militare in Afghanistan, anche se una parte della nuova maggioranza di governo non è affatto convinta che si debba fare così e sostiene la tesi del ritiro. Garantisco io come ministro degli Esteri – questo il senso delle sue prime parole a Condi Rice – che l’Italia non si ritirerà da Kabul. Impegno su questo il mio prestigio politico. Finché sarò ministro degli Esteri, l’Italia resterà in Afghanistan: puoi essere certa di questo.
Seduta a fianco di Stefano Stefanini, cercavo di capire che tipo di persona fosse realmente la prima donna afroamericana a essere diventata segretario di Stato, dopo avere ricoperto per alcuni anni – ma in modo poco soddisfacente, secondo gli «insiders» della Casa Bianca – la carica di consigliere per la Sicurezza nazionale. Al momento della sua nomina nell’Amministrazione Bush, nel 2000, Rice non era certo una sconosciuta a Washington. Nel suo curriculum di esperta di Unione Sovietica, e con una nomina prestigiosa alle spalle quale Prevost della Stanford University, rientrava la collaborazione giovanile con Brent Scowcroft, consigliere alla Sicurezza nazionale di Bush padre. Condi era insomma legata da anni al clan dei Bush; ed era nel tempo diventata la voce di politica estera più ascoltata alla Casa Bianca. Quali doti giustificavano un’ascesa così rapida? Che io, per fare solo un esempio casuale, non avevo invece vissuto? Secondo gli amici e gli esperti americani, intelligenza, fedeltà e soprattutto volontà. Una volontà di ferro. Doti così persuasive da giustificare la scherzosa previsione di Francis Fukuyama: «Prima o poi, ci ritroveremo tutti a lavorare per Condi».
Era proprio così intelligente e brillante? Dopo averla ascoltata per alcuni minuti giunsi intanto a una prima conclusione: intelligente sì, brillante sì, ma non una grande conoscitrice di questioni mediorientali – come non lo sono io, del resto, mi scoprii sconcertata a pensare. Quando Rice liquidò con troppa facilità i timori espressi da D’Alema sulla ripresa di attivismo talebano nel Sud del paese, rafforzai questa mia impressione iniziale.
Seguirono scambi non semplici sul problema israelopalestinese. Per il ministro italiano, il premier palestinese Abu Mazen non sarebbe riuscito a liberarsi così facilmente di Hamas. Se Israele voleva trattare con un interlocutore in grado di garantire davvero qualcosa, avrebbe quindi dovuto promuovere la costruzione di un governo di unità nazionale palestinese. Per Condi Rice, non era un’ipotesi percorribile né augurabile. Dopo il ritiro unilaterale israeliano da Gaza, Gerusalemme non avrebbe avuto niente da perdere, ma forse molto da guadagnare, da un vero e proprio showdown fra Hamas e Fatah, fra le due fazioni palestinesi – che l’America quindi auspicava e che si sarebbe in effetti verificato non molti mesi dopo.
Si capiva già da quel primo incontro. D’Alema era deciso a difendere una sua verità, sulle questioni mediorientali. Rice ne aveva in testa un’altra. Avevano deciso di fidarsi l’uno dell’altra e avrebbero collaborato in modo onesto, a tratti amichevole; ma da sponde abbastanza lontane.
Era passata quasi un’ora. Daniel Fried, responsabile delle questioni europee del Dipartimento di Stato, fece un segno a Condi, era arrivato il momento della conferenza stampa. Massimo si alzò abbastanza sollevato. Condi Rice lo guidò verso il palco da cui avrebbero parlato insieme e senza nessuna incertezza nei toni sintetizzò per dieci minuti il senso del suo incontro con il ministro degli Esteri italiano. La ascoltai affascinata.
A me la voce è sempre tremata un po’, parlando in pubblico. Ai primi esami di università dovevo mettermi un dito sul labbro, per quanto ballava. Grazie al dito non ho mai preso meno di 30. Con il passare degli anni i tremori si sono per fortuna ridotti, riesco perfino a parlare alla radio senza svenire. Ma l’insicurezza continuo a sentirla dentro di me, non mi è mai passata del tutto. E se cerco di capire perché, dottore, la risposta onesta, anche se probabilmente sbagliata, è questa: ho paura di venire scoperta.