Amedeo Balbi – Il buio oltre le stelle
Il primo capitolo del nuovo libro di Amedeo Balbi, astrofisico di riferimento del Post
di Amedeo Balbi

Non conosco nessuno che non trovi affascinante ed emozionante la visione del cielo stellato. Anche la persona più pratica e disincantata, se messa nelle giuste condizioni (una notte limpida, in un posto lontano da luci artificiali), alzerà istintivamente lo sguardo verso la volta celeste e si sentirà attraversata da una corrente di sensazioni e pensieri: stupore, ammirazione, senso di limitatezza di fronte all’immensità dell’universo, interrogativi sull’origine di tutto. Passato il momento lirico, alcuni torneranno probabilmente ad essere le persone aride di sempre. Ma per altri, la visione del cielo stellato può essere davvero un’esperienza che cambia la vita. Fate la prova. La prossima volta che non saprete come trascorrere il tempo libero, in una notte serena, andatevene lontano dalla città e, semplicemente, guardate il cielo. (Certe volte penso che aver illuminato artificialmente la notte non sia stata per l’umanità solo una forma di protezione da ladri, assassini, animali feroci e altri pericoli concreti, ma anche un esorcismo nei confronti di quell’inesorabile promemoria della nostra finitezza.)
Quando ero bambino, guardare il cielo notturno al mare, d’estate, in un ambiente che era così diverso da quello cittadino in cui vivevo per il resto dell’anno, significava affacciarsi su un mondo di domande e di misteri, e forse questa è stata una delle molle più o meno inconsapevoli che da adulto mi hanno portato a fare l’astrofisico di professione. Probabilmente, nell’infanzia dell’umanità, l’astronomia è nata in modo molto simile, dalla semplice ammirazione per uno spettacolo che sembrava incomprensibile. L’universo degli antichi era piuttosto semplice. Essenzialmente era limitato a quello che si poteva vedere nel cielo di notte, a occhio nudo. Se si trattava di immaginare bizzarre divinità, paurosi fantasmi o miti complicati, la fantasia degli uomini del passato era inesauribile. Ma quando si passava dall’immaginazione alla realtà, e ci si fermava a quello che si poteva vedere, bisognava concludere che il cosmo fosse tutto sommato abbastanza limitato.
C’erano molti puntini luminosi, le stelle, apparentemente in posizioni fisse e immutabili tra loro, anche se si spostavano tutte insieme durante la notte e con le stagioni. Poi c’era qualche puntino a prima vista identico agli altri che, però, a guardarlo attentamente per un po’ di tempo, cambiava posizione rispetto alle stelle. Quelli erano i pianeti, ed erano soltanto cinque: Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. In più c’era un astro strano, più grande e continuamente mutevole, la Luna. E di giorno c’era il Sole che la faceva da padrone. Tutto qui. Le stelle visibili a occhio nudo nel cielo sono meno di quante sembrino: il numero esatto dipende ovviamente dalle condizioni ambientali, ma anche in una situazione ottimale non se ne vedono più di tremila, circa, nel nostro emisfero (e altrettante nell’emisfero opposto). La maggior parte delle stelle appare addensarsi attorno a una striscia luminosa dai contorni irregolari, la Via Lattea. Per il resto, il cielo notturno è completamente buio: ciò che domina, in termini di spazio, è l’oscurità, non la luce. E a pensarci bene, lo spettacolo maestoso della volta stellata, lo stesso che ha dato origine all’astronomia e reso possibile lo studio dell’universo, è dovuto proprio al contrasto tra la miriade di minuscoli puntini luminosi e lo sfondo perfettamente scuro su cui si stagliano.
Ma probabilmente a nessun osservatore antico, armato solo della propria vista, sarà venuto in mente di poter penetrare il mistero della parte buia del cielo, di chiedersi se ci fosse altro rispetto a quello che si vedeva. All’inizio, l’astronomia fu semplicemente il tentativo di misurare e prevedere le variazioni stagionali nell’aspetto del cielo notturno: le regolarità nel moto dei pianeti e la posizione accurata delle stelle fisse. L’interesse era da un lato mitico-religioso, dall’altro pratico: un modo per orientarsi e per misurare il passare del tempo. Non si poteva fare molto di più con quello che si vede a occhio nudo. La cosa più frustrante per i primi astronomi dev’essere stata l’impossibilità di conoscere con certezza la distanza di quei punti luminosi, che pure certe volte sembrano così vicini da poterli toccare. Erano più alti delle montagne più alte, e al di là delle nuvole: ma di quanto? E cosa li teneva sospesi in cielo, cosa li muoveva?
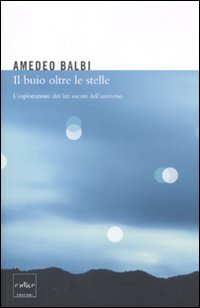
Erano incastonati in sfere trasparenti, attaccati a fili invisibili mossi da ingranaggi complicati e impercettibili, oppure erano più leggeri dell’aria e volteggiavano come fuochi fatui o sbuffi di vapore; o ancora, erano portati in giro da spiriti o angeli, o erano spiriti e angeli loro stessi? Qualche pensatore più scaltro degli altri iniziò ad escogitare metodi per colmare lo spazio tra la terra e il cielo, e per misurare la distanza di oggetti che non possiamo toccare.
Il primo, secondo le cronache, fu Aristarco di Samo. Intorno al 250 a.C., osservando la grandezza dell’ombra che la Terra proietta sulla Luna durante un’eclissi, Aristarco riuscì a stimare il raggio della Luna in proporzione a quello terrestre. Il risultato era relativamente vicino a quello che oggi sappiamo essere il valore corretto, ma per conoscere la distanza della Luna dalla Terra bisognava prima stimare il raggio terrestre. Questo fu misurato da Eratostene, qualche tempo dopo, con un metodo semplice e ingegnoso: se si pianta un’asta di lunghezza fissa, a una certa ora e in un certo periodo dell’anno, in punti abbastanza distanti tra loro lungo un meridiano terrestre (cioè lungo la direzione nord-sud), si osserva sul terreno un’ombra di lunghezza diversa.
Dal confronto fra le lunghezze si può misurare l’angolo formato tra i due punti rispetto al centro della Terra (ovvero la loro differenza di latitudine) e quindi, conoscendo la distanza geografica tra i due punti, risalire al raggio terrestre. In pratica, la misura sfruttava direttamente la curvatura della superficie terrestre, cosa che testimonia il fatto che la sfericità della Terra fosse ben nota molti secoli prima che i navigatori circumnavigassero il globo. I pensatori antichi non erano affatto degli sprovveduti. Aristarco misurò anche la distanza del Sole dalla Terra, e di conseguenza il suo raggio: un compito decisamente più difficile, che richiedeva la misura dell’angolo formato da Terra, Sole e Luna quando quest’ultima appare nel cielo illuminata esattamente per metà.
L’angolo in questione è molto piccolo e difficile da misurare con precisione, e il risultato di Aristarco è piuttosto impreciso per gli standard moderni: ma l’aver congegnato quel metodo di misura rivela idee piuttosto chiare sulla natura della Luna, del Sole e della Terra, e delle relazioni geometriche fra loro. In effetti, Aristarco ideò un modello di sistema solare piuttosto avanzato, con il Sole al centro del moto dei pianeti e la Luna in orbita intorno alla Terra. Il primo esempio documentato di sistema eliocentrico. Ma per ragioni filosofiche, peraltro non disprezzabili se ci si mette nei panni dei pensatori dell’epoca, il modello di Aristarco non riscosse grande credito: dopotutto a nessuno pare che la Terra si muova, e l’idea di gravità allora non era quella a cui siamo abituati oggi. I corpi cadono perché vanno naturalmente verso il centro dell’universo, si pensava all’epoca, e quando giungono sulla Terra trovano finalmente la loro posizione naturale di quiete. Non è sorprendente, quindi, che il modello accettato di universo finì per essere quello formalizzato da Tolomeo intorno al ii secolo d.C., con la Terra al centro e gli altri pianeti, Luna, Sole e stelle fisse, a girarle attorno. Un modello che, grazie a un complicato sistema di orbite circolari combinate fra loro, riusciva ad essere in ottimo accordo non soltanto con il senso comune, ma anche con le osservazioni dei moti planetari.
Per diversi secoli il modello di Tolomeo fu tutto quello di cui gli astronomi ebbero bisogno per spiegare quanto osservavano nel cielo. A nessuno sarebbe venuto in mente che, ben nascosto alla vista, potesse in realtà esserci molto di più. L’universo era tutto lì, squadernato nel cielo notturno, e se ne poteva prevedere il comportamento con grande precisione. Un buon astrolabio era più che sufficiente a contenere tutto il cosmo. Ogni tanto, però, a guastare quell’ordine regolare, spuntava un fenomeno inusuale e inspiegabile: una cometa, per esempio, oppure una “stella nuova” (quella che ancora oggi continuiamo a chiamare una nova o una supernova, pur avendo compreso che si tratta di una stella morente, piuttosto che appena nata). In genere questi fatti insoliti venivano interpretati dalla popolazione come segni di imminenti sciagure, del malumore divino, o comunque di grandi mutamenti in arrivo. Ma anche tra gli astronomi professionisti le idee non erano molto più chiare. Piuttosto che contaminare la presunta perfezione delle sfere celesti, si preferiva pensare che questi fenomeni avvenissero nell’atmosfera, o al massimo all’interno dell’orbita lunare. Fu proprio l’improvvisa comparsa di uno di questi strani segni dal cielo, la supernova del 1572, a dare il via a una catena di eventi che finì per spalancare una finestra su un universo fino ad allora sconosciuto.
Quando il nuovo astro iniziò a brillare, Tycho Brahe aveva ventisei anni ed era già pericolosamente attratto dall’astronomia, nonostante la sua famiglia, una delle più ricche in Danimarca, avesse in mente per lui ben altra carriera. Tycho investì parte del patrimonio familiare nella costruzione di uno strumento (un quadrante, per l’epoca sofisticatissimo) che gli consentisse di misurare eventuali cambiamenti di posizione della nuova stella rispetto alle stelle fisse. Le misure di Tycho determinarono senza ombra di dubbio che l’astro non si muoveva rispetto alle altre stelle, e che per questo doveva trovarsi come loro a una distanza enorme dalla Terra. C’erano quindi altre cose nell’universo, cose che normalmente non si vedevano ma potevano sbucare fuori dall’oscurità senza alcun preavviso.
La scoperta non solo iniziò a mettere in dubbio pregiudizi secolari sulla natura del cosmo, ma rese Tycho l’astronomo più famoso d’Europa. Il re Federico ii di Danimarca gli concesse una quantità di fondi enorme e l’intera isola di Hven per costruire Uraniborg, l’osservatorio astronomico più avanzato dell’epoca. Grazie a risorse economiche praticamente illimitate e alla sua incredibile abilità, Tycho spinse la precisione nella determinazione della posizione e dei moti dei corpi celesti a vette mai raggiunte prima di allora. Come sempre accade nella storia della scienza, l’arrivo di dati più accurati rappresentò una sfida per le previsioni dei modelli teorici. Alla sua morte Tycho lasciò un insieme di osservazioni di straordinaria qualità, ma non un’interpretazione in grado di spiegarle in modo convincente. Il modello di Tolomeo cominciava a mostrare segni di affanno, soprattutto quando si trattava di spiegare lo strano comportamento di Marte.
Il moto del pianeta nel cielo, fatto di capricciosi avanzamenti e arretramenti, era sempre stato un enigma per gli astronomi: Tolomeo era riuscito in qualche modo ad averne ragione escogitando un complicato sistema di orbite circolari innestate una sull’altra, i cosiddetti epicicli. Tycho aveva ideato un modello alternativo, in cui la Terra era al centro del moto del Sole e della Luna, ma gli altri pianeti ruotavano intorno al Sole.
Tuttavia, il modello di Tycho, oltre ad essere ancora più cervellotico di quello tolemaico, non aveva maggiore successo nella spiegazione dei dati. Oggi, in tempi in cui per essere un ricercatore di successo è richiesta un’estrema specializzazione in un singolo campo del sapere, è normale che uno scienziato che eccelle nelle osservazioni e nelle misure non sia altrettanto attrezzato nel mettere a punto il quadro teorico per interpretarle. Ma anche all’epoca in cui l’astronomia moderna muoveva i primi passi, i talenti venivano assegnati dalla sorte in modo ineguale.
Tycho era il più grande osservatore dei suoi tempi, ma evidentemente non era altrettanto abile con la teoria. Fortunatamente il fato gli mise accanto come assistente un uomo che gli era complementare in tutto. Keplero, che al contrario di Tycho veniva da una famiglia disfunzionale e da un’infanzia poverissima, era miope e non avrebbe mai sfondato come osservatore; ma era dotato di tenacia smisurata, pignoleria, talento coi numeri e capacità di astrazione. Era lui la persona giusta per fondare l’astronomia teorica moderna.
Alla morte di Tycho, Keplero ne ereditò le osservazioni e l’ossessione per il mistero del moto di Marte. Convinto che la spiegazione corretta stesse nell’adozione di un modello con il Sole al centro del moto dei pianeti (in pratica il modello di Aristarco, riproposto da Copernico qualche decennio prima), Keplero si imbarcò nell’impresa di dare un inquadramento matematico ai dati di Tycho: impresa che si rivelò molto più dura del previsto. Mettendosi all’opera, Keplero si era illuso di riuscire a trovare una soluzione nel giro di otto giorni. Invece ci mise otto anni, riempiendo quasi mille pagine di calcoli. Per gli appassionati di coincidenze numeriche, l’ostacolo che ritardò così a lungo il completamento del progetto di Keplero fu una discrepanza di soli otto minuti d’arco nella previsione del moto di Marte.
Otto minuti d’arco che sarebbero stati assolutamente trascurabili per gli astronomi venuti prima di lui, ma che diventavano importanti se messi a confronto con la straordinaria accuratezza delle osservazioni di Tycho. (Un minuto d’arco è un sessantesimo di grado: otto minuti d’arco corrispondono quindi alla duemilasettecentesima parte di una circonferenza.) La soluzione trovata da Keplero e pubblicata finalmente nel 1609 non fu solo un passo in avanti verso l’adozione di un modello eliocentrico per il sistema solare, ma rappresentò un salto concettuale ancora più profondo.
Nello schema di Keplero i pianeti non si muovono attorno al Sole con velocità costanti, e le orbite non sono cerchi perfetti, come ostinatamente si era voluto ipotizzare fino ad allora, ma ellissi. Keplero sganciò per sempre quei puntini luminosi dalle ipotetiche sfere invisibili in cui erano incastonati, lasciandoli a vagare sospesi nel vuoto dello spazio.
L’universo non era più uno spettacolo di luci appese a una giostra, allestito a beneficio del genere umano. Il moto dei pianeti era qualcosa che richiedeva una spiegazione più profonda e Keplero fu a un passo dal trovare di nuovo quella giusta, ipotizzando un’azione a distanza fra i corpi celesti (quella che oggi chiameremmo forza di gravità). Ma i tempi non erano ancora maturi. Era invece arrivato il momento per rompere un altro muro che aveva resistito per millenni, da quando l’uomo aveva cominciato ad osservare il cielo.
Proprio mentre Keplero annunciava la soluzione dell’enigma delle orbite dei pianeti, un italiano, sfruttando e perfezionando l’invenzione di un artigiano fiammingo, stava per squarciare il velo oscuro sul quale erano stati adagiati fino ad allora i punti luminosi che formano lo spettacolo del cielo notturno. Nel 1609, Galileo Galilei fece un gesto semplice e allo stesso tempo rivoluzionario. Prese un cannocchiale che si era costruito da solo (due lenti infilate in un tubo: poco più di un giocattolo, se lo giudichiamo con la nostra spocchia di gente abituata a mirabolanti strumenti tecnologici, ma una conquista straordinaria per quei tempi) e lo puntò verso il cielo.
Fu come se l’oscurità diventasse improvvisamente meno buia. Le osservazioni di Galileo mostrarono che anche zone del cielo apparse sempre completamente vuote erano in realtà piene di altri puntini luminosi, fino ad allora sfuggiti alla vista. «Grande cosa è certamente alla immensa moltitudine delle stelle fisse che fino ad oggi si potevano scorgere con la facoltà naturale, aggiungerne e far manifeste all’occhio umano altre innumeri, prima non mai vedute e che il numero delle antiche e note superano più di dieci volte», scrive Galileo nel Sidereus Nuncius, il resoconto in presa diretta delle sue osservazioni, del 1610. Secondo me è una delle cose più emozionanti mai scritte: il racconto di un uomo che si accorge di vedere nelle profondità del cielo notturno cose che nessun altro aveva visto prima di allora. Armato del suo cannocchiale, Galileo scoprì, tra le altre cose, che Venere aveva fasi proprio come la Luna, e notò l’esistenza di quattro puntini mai visti prima che sembravano orbitare intorno a Giove, e che correttamente identificò come satelliti del pianeta. Entrambe le cose erano in conflitto con il modello tolemaico di sistema solare.
Le osservazioni di Galileo, assieme alle leggi teoriche formulate da Keplero, furono quindi essenziali per stabilire la validità del modello eliocentrico di sistema solare. Ma la vera conquista di Galileo fu il mostrare al mondo che, potenziando la vista con un aiuto tecnologico (un aiuto peraltro alla portata di tutti, cosa che non poteva certo far piacere ai difensori dell’ordine costituito), sbucavano fuori dal buio del cielo notturno innumerevoli altre meraviglie. Era solo il primo esempio di quella che sarebbe stata la regola dell’indagine astronomica per i secoli a venire: ogni nuovo strumento escogitato dall’inventiva umana avrebbe risolto alcuni interrogativi, ma allo stesso tempo avrebbe reso l’universo più grande e più complesso di quanto si fosse pensato in precedenza.
Così, dopo Galileo, il terreno di indagine dell’astronomia si ampliò enormemente. L’enorme distesa del cielo buio si spalancava inesplorata, terreno vergine e sconosciuto da conquistare. Tycho fu l’ultimo – e il migliore di tutti – a scrutare la volta celeste armato soltanto dei suoi occhi. Ora, se si volevano scandagliare gli abissi della parte buia del cielo, c’era bisogno di nuovi strumenti. Non c’è resoconto della storia della rivoluzione scientifica del xvii secolo che non ricordi la leggenda di Newton e della mela, una specie di storia zen (forse apocrifa, ma con ogni probabilità originata da Newton stesso) in cui, dopo una lunga e infruttuosa meditazione, l’illuminazione arriva improvvisa e inaspettata grazie a un evento esterno.
Osservando una mela cadere da un albero (o, secondo alcune versioni, venendone colpito sulla testa), Newton fu spinto a supporre che potesse esistere una forza invisibile, la forza di gravità, in grado di agire a distanza su tutta la materia, non solo qui sulla Terra, ma ovunque nell’universo. Una forza del genere avrebbe spiegato come mai i pianeti si muovono lungo orbite ellittiche intorno al Sole, senza un vincolo materiale che li forzi a percorrerle. D’altra parte, ipotizzare che tra corpi separati dallo spazio vuoto potesse agire una forza invisibile sembrava un po’ troppo, anche in un’epoca più disinvolta in materia di princìpi occulti. Newton stesso era perplesso di fronte al modo in cui sembrava funzionare la gravità, ma ebbe un atteggiamento pragmatico, da scienziato moderno: «Non sono stato in grado di scoprire le cause di tali proprietà della gravità, e non avanzo ipotesi. Poiché tutto ciò che non è dedotto dai fenomeni va chiamato ipotesi; e le ipotesi, siano esse metafisiche, fisiche, basate su qualità occulte, o meccaniche, non hanno posto nella scienza sperimentale. […] È sufficiente che la gravità esista e agisca secondo le leggi che ho spiegato e che sia in grado di rendere conto di tutti i moti dei corpi celesti», scrisse nell’appendice alla seconda edizione dei Principia.
E in effetti la legge di gravitazione universale, usata assieme ai tre princìpi della dinamica e al calcolo infinitesimale (anche questi ultimi sviluppati da Newton), era in grado di fornire una spiegazione matematicamente e fisicamente coerente delle osservazioni astronomiche e delle leggi che Keplero aveva escogitato per interpretarle. Per Newton, i pianeti si muovevano nel modo in cui si muovevano non perché rispondessero a chissà quali speciali meccanismi celesti, ma perché erano soggetti alle stesse leggi di tutto il resto della materia (così in cielo, come in terra). L’opera di Newton nel campo della meccanica fu talmente importante e rivoluzionaria che oggi tende a oscurare i suoi contributi allo studio dell’ottica. Eppure la tenacia di Newton nel tentare di comprendere la natura della luce fu straordinaria.
Rischiò di perdere la vista in almeno un paio di occasioni durante i suoi esperimenti: una volta per aver fissato il Sole troppo a lungo, un’altra per aver tentato di alterare la forma della sua retina con l’ausilio di uno spillone. In modo meno pericoloso per se stesso, usando un sistema di prismi e di lenti, Newton non solo dimostrò che la luce naturale poteva essere scomposta in uno spettro di colori, ma che a loro volta i raggi di luce colorata che formano l’iride potevano essere ricomposti in un raggio di luce bianca. Inoltre mostrò che ciascun raggio di luce colorata non poteva essere ulteriormente scomposto: un raggio di un certo colore restava di quel colore anche dopo ulteriori riflessioni o passando attraverso vetri, prismi e lenti, e la stessa cosa avveniva per tutti i colori dell’iride.
Questi esperimenti con la luce e i colori portarono tra l’altro Newton a inventare un nuovo tipo di telescopio che eliminasse i fastidiosi aloni iridescenti che disturbavano le osservazioni effettuate con i telescopi di tipo galileiano. Inoltre ipotizzò che la luce fosse composta di minuscole particelle, riuscendo in questo modo a spiegare in maniera soddisfacente la propagazione dei raggi luminosi e i fenomeni ottici noti all’epoca. Una teoria alternativa sulla natura della luce fu proposta negli stessi anni da Robert Hooke e poi da Christiaan Huygens, i quali supposero che essa fosse composta di onde che viaggiavano attraverso un ipotetico mezzo invisibile diffuso in tutto lo spazio, il cosiddetto etere luminifero. Le due teorie sulla natura della luce si fronteggiarano per molto tempo con alterne fortune, praticamente fino all’inizio del xx secolo. Oggi sappiamo che la luce ha allo stesso tempo natura corpuscolare e ondulatoria, e che la si può descrivere tanto in termini di onde (le onde elettromagnetiche) che in termini di particelle prive di massa che si muovono alla velocità della luce (i fotoni). Ma anche nei secoli in cui la controversia tra i seguaci della teoria corpuscolare di Newton e i fautori dell’interpretazione ondulatoria di Huygens era ancora lontana dal trovare una soluzione, la cosa che contava per gli astronomi era una sola: nemmeno un po’ della luce proveniente dalle profondità del cielo notturno poteva andare sprecata.
I progressi compiuti nell’ottica dal xvii secolo in poi portarono a una migliore comprensione del funzionamento dei telescopi e al loro costante perfezionamento. Si capì che per far emergere dall’oscurità le stelle più lontane e più deboli bisognava concentrare la loro luce in modo efficiente, facendola convergere nell’oculare dei telescopi. In termini moderni, questo equivale a raccogliere più fotoni possibili in una certa area. Nell’occhio umano l’area interessata è molto piccola, quella della pupilla. Per poter vedere sorgenti luminose molto deboli, il trucco è allora quello di ampliare artificialmente l’area delle nostre pupille. Che si tratti di un cannocchiale di tipo galileiano, in cui la luce viene fatta convergere attraverso una lente, o di un telescopio newtoniano, in cui è uno specchio a raccogliere e concentrare i raggi luminosi, la regola è sempre la stessa: aumentare l’area del sistema di raccolta si traduce nella possibilità di vedere oggetti sempre meno luminosi.
Costruire un telescopio è come fabbricare un catino per raccogliere la pioggia: più è grande, meglio è. Intorno alla fine del xviii secolo, il telescopio più grande e più potente ce l’aveva un signore che aveva iniziato da dilettante, come molti astrofili odierni, costruendosi i suoi strumenti nel giardino di casa. William Herschel era un tedesco naturalizzato britannico che di mestiere faceva il musicista, e nel tempo libero si divertiva a guardare le stelle. Nel 1781 una delle sue osservazioni notturne lo fece entrare nel club degli astronomi che contano: Herschel scoprì un nuovo pianeta, quello che oggi chiamiamo Urano. Come Galileo prima di lui, Herschel si era costruito da solo il suo telescopio; e come Galileo, che per ingraziarsi la potente famiglia de’ Medici aveva chiamato “Astri Medicei” i satelliti di Giove che aveva scoperto, Herschel decise di farsi benvolere da re Giorgio iii chiamando il nuovo pianeta “Astro di Giorgio”. Grazie ai soldi del re, Herschel potè costruirsi quella che all’epoca era una vera e propria meraviglia tecnologica: il telescopio più grande del mondo, un gigante con un’apertura di 1,2 metri.
Con il suo nuovo telescopio, Herschel poté iniziare un ambizioso programma di mappatura della volta celeste. Alla sua morte, egli lasciò al mondo il primo modello tridimensionale della Via Lattea, di cui era riuscito a comprendere la vera natura: quella striscia luminosa nel cielo era in realtà un disco formato da un numero enorme di stelle, tra cui il nostro Sole. Herschel non fu in grado di determinare le distanze assolute delle stelle da noi (le espresse in unità relative alla distanza della stella Sirio, ipotizzando erroneamente che avessero tutte più o meno la stessa luminosità) e sbagliò a posizionare il Sole approssimativamente al centro della Via Lattea. Nonostante ciò, comprese correttamente che il Sole faceva parte di una vasta isola cosmica – una galassia, diremmo oggi – formata da moltissime altre stelle. Restava da capire se la nostra galassia fosse l’intero universo, o ci fosse dell’altro. Herschel era convinto che la Via Lattea racchiudesse l’intero contenuto materiale del cosmo.
Ciò includeva anche una serie di oggetti celesti che non sembravano stelle, ma che il telescopio mostrava come nuvolette luminose, e che per questo venivano chiamate in modo generico nebulose. (Alcune nebulose sono riconoscibili anche a occhio nudo.) Herschel ne classificò oltre duemila, senza riuscire a chiarirne definitivamente la natura, ma restando personalmente convinto che si trattasse di stelle in formazione facenti parte della Via Lattea. Per alcuni, però, tra cui il filosofo Immanuel Kant, quei batuffoli di luce erano altre galassie simili alla Via Lattea, separate dalla nostra da immensi spazi vuoti. La questione si trascinò a lungo, in una battaglia giocata a colpi di osservazioni meticolose condotte su telescopi sempre più grandi. Nel xix secolo il primato di Herschel fu soppiantato da Lord William Parsons, conte di Rosse, che fece costruire un enorme telescopio con un’apertura di 1,8 metri, appropriatamente ribattezzato “il Leviatano”. Grazie a questo gigante fu possibile stabilire che molte delle nebulose osservate, se non tutte, avevano strutture complicate che somigliavano a spirali di luce: alcune di queste, inoltre, sembravano contenere al loro interno altre stelle.
Poi vennero nuovi strumenti: la scoperta della fotografia, con la possibilità di impressionare una lastra di materiale sensibile per tempi molto lunghi, permise di raccogliere i fotoni in modo più efficiente e di analizzare le immagini in modo più obiettivo e accurato. Eppure, ancora nel 1920 la natura delle nebulose a spirale era oggetto di dispute, e gli astronomi erano divisi in due fazioni: quelli che pensavano che la Via Lattea fosse tutto ciò che c’era nell’universo e quelli che vedevano le nebulose come altre isole cosmiche immensamente lontane dalla nostra. La controversia tra gli astronomi trovò la sua arena simbolica alla National Academy of Sciences di Washington, dove il 26 aprile del 1920 si svolse quello che passò alla storia come il “Grande Dibattito”. I contendenti erano Harlow Shapley, sostenitore della posizione che vedeva le nebulose come oggetti facenti parte della Via Lattea, e Heber Curtis, che parlava a nome di chi riteneva le nebulose altre galassie esterne alla nostra. I testimoni dell’epoca furono concordi nel ritenere che Curtis uscì decisamente sconfitto dal dibattito.
Ma la gloria di Shapley durò poco. Anche grazie al successo ottenuto nel dibattito, Shapley lasciò l’osservatorio di Mount Wilson in California per andare a fare il direttore dell’osservatorio di Harvard. A Mount Wilson era arrivato nel frattempo un astronomo giovane e sicuro di sé, Edwin Hubble, determinato a risolvere una volta per tutte il problema della natura delle nebulose a spirale. Poco dopo l’arrivo di Hubble, a Mount Wilson fu inaugurato il telescopio più grande del mondo, il telescopio Hooker di 2,5 metri di apertura. Purtroppo per Shapley, la scelta di trasferirsi ad Harvard risultò piuttosto infelice, perché quello era proprio lo strumento che avrebbe risolto per sempre la questione delle nebulose.
Il problema era, in ultima analisi, lo stesso che, da Aristarco in poi, aveva assillato coloro che osservavano la volta celeste: la determinazione delle distanze. Quanto erano lontane quelle nebulose? Se fossero state molto lontane, la loro luminosità apparente avrebbe portato a concludere che esse emettevano moltissima luce, e che quindi contenevano un numero enorme di stelle, dando ragione a chi sosteneva che si trattasse di galassie simili alla nostra. Shapley era stato determinante nello stabilire le reali dimensioni della Via Lattea, calcolando la distanza degli ammassi globulari, grandi concentrazioni sferiche di stelle che si trovano sparse nella nostra galassia. Per farlo aveva usato come metro un particolare tipo di stelle, chiamate Cefeidi, la cui luminosità varia con il tempo: il periodo di variazione è legato alla luminosità, per cui dalla sua misura si può stimare la distanza della stella. Ma anche se i confini della Via Lattea erano ora noti con buona precisione, la distanza delle nebulose a spirale restava un mistero.
La notte del 4 ottobre 1923, Edwin Hubble puntò il telescopio Hooker verso una delle nebulose più visibili (è osservabile anche a occhio nudo, in condizioni ottimali), la nebulosa di Andromeda. Incuriosito da una macchiolina che inizialmente identificò come una nova, Hubble proseguì le osservazioni, e nel giro di pochi giorni capì che in realtà aveva scoperto una Cefeide nella nebulosa di Andromeda. Questo voleva dire che era finalmente possibile misurare la distanza di Andromeda. Applicando il metodo perfezionato da Shapley, Hubble concluse che Andromeda era almeno tre volte più lontana da noi del confine del disco della Via Lattea. La conclusione possibile era una sola: si trattava di un’altra galassia, contenente un numero enorme di stelle.
Dopo aver letto la lettera con la quale Hubble gli comunicava i risultati delle sue osservazioni, Shapley commentò: «Questa è la lettera che ha distrutto la mia visione dell’universo». La scoperta di Hubble che nell’universo ci sono altre galassie oltre alla nostra è stata solo un ulteriore passo (ma non il definitivo) di un lungo percorso iniziato quando i nostri antenati alzarono per la prima volta lo sguardo verso la volta celeste. Il buio della notte, punteggiato da poche migliaia di minuscole luci, si è rivelato sempre meno buio man mano che lo si è osservato con strumenti più potenti. Da Galileo in poi, le stelle della nostra Via Lattea sono diventate centinaia di migliaia, poi milioni, poi miliardi. Oggi sappiamo che sono centinaia di miliardi. La sfera delle stelle fisse si è lentamente trasformata in una struttura tridimensionale, ricca, complessa e affascinante.
Oltre i confini della nostra galassia sono emerse dal nero del cielo notturno altre innumerevoli isole cosmiche. L’universo è diventato un posto complesso ed enorme, contenente centinaia di miliardi di galassie come la nostra, ognuna con le sue centinaia di miliardi di stelle: galassie così distanti che la loro luce ci appare come un fioco lumicino che solo i telescopi più potenti riescono a catturare. Scrutando nel buio con tenacia e inventiva siamo riusciti a diventare gli spettatori di uno spettacolo ben più maestoso di quello che la volta celeste offre ai nostri sguardi nudi.
***
Esce per Codice Il Buio oltre le stelle, il nuovo libro di Amedeo Balbi.
Balbi è astrofisico, si divide tra carriera scientifica e divulgazione. Dopo aver lavorato a Berkeley e Pasadena, ora è ricercatore e professore aggregato a Tor Vergata, Roma.
Scrive per Il Post, e ha un suo blog che si chiama Keplero. Ha pubblicato La musica del big bang (Springer, 2007) e Seconda stella a destra. Vite semiserie di astronomi illustri
(DeAgostini, 2010).





