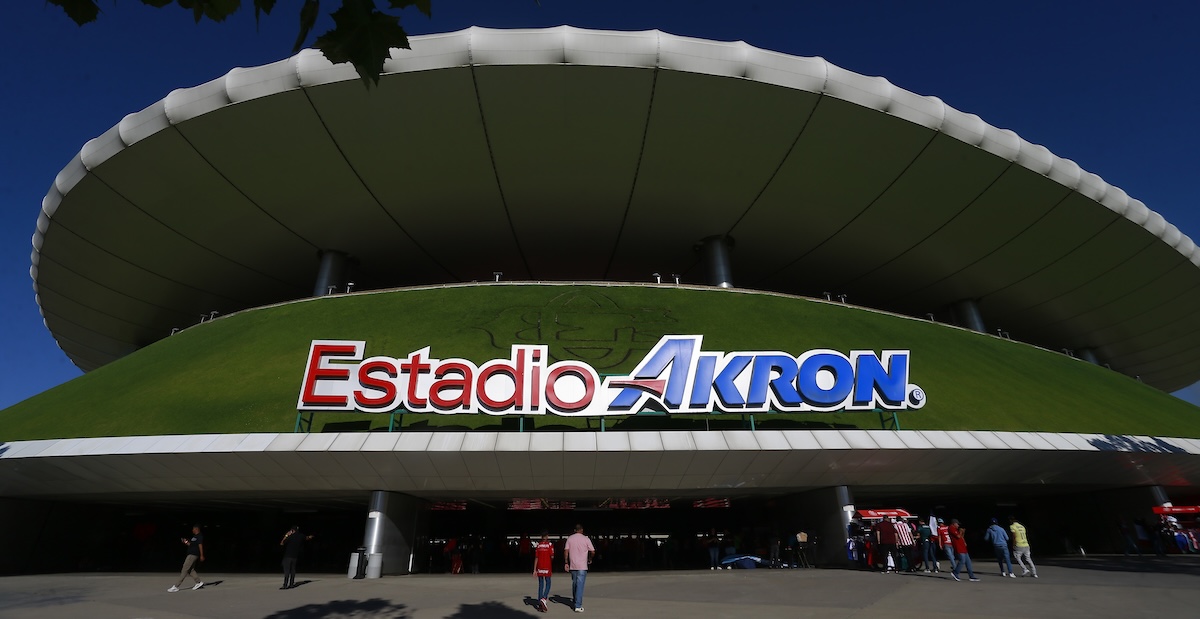Aveva ragione Bush?
La stampa internazionale si chiede se quanto accade in Tunisia e in Egitto rivaluti l'idea dell'esportazione della democrazia
di Francesco Costa

Davanti a quanto sta accadendo in Tunisia, in Egitto e in parte del mondo arabo, negli ultimi giorni in molti si sono chiesti se George W. Bush non avesse più ragione di quanto sembrava la storia avesse dimostrato, con la sua idea della promozione della democrazia. I rivali e gli oppositori dell’ex presidente americano hanno detto per anni che la democrazia non si può esportare, che deve nascere da sola, che bisogna essere pronti per la democrazia, e ci sono popolazioni che per ragioni storiche o culturali non lo sono ancora. Ma in questi giorni un possibile ripensamento è saltato agli occhi di Economist, Newsweek, Foreign Policy e Slate, che si sono chiesti se quello che è accaduto in Tunisia ed Egitto in qualche modo dia ragione a George W. Bush.
Quando fu eletto presidente degli Stati Uniti, nel 2000, George W. Bush era promotore di una dottrina di politica estera molto diversa e molto più isolazionista di quella globale che aveva condotto il suo predecessore, Bill Clinton. Durante la campagna elettorale, infatti, Bush aveva promesso di badare più agli interessi degli Stati Uniti che a quello che accadeva nel resto del mondo – criticava Clinton per aver fatto il contrario – e di abbandonare la dottrina del cosiddetto “interventismo umanitario” di Clinton a favore di un atteggiamento più concreto e realista.
Poi arrivò l’11 settembre, e tra le tante cose che travolse e cambiò ci fu anche la politica estera dell’amministrazione Bush. Una presidenza che nasceva ripiegata sui problemi degli Stati Uniti si trovò obbligata ad affrontare la sfida globale più pericolosa dalla fine della Guerra Fredda, e decise di affrontarla sposando una dottrina ben precisa: la promozione della democrazia. Nella convinzione che – parole di Bush – “per proteggere la libertà in America bisogna proteggere la libertà ovunque”, che non si poteva più “barattare la stabilità con la libertà”, che la democrazia avrebbe portato libertà, che la libertà avrebbe portato prosperità e laicità, e queste cose insieme avrebbero combattuto il terrorismo meglio di qualsiasi altra strategia. La tesi è di indubbio fascino ideale, si richiamava anche all’interventismo umanitario di Clinton e dei democratici, fu sposata dalla destra – i realisti mettevano l’accento sulla protezione degli interessi americani, gli idealisti sulla protezione degli ideali americani – ma guardata con interesse anche anche da pezzi della sinistra, seducendo intellettuali e giornalisti del calibro di Paul Berman e Christopher Hitchens.
Se si parla di esportazione della democrazia, oggi, la prima cosa a cui si pensa è sicuramente la guerra in Iraq. Non è un approccio del tutto preciso, ma è un’imprecisione che si deve soprattutto allo stesso Bush. Più che con la missione ideale della sovversione di una dittatura, nel 2003 quell’intervento fu infatti promosso sulla base di motivazioni molto realiste: la minaccia alla sicurezza nazionale rappresentata dalla presenza in Iraq di armi di distruzione di massa. Poi le armi di distruzione di massa non si trovarono – anche se qualcosina c’era, sappiamo oggi – e quindi Bush e i suoi alleati si affrettarono a spiegare perché, armi o non armi, deporre Saddam era stata una cosa buona in nome della libertà e della democrazia. Questo va detto non per riaprire il dibattito sulla guerra in Iraq, ma per dire che gli sforzi dell’amministrazione Bush nella promozione della democrazia vanno letti spostandosi su altri fronti. Prendiamo proprio l’Egitto, per esempio.
Nel dicembre del 2005 la Segretaria di Stato, Condoleeza Rice, aveva annullato una visita ufficiale in Egitto per protestare contro l’arresto del dissidente politico Ayman Nour. Rice andò in Egitto soltanto a giugno, dopo aver ottenuto il rilascio di Nour, e una volta al Cairo fece un discorso molto provocatorio nei confronti del regime di Mubarak. “Per sessant’anni”, disse, “in questa regione il mio paese ha cercato di ottenere stabilità a scapito della democrazia, finendo per non avere né l’una né l’altra. Ora abbiamo cambiato registro. Noi sosteniamo le aspirazioni democratiche di tutti i popoli. Presto arriverà il momento in cui la promessa di un mondo interamente libero e democratico, che si credeva impossibile, apparirà inevitabile. Signori e signore, in giro per il Medio Oriente milioni di cittadini chiedono libertà e democrazia. A questi uomini e queste donne così coraggiosi voglio dire: tutte le nazioni libere staranno dalla vostra parte”. Oltre ai discorsi arrivarono finanziamenti agli oppositori di Mubarak – non ai Fratelli Musulmani, ovviamente – in Egitto e in molte altre parti del mondo. Così la riassume l’Economist:
Bush è stato certamente un alfiere della democrazia molto più attivo di quanto è stato Obama finora. Obama si è insediato promettendo di “coinvolgere” i nemici degli Stati Uniti e ricostruire un rapporto proficuo col regime iraniano, a cui ha creduto al punto da dare un sostegno molto tiepido alla cosiddetta “rivoluzione verde” del 2009. Anche lui ha fatto un discorso al Cairo, nel 2009, ma per dire tra le altre cose che “gli Stati Uniti non pensano di sapere cosa è meglio per tutti”. Davanti alle sollevazioni popolari nel mondo arabo, chi prendeva in giro Bush sembra meno intelligente, mentre lui sembra più saggio.
È indubbio che la politica estera di Obama sia più votata alla stabilità di quella di Bush: che badi più agli interessi americani che agli ideali americani e che preferisca un approccio più dialogante e meno aggressivo nei confronti nei regimi dittatoriali. E lo fa non senza ragioni: l’interventismo dell’amministrazione Bush ha aumentato la diffidenza e l’odio del mondo arabo nei confronti degli Stati Uniti, invece che diminuirlo, permettendo così ai regimi di rinsaldare la loro tenuta brandendo la minaccia credibile di un possibile intervento americano. Gli Stati Uniti stanno tentando faticosamente di chiudere i due fronti di guerra in cui sono impegnati, e non vogliono aprirne altri. Le cose non sono semplici, insomma: una leva sblocca una situazione da una parte e ne complica un’altra da un’altra parte. E se probabilmente molti critici della dottrina Bush hanno liquidato frettolosamente idee che trovano origine nella migliore tradizione della sinistra liberale, è vero anche che sarebbe altrettanto sbrigativo e improprio sostenere che quanto accaduto in Tunisia ed Egitto sia merito della cosiddetta “freedom agenda” portata avanti dall’amministrazione Bush o di un ritardato “effetto domino”. Scrive così Fred Kaplan su Slate.
In fin dei conti, la “freedom agenda” è fallita perché nessuno ci ha creduto sul serio. Bush parlava di sostegno agli oppressi in ogni parte del mondo ma camminava mano nella mano con la monarchia saudita, accoglieva a braccia aperte il presidente cinese, teneva cene di stato in onore del presidente dell’Azerbaijan (quello che di recente ha ordinato il pestaggio di chi protestava contro l’ennesima elezione truccata).
A queste critiche si aggiungono quelle dell’Economist, secondo cui la dottrina Bush viveva su una contraddizione: l’idea che i leader arabi dovessero dare libertà ai loro cittadini ma allo stesso tempo proteggere gli interessi americani. Questa contraddizione ha limitato l’efficacia degli sforzi e delle pressioni degli Stati Uniti nei confronti dei regimi, che d’altra parte hanno approfittato della situazione, confidando nel fatto che Bush prima o poi avrebbe lasciato la presidenza e col suo addio sarebbero arrivati tempi più tranquilli. Non è andata così, ma quella contraddizione ora minaccia anche Obama ed è destinata a minacciare gli Stati Uniti finché questi vorranno essere contemporaneamente la più grande superpotenza ma anche un ambasciatore della democrazia, della libertà e dell’autodeterminazione. Le due cose – conclude ancora l’Economist – possono non andare d’accordo.