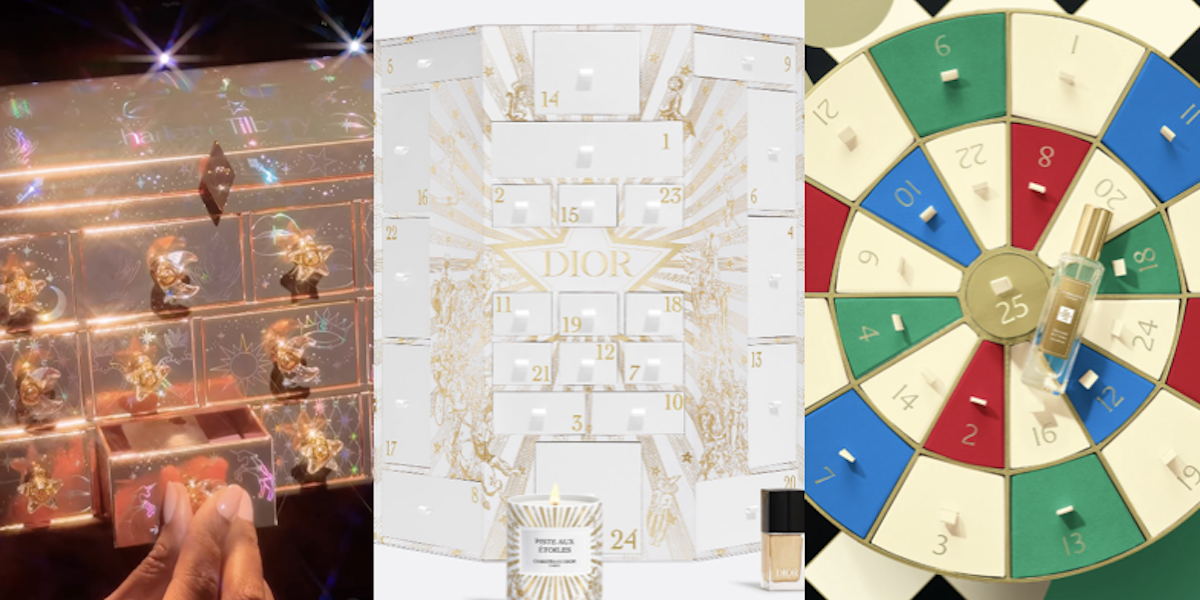Gorillaz, un po’ di rock’n’roll
Damon Albarn è "il più grande musicista della sua generazione"?
di Simona Siri

Damon Albarn è una rivincita. Mia, vostra, di tutti quelli, insomma, che sono cresciuti all’epoca della gloriosa stagione del brit pop e che in lui hanno sempre creduto. Adesso sembra persino troppo facile, ma allora – quindici anni fa, mica un secolo – sostenere che quel tipetto middle class che si schiariva il ciuffo con il succo di limone sarebbe diventato il più grande musicista della sua generazione sarebbe suonata come una enormità. Invece. L‘anno scorso è stata la reunion dei Blur, ovvero la band che è riuscita a diventare “i Rolling Stones degli anni zero” (definizione del Times) . Oggi sono i Gorillaz, il gruppo virtuale fondato assieme al fumettista Jamie Hewlett, nato come uno sfizio per intellettuali fighetti e trasformatosi – nel giro di tre dischi – in una band vera per suono, formazione e pezzi in repertorio. Lasciate perdere le venti milioni di copie vendute, le nomination ai Grammy Awards, il fatto che i Gorillaz abbiano ridefinito visivamente e musicalmente il pop contemporaneo. Tralasciate persino la notizia di qualche giorno fa, quella secondo la quale il nuovo disco sarà pronto prima di Natale, composto interamente da Albarn sul suo iPad durante le date del Plastic Beach Tour quello che i Gorillaz in formazione completa stanno portando in giro per il mondo. Chissenefrega. Sono i dettagli che contano. È la maglia rossa a righe nere con cui Damon si presenta sul palco a ogni concerto. È il suo sorriso senza un dente. È lo sguardo d’amore che rivolge a Mick Jones che sta lì, alla sua destra, e suona la chitarra vestito da capitano Stubing. È la complicità con Paul Simonon, l’uomo che sulla copertina di uno dei dischi più importanti della storia della musica – London Calling – spaccava il basso e che adesso si veste da marinaretto, le braghe calate, il basso senza cinghia.
Se hai più di 30 anni vedere Albarn, Jones e Simonon insieme sullo stesso palco è la cosa più stratosfericamente figa che ti possa capitare. Sono pezzi di vita che si rimettono a posto. Sono la possibilità di crescere con l’illusione di poter mantenere in un angolo della tua vita un po’ di rock’n’roll. Sono fili diversi tenuti insieme da quello che non è più solo un musicista, ma secondo L’Independent “l’equivalente moderno di un esploratore britannico del XIX secolo, gente che andava in giro per il mondo alla ricerca di culture diverse, laddove Albarn sembra costantemente attratto dai punti di contatto più che dalle differenze”.
In No distance left to run meraviglioso documentario uscito l’anno scorso che racconta la storia dei Blur Damon Albarn ad un certo punto dice: “I nostri dischi erano pieni di risentimento e cinismo, ma nessuno se ne è accorto, perché tutto allora doveva essere figo” . Lo dice parlando della stagione d’oro dei Blur, quella di Parklife e di The great Escape, della lotta con gli Oasis per il primato in classifica, della Cool Britannia e del New Labour di Tony Blair, con il quale Albarn non ha mai voluto avere niente a che fare tanto che nel 1997, quando il premier invita a Downing Street tutta la bella gente che stava facendo della Britannia un posto, appunto, di nuovo cool, lui gli fa recapitare un biglietto: “Spiacente, non vengo perché non sono più un sostenitore del New Labour. Sono diventato comunista. Divertitevi”.
La trasformazione di Damon Albarn da popstar di buona famiglia a “cultural globalist” (definizione sempre dell’Independent) avviene in quel momento, tra le macerie del brit pop, nella perdita di fiducia di un ideale sociale e politico, nella messa in discussione della mitologia stessa della englishness ovvero di cioè che aveva fatto dei Blur (e di Albarn) quello che i Blur (e Albarn) erano fino ad allora. Nasce così la collaborazione con il musicista africano Afel Bocoum (il risultato è il disco Mali Music), quella con il musicista cinese Zeng Zhen, l’idea di un’opera lirica in cinese, Monkey: Journey to the West, insomma tutto quello che fa sì che venga accostato a Ry Cooder, Brain Eno, Peter Gabriel. E nascono così anche i Gorillaz, musicalmente un mix di stili e gente diversa: solo nell’ultimo disco Plastic beach suonano Lou Reed, Snoop Dog, De La Soul, Mos def, Bobby Womack, l’intera orchestra nazionale libanese e due ex Clash. La perfetta chiusura del cerchio – anche simbolica: dalla campagna inglese a un’isola post atomica – per l’uomo che ha inventato il brit pop prendendo per il culo l’essenza stessa dell’essere inglesi: una vita fatta di case in campagna, di caccia alla volpe e di tè delle cinque. Anche perché – gli piaccia o meno – Albarn in questo momento rappresenta più di ogni altro quello che per noi – che la vediamo da qua e che con quella siamo cresciuti – è la musica inglese. Che è fatta sì di suoni – quello che ha sempre collegato i Blur ai Kinks e ai Beatles – ma anche e soprattutto di attitudine, di rock nel dna, di talento innato nel mischiare le carte, l’alto e il basso, i bambini di mille colori nello stesso asilo, l’integrazione quella vera, andare all’Opera in jeans e scarpe da ginnastica, essere posh e punk allo stesso tempo, frequentare i gentlemen’s club e i puzzolenti pub all’angolo.
L’anno scorso, per dire, il Times ha dato questa definizione di Albarn: “the essence of the British bloke” che tradotto liberamente significa incarnare l’essenza stessa della mascolinità britannica. Ancora prima, nel 2000, un istituto inglese fece una ricerca – commissionata dall’etichetta discografica – per capire se il momento era propizio all’uscita di un best of dei Blur. I risultati dimostrarono che la prima cosa a cui la gente pensava sentendo le parole “Music” e “England” erano gli occhi azzurri di Damon Albarn. Non sarebbe meraviglioso, invece delle tazze con la faccia della Regina Elisabetta e in attesa di quelle con il principe William e la futura sposa borghese Kate, avere quelle con Damon Albarn come simbolo supremo di orgoglio britannico? Sua Altezza, la prego, ci pensi e ci faccia sapere.