I segreti di Maxwell Sim
È uscito il nuovo romanzo di Jonathan Coe, ve ne proponiamo otto pagine

Quindici anni fa la scrittura leggera e spiritosa di Jonathan Coe, e la sua capacità di raccontare personaggi e sentimenti moderni, molto inglesi, lo fece diventare lo scrittore del momento e gli guadagnò un gran culto. Erano i tempi de La famiglia Winshaw, e poi de La casa del sonno. C’erano lui e Nick Hornby, a eccitare i lettori curiosi delle cose britanniche. Poi ha scritto ancora altri libri divertenti, ma senza rinnovarsi molto, e forse sono anche cambiati i tempi: La banda dei brocchi, Circolo chiuso, La pioggia prima che cada.
Adesso è uscito il suo nuovo libro, I terribili segreti di Maxwell Sim, edito ancora da Feltrinelli. Fatevene un’idea.
Due ore dopo, verso le quattro e mezzo del pomeriggio, ora di Sydney, stavo bevendo il mio secondo bicchiere di champagne, in attesa del decollo, contemplando i piaceri del viaggio che mi aspettava. Avevo un posto vicino al corridoio; quello di fianco a me, accanto al finestrino, al momento era ancora vuoto. I sedili erano larghi e ben imbottiti, e avevo un sacco di spazio per le gambe. Provai un piacere quasi sensuale al pensiero dei lussi che potevo aspettarmi. Tredici ore fino a Singapore: la cena, innaffiata da alcuni bicchieri di champagne, più di cinquecento film e spettacoli televisivi in attesa per me sulla consolle d’intrattenimento, e forse un sonnellino da qualche parte
lungo il tragitto. Poi un paio d’ore di scalo all’aeroporto di Singapore, la sistemazione su un altro aereo, un whisky abbondante, un paio di sonniferi, e mi sarei spento come una lampadina fino all’arrivo a Heathrow, il mattino dopo. Non poteva andarmi meglio.
Almeno così avrebbe dovuto andare. Il problema, come ho detto, era che vedere la donna cinese e la figlia la sera prima aveva inaspettatamente risvegliato il mio bisogno di contatto umano. Volevo parlare. Lo desideravo con tutte le mie forze.
Nessuna sorpresa, dunque, che quando un uomo d’affari pallido e sovrappeso, con un leggero completo grigio, si strizzò contro le mie gambe con un vaghissimo cenno di scuse e si sistemò sul sedile accanto al finestrino, provassi un bisogno insopprimibile di trascinarlo in una conversazione. Era un bisogno mal indirizzato, devo ammettere. Se la mia esperienza di venditore mi aveva insegnato qualcosa, dopo tanti anni, era a leggere i volti delle persone, per cui avrebbe dovuto risultarmi evidente che questo sconosciuto riservato e dall’aria diffidente non era molto interessato a parlare con me, e avrebbe preferito di gran lunga essere lasciato in pace con i suoi giornali e il suo computer. Ma la verità, suppongo, è che l’avevo capito perfettamente, ma scelsi di ignorarlo.
L’uomo d’affari ci mise un paio di minuti a mettersi comodo sulla sua poltrona. Una volta sistemato, si rese conto di
aver lasciato il computer in una custodia dentro la cappelliera, per cui dovette alzarsi di nuovo e ci furono altri tira e molla un po’ansimanti prima che entrambi tornassimo a sederci ai nostri posti. Allora lui aprì il suo portatile e cominciò a battere furiosamente sui tasti. Dopo circa cinque minuti, smise di digitare, rilesse rapidamente le parole sullo schermo, premette un tasto con gesto deciso, quasi teatrale, poi sospirò e si rilassò contro lo schienale, ansimando leggermente mentre il computer si spegneva. Girò la testa verso di me, senza guardarmi direttamente; ma il gesto fu sufficiente. Lo presi come un invito a lanciarmi nella conversazione, anche se lui non lo aveva inteso così.
“Tutto fatto?” dissi.
Lui mi lanciò un’occhiata inespressiva, palesemente sorpreso di essere stato interpellato. Per un attimo pensai che
non avrebbe detto niente, ma poi riuscì ad articolare uno striminzito:
“Mmh… mmh”.
“E-mail dell’ultimo minuto?” azzardai.
“Già.”
L’accento sembrava australiano, anche se era difficile stabilirlo basandosi solo su un “Mmh… mmh”e un “Già”.
“Sa cosa mi piace degli aerei?”continuai imperterrito. “Sono l’ultimo posto che ci rimane in cui possiamo essere totalmente irraggiungibili. Totalmente liberi. Nessuno può telefonarti o mandarti un sms su un aereo. Una volta che sei in aria, nessuno può spedirti un’e-mail. Almeno per qualche ora, sei lontano da tutto questo.”
“È vero,”disse l’uomo. “Ma non per molto, ancora. Ci sono già alcune linee aeree che consentono di inviare la posta e navigare in rete sul proprio computer anche in volo. E pare che presto permetteranno l’uso dei cellulari. Personalmente, quello che a lei piace dei voli in aereo è esattamente la cosa che io detesto. È tempo morto. Completamente morto.”
“Non proprio,”dissi. “Significa solo che, se vuoi comunicare con qualcuno durante un volo, devi farlo direttamente. Cioè parlando, capisce? È un’occasione per conoscere altra gente. Gente nuova.”
Mentre lo dicevo, lui mi guardò. Qualcosa nella sua occhiata mi disse che fare la mia conoscenza era una chance che si sarebbe lasciato sfuggire senza l’ombra di un rimpianto. Ma il secco rifiuto che mi aspettavo non arrivò. Invece, mi tese la mano e disse bruscamente:
“Mi chiamo Charles. Charles Hayward. Gli amici mi chiamano Charlie”.
“Maxwell,”risposi. “Max, per abbreviare. Maxwell Sim. Sim, come l’attore.”Lo dicevo sempre quando mi presenta-
vo, ma di solito, a meno che non stessi parlando con un inglese di una certa età, il riferimento cadeva nel vuoto e dovevo aggiungere: “Oppure Sim, come in Sim card”.
“Piacere di conoscerla, Max,” disse Charlie; poi prese il giornale, si girò e si mise a leggerlo, iniziando dalle pagine finanziarie.
Eh no, non va bene. Non si può star seduti vicino a qualcuno per tredici ore filate e ignorarlo completamente, vi pare? Non tredici ore in realtà, ma ventiquattro –perché avevo notato dalla carta d’imbarco sul suo tavolino che Charlie e io saremmo stati vicini anche nella seconda tratta del volo. Semplicemente, sarebbe stato disumano starsene seduti in silenzio per tutto quel tempo. Però ero sicuro che, se mi fossi impegnato a fondo, sarei riuscito a farlo uscire dal suo guscio. Adesso che ci eravamo scambiati qualche parola, mi accorsi che non era poco amichevole in sé e per sé, solo parecchio stanco e stressato dal lavoro. Doveva essere sui cinquantacinque anni, e durante la cena mi raccontò che era cresciuto a Brisbane e ora occupava una posizione di rilievo nella sede di Sydney di una multinazionale che stava accusando qualche difficoltà finanziaria. Suppongo fosse questo il motivo per cui non viaggiava in Business class. Era diretto a Londra per consultarsi sulla crisi con alcuni degli altri dirigenti: naturalmente, non specificò quali fossero le difficoltà finanziarie (perché avrebbe dovuto dirlo proprio a me?), ma a quanto pareva era tutto legato al leverage, o leva finanziaria che dir si voglia. La sua compagnia aveva acquisito dei mutui che erano troppo o troppo poco a leva, o qualcosa del genere. A un certo punto, cercando di spiegarmelo cominciò ad animarsi, e pensai che ci fosse una possibilità che diventasse davvero loquace, ma quando si rese conto che non sapevo niente di leverage e di derivati e non avevo una conoscenza reale di nessuno strumento finanziario più complicato di uno scoperto bancario o di un conto di deposito, parve perdere ogni interesse nella mia persona, e da quel momento divenne sempre più difficile ottenere da lui qualcosa di più di qualche parola smozzicata.
Non fu di alcun aiuto che cenando avesse bevuto parecchi bicchieri di champagne e non so più quante birre, anzi cominciava ad avere un’aria ancor più sfinita di prima. L’altro problema era che più lui diventava taciturno, più io parlavo e, come se fossi terrorizzato dalla possibilità del silenzio tra noi, cominciai io a diventare loquace, logorroico persino, e pensai bene di sommergere la mia nuova conoscenza sotto una valanga di confessioni e confidenze che –ne sono sicuro – dovettero sembrargli noiose, se non imbarazzanti.
Tutto cominciò quando gli dissi: “Lei è così fortunato a vivere a Sydney. Che città straordinaria. Così diversa da do-
ve vivo io…”.
Ci fu un breve silenzio, che alla fine lui ruppe con la doverosa domanda: “Ma lei non vive a Londra, allora?”.
“No, non proprio a Londra. A Watford.”
“Ah, Watford,”disse lui. Era difficile capire che valenza attribuisse alla parola, se esprimeva curiosità, disprezzo o qualcos’altro.
“È mai stato a Watford?”
Lui scosse la testa. “No, non credo proprio. Sono stato in alcune grandi città. Parigi. New York. Buenos Aires. Roma.
Mosca. Ma mai a Watford.”
“C’è parecchio da dire su Watford,”proseguii con un tono lievemente difensivo. “Non molti sanno che è gemellata
con Pesaro, una città italiana assolutamente deliziosa, sulla costa adriatica.”
“Sono sicuro che sia un matrimonio paradisiaco.”
“Sa,”continuai, “a volte me lo chiedo anch’io come ci sono finito a Watford. Io sono di Birmingham, capisce. Sup-
pongo sia capitato perché qualche anno fa ho avuto questo lavoro per una ditta di giocattoli, stanziata a St. Albans, e Watford è molto vicina, come lei forse saprà. O forse no. Comunque, le due cittadine sono a un tiro di schioppo. Non potrebbe essere più 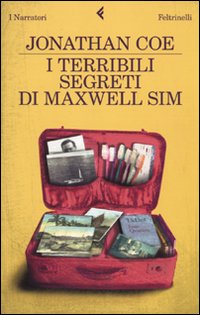 comodo, mi creda, se le capitasse di dover andare da una all’altra. C’è da dire che ho smesso di lavorare per quella ditta poco dopo essermi trasferito a Watford, il che è una bella ironia, a pensarci bene, perché poi ho cominciato a lavorare per un grande magazzino di Ealing, che di fatto è più lontana da Watford di quanto lo sia St. Albans. Non moltopiù lontana però, solo qualcosa come… diciamo dieci o quindici minuti, se ci vai in macchina. Cosa che di solito facevo, perché è piuttosto difficile viaggiare da Watford a Ealing coi trasporti pubblici, sorprendentemente difficile, a ben pensarci. Ma di sicuro non mi pento di aver accettato quel lavoro –a Ealing intendo –per- ché è lì che ho conosciuto mia moglie, Caroline. Anzi, la mia ex moglie, tra non molto, suppongo, perché ci siamo separati qualche mese fa. Dico separati, ma la verità è che un bel giorno lei mi ha detto che non voleva più stare con me. Niente da dire, per carità, è un suo diritto, e bisogna rispettare questo tipo di decisioni, è naturale, e lei… be’, lei è molto felice adesso, sta con nostra figlia Lucy, su al Nord dove si sono trasferite, e sembrano contente di star lì, perché per qualche ragione, non so bene quale, Caroline non si è mai ambientata a Watford, non sembrava mai del tutto felice lì, e secondo me è un peccato perché, come si suol dire, si può sempre trovare qualcosa di buono in qualsiasi posto, non crede?
comodo, mi creda, se le capitasse di dover andare da una all’altra. C’è da dire che ho smesso di lavorare per quella ditta poco dopo essermi trasferito a Watford, il che è una bella ironia, a pensarci bene, perché poi ho cominciato a lavorare per un grande magazzino di Ealing, che di fatto è più lontana da Watford di quanto lo sia St. Albans. Non moltopiù lontana però, solo qualcosa come… diciamo dieci o quindici minuti, se ci vai in macchina. Cosa che di solito facevo, perché è piuttosto difficile viaggiare da Watford a Ealing coi trasporti pubblici, sorprendentemente difficile, a ben pensarci. Ma di sicuro non mi pento di aver accettato quel lavoro –a Ealing intendo –per- ché è lì che ho conosciuto mia moglie, Caroline. Anzi, la mia ex moglie, tra non molto, suppongo, perché ci siamo separati qualche mese fa. Dico separati, ma la verità è che un bel giorno lei mi ha detto che non voleva più stare con me. Niente da dire, per carità, è un suo diritto, e bisogna rispettare questo tipo di decisioni, è naturale, e lei… be’, lei è molto felice adesso, sta con nostra figlia Lucy, su al Nord dove si sono trasferite, e sembrano contente di star lì, perché per qualche ragione, non so bene quale, Caroline non si è mai ambientata a Watford, non sembrava mai del tutto felice lì, e secondo me è un peccato perché, come si suol dire, si può sempre trovare qualcosa di buono in qualsiasi posto, non crede?
Con questo non voglio dire che se vivi a Watford ti svegli tutte le mattine e ti dici: Oddio, forse la vita è un po’ uno schifo, ma guarda il lato positivo, se non altro sei a Watford, insomma non è che Watford sia un posto tale per cui il fatto stesso di vivere lì ti dia un motivo per continuarea vivere, no, questa sarebbe una forzatura. Watford non è quel tipo di posto, però ha una biblioteca eccellente, per esempio, e ha anche l’Harlequin, che è un nuovo centro commerciale con alcuni negozi fantastici, sì, davvero fantastici e c’è anche –adesso che ci penso la cosa la divertirà davvero –cioè…”vedendo la sua espressione gelida non ne ero più così sicuro “…forse la troverà divertente, allora dicevo, c’è anche il Walkabout, che è un grande bar a tema, direi, che ha una grossa insegna che promette di offrirti ‘Il Maestoso Spirito dell’Australia’ anche se, pensandoci bene, quando sei lì dentro non hai mai l’impressione di essere in Australia, non ti dimentichi mai veramente che sei a Watford, per essere del tutto onesti, ma se sei come me, e ti piace comunque vivere a Watford, che male c’è?, insomma, certa gente è felice di quello che si ritrova e non ci vedo niente di sbagliato in questo, cioè, non voglio dire che sia sempre stata una mia ambizione vivere a Watford,
non ricordo che mio padre mi abbia mai fatto sedere sulle sue ginocchia e mi abbia chiesto: Figliolo, hai mai pensato a cosa vuoi fare da grande?, e io gli abbia risposto: Sai, papà, non me ne importa molto, purché io riesca a vivere a Watford –non ricordo nessuna circostanza del genere, è vero, d’altronde, tanto per cominciare, mio padre non era proprio quel genere di persona, non mi ha mai preso sulle ginocchia, per quel che ricordo, non è mai stato molto portato al contatto fisico, o affettuoso, o molto… presente nella mia vita, non in modo significativo almeno, fin dall’età di circa –bah, fin da quando mi ricordo, suppongo –comunque, quello che voglio dire è che, anche se Watford non è il genere di posto in cui sogni di andare ad abitare per tutta la vita, non è nemmeno il genere di posto da cui non vedi l’ora di andartene, però devo dire che qualche anno fa ho avuto una conversazione in proposito con il mio amico Trevor, Trevor Paige, che è uno dei miei più vecchi amici a dire il vero, ci conosciamo fin dagli anni novanta, quando facevo ancora il rappresentante per la ditta di giocattoli di cui le parlavo prima, lui copriva l’Essex e la costa orientale, e io facevo Londra e le sei contee circostanti, ma io quel lavoro l’ho lasciato dopo un paio d’anni, come le dicevo, per un posto in questo grande magazzino di Ealing, mentre Trevor ha continuato a farlo, capisce, e noi siamo rimasti amici, soprattutto perché abitavamo a due isolati di distanza a Watford, almeno fino a due anni fa, perché circa due anni fa, mentre ci facevamo un bicchiere insieme allo Yates’s Wine Lodge del quartiere, di punto in bianco lui mi fa: Sai una cosa, Max? Sono stufo marcio, sì, ne ho proprio le palle piene, e io gli ho detto: Ne hai le palle piene? E di cosa? E lui ha detto: Di Watford.
Di Watford? ho detto io, e lui ha insistito: Sì, ne ho le palle piene di Watford, ne ho fin sopra i capelli di Watford, sono diciotto anni che abito a Watford e per essere franchi penso di aver visto tutto quello che Watford può offrire e posso dire in tutta onestà che Watford non ha più nessuna gioia o sorpresa in serbo per me e, per dirla tutta, sono sicuro che se non me ne vado al più presto finirò per ammazzarmi o morire di noia o di frustrazione o non so cosa, e devo dire che per me è stata una grossa sorpresa, perché avevo sempre pensato che Watford andasse a pennello a Trevor e Janice –Janice è il nome di sua moglie –, anzi, era una delle cose che io e Trevor avevamo sempre avuto in comune, il fatto che avevamo un debole per Watford, anzi, che eravamo entrambi innamorati di Watford, capisce, molti dei nostri ricordi più cari… momenti condivisi della nostra amicizia erano legati a Watford, come per esempio il fatto che ci eravamo sposati a Watford e che i nostri figli erano nati a Watford, e per la verità pensavo che Trevor fosse un po’fuori di testa quella sera e che a parlare non fosse lui ma l’alcol, e ricordo di aver pensato tra me: No, Trevor non lascerà mai Watford… tra il dire e il fare…, comunque pensavo che non avrebbe fatto niente, e invece devo ammettere che Trevor aveva più risorse di quanto pensassi e il suo non era stato uno sfogo passeggero, voleva davvero darci un taglio con Watford e così ha fatto, tanto che sei mesi dopo lui e Janice si sono trasferiti a Reading, dove ha trovato questo nuovo lavoro –che a occhio e croce sembra un ottimo lavoro –con una ditta che fabbrica spazzolini da denti, o li importa, credo che li importino dall’estero ma li distribuiscono in tutto il Regno Unito, e non degli spazzolini normali, ma spazzolini da denti per specialisti, con un design molto innovativo, capisce, e anche il filo interdentale e il collutorio e altri prodotti per l’igiene orale, che stanno andando forte sul mercato… Come, scusi?”
Mi accorsi che qualcuno mi stava dando dei colpetti sulla spalla. Mi girai e vidi che era una delle hostess.
“Signore?”disse. “Signore, dobbiamo parlare con lei, del suo amico.”
“Il mio amico?”
Sulle prime non capii a chi si riferissero. Poi mi resi conto che doveva trattarsi di Charlie Hayward.
C’era un’altra hostess accanto alla prima, e un assistente di volo maschio. Non avevano l’aria felice. Ricordai che c’era stato un po’di trambusto qualche minuto prima, quando uno di loro era venuto a ritirare il vassoio di Charlie, ma io ero tutto preso dalla mia conversazione e non ci avevo badato.
In ogni caso, come non tardarono a informarmi, era impossibile stabilire il momento esatto –non finché non avessero scoperto se c’era un medico a bordo –ma, a quanto pareva, Charlie era morto da almeno cinque o dieci minuti.
Di infarto, naturalmente. Di solito si tratta di infarto.





