Avanti, a passi sempre un po’ più corti
Modern Times (2006)
(Il disco precedente: “Love and Theft”;
il disco successivo: Tell Tale Signs…)

Alicia Keys. Vi spiegherò poi.
Avete notato come passa alla svelta il tempo ultimamente? Roba che ormai ti addormenti in autunno ti risvegli in primavera. Oppure, non so, inviti una ragazza a cena ma passi a prenderla un po’ in ritardo e lei nel frattempo si è sposata e ha avuto tre figli uno dei quali vuole fare il liceo scientifico, io che ne penso? Penso che me l’avevano pur detto, che il tempo funzionava così. Pare sia una questione percettiva, abbastanza elementare se ci rifletti.
Quando compi un anno di vita, tutta la vita è in quell’anno; ma poi ne compi un altro e ti sembra un periodo lunghissimo, addirittura la metà della tua vita. E già pensi che ti aspetta un altro anno, ma quando arriva è soltanto un terzo della tua vita (che per carità, è ancora parecchio). Ma insomma, ogni anno che passa, passa più alla svelta: e per quanti anni metti assieme, la somma di tutti gli anni dopo il primo non durerà mai quanto il primo. La funzione insomma è y=x/1+x/2+x/3+x/4+x/5 eccetera, c’è senz’altro un modo più elegante ed esauriente di scriverla ma non ho fatto lo scientifico. La cosa interessante è che quando arrivi a x/65 – l’età di Dylan quando incise Modern Times, in realtà devi ancora arrivare al quinto anno di età percepita. Roba da matti.
 Infatti secondo me ho fatto un errore. Eppure il ragionamento spiegherebbe perfettamente il perché a un certo punto oltrepassi una specie di soglia dopo la quale gli anni passano talmente alla svelta che non li riconosci più. C’entra anche il modo in cui ti tratta la vita: fino a vent’anni puoi provare a cambiare spesso i partner, o la città, o la professione, ma a un certo punto fatalmente rimani incastrato in una famiglia e/o una città e/o un ufficio, e da lì in poi certe cose come, che so, fare la spesa, assumono una ritualità ipnotica: se all’Esselunga ogni tanto non cambiano il posto ai prodotti degli scaffali, tu sul serio certe volte non ti ricordi più se quei cetriolini li hai comprati la settimana scorsa o dieci anni fa. Oppure entri in un bar e il cameriere ti serve senza chiederti niente, ma come si permette, poi fai due calcoli e sono già cinque anni che entri e chiedi la stessa cosa, cinque rapidissimi anni, perché in realtà per te ne sono passati appena (1/35+1/36+1/37+1/38+1/39)=0,13. Cioè quando dici che ti sembra ieri che inauguravano il locale, dal tuo punto di vista hai ragione (è che il tuo punto di vista sta accelerando man mano che muori).
Infatti secondo me ho fatto un errore. Eppure il ragionamento spiegherebbe perfettamente il perché a un certo punto oltrepassi una specie di soglia dopo la quale gli anni passano talmente alla svelta che non li riconosci più. C’entra anche il modo in cui ti tratta la vita: fino a vent’anni puoi provare a cambiare spesso i partner, o la città, o la professione, ma a un certo punto fatalmente rimani incastrato in una famiglia e/o una città e/o un ufficio, e da lì in poi certe cose come, che so, fare la spesa, assumono una ritualità ipnotica: se all’Esselunga ogni tanto non cambiano il posto ai prodotti degli scaffali, tu sul serio certe volte non ti ricordi più se quei cetriolini li hai comprati la settimana scorsa o dieci anni fa. Oppure entri in un bar e il cameriere ti serve senza chiederti niente, ma come si permette, poi fai due calcoli e sono già cinque anni che entri e chiedi la stessa cosa, cinque rapidissimi anni, perché in realtà per te ne sono passati appena (1/35+1/36+1/37+1/38+1/39)=0,13. Cioè quando dici che ti sembra ieri che inauguravano il locale, dal tuo punto di vista hai ragione (è che il tuo punto di vista sta accelerando man mano che muori).
Lo avevo sempre saputo che sarebbe finita così, ma per qualche motivo ero convinto che l’avrei gestita meglio degli altri. Per esempio: scriverò una pagina tutti i giorni per tutta la mia vita. Quando mi chiederanno, dove hai messo il tuo tempo? Eccolo qua. E non si sgarra, vedrete che ogni anno sarà più o meno di trecento pagine. Che ingenuo, vero? Beh, l’ho fatto sul serio. Meno male che hanno inventato i blog, sennò ormai mi ritroverei in soggiorno una pila di manoscritti che mi accuserebbero: “dove hai messo il tuo tempo?” E, indovinate? Ogni pagina è come se fosse un po’ meno importante della precedente. Per esempio: cosa facevo nel febbraio del 2006, mentre Bob Dylan incideva Modern Times (sembra ieri e infatti è successo 11 anni fa)? Voi non vi ricordate di cosa stavate discutendo nel febbraio del 2006. Io sì, io ho l’archivio on line. Io infatti stavo discutendo… delle vignette satiriche di Charlie Hebdo su Maometto.
No, aspetta
Sono passati già undici anni?
Dio mio.
Ma parliamo di Dylan. Ha appena ottenuto una nomination ai Grammy – beh, ne ha già vinti dodici, di cui uno alla carriera. Ultimamente lo candidano nella categoria “Miglior album pop tradizionale”, che come ci spiega l’eminente Madeddu non è un campo qualsiasi, ma il teatro di una logorante guerra di posizione tra Tony Bennett e Michael Bublé. Che ci fa Dylan tra questi crooner, questi interpreti confidenziali? Diciamo che la cosa non ci sorprende più. Forse ci avrebbe ancora sorpreso l’altro ieri – ovvero nel 2006, quando uscì Modern Times.

Tony Bennett
Una cosa dovete riconoscere al signor Dylan: non ha mai voluto incidere lo stesso disco due volte. Diciamo *quasi* mai. Persino quando aveva a disposizione solo una chitarra e un’armonica, ogni disco era il segnale che il tempo stava cambiando. The Freewheelin’ non assomigliava a The Times They Are A-changin’ che non assomigliava ad Another Side. Solo verso gli anni Ottanta le sue difficoltà in studio lo hanno portato un po’ a ripetersi: ma persino Saved non assomigliava a Slow Train Coming; persino Knocked Out Loaded, che è pure fatto con gli avanzi di Empire Burlesque, in qualche miracoloso modo è già un disco diverso. Per quanto la gente continuasse a pensare a lui principalmente come al menestrello delle foto in bianco e nero, o il rocker d’avanguardia in occhiali scuri – tutti ricordi risalenti ai suoi pochi, primi, lunghissimi anni – Dylan ha combattuto l’accelerazione del tempo con tutte le sue forze, continuando a cambiare pelle a ogni disco. Questo forse per lui era più importante che la qualità – posso capirlo. Immagino che trovare un seguito a The Freewheelin’ debba essere dura, ma quando invece hai fatto trenta dischi, è così importante se il trentunesimo è un capolavoro o è inascoltabile? Smetterai di essere il grande Bob Dylan, se capita che sia un brutto disco? E se invece è buono, qualcuno oserà metterlo sullo stesso piano di Blonde On Blonde e di quei dischi che hai inciso in fretta e quasi per caso da giovane, quando gli anni non finivano mai e succedeva qualcosa di diverso tutti i giorni?

Michael Bublé
Modern Times è il 32esimo disco di studio di Bob Dylan, e com’è? È buono. Buono come “Love and Theft“? Più o meno. Buono come Highway 61? In teoria si potrebbero mettere sullo stesso piano – se potessimo avere un punto di vista fuori dal tempo, e magari tra uno o due secoli un ascoltatore ce l’avrà. Per adesso è come paragonare una stella di media grandezza al big bang. La cosa più notevole è che almeno per una buona metà Modern Times suona quasi identico al precedente, di cui ricalca la struttura (un brano rockabilly, uno swing, di nuovo un rockabilly, ecc.): il che non è poi sorprendente per un tizio che ha già stampato trentadue dischi (i Rolling Stones hanno cominciato a cristallizzarsi trent’anni prima) ma lo è per Dylan. Soprattutto se pensiamo che tra i due dischi ci sono cinque anni: un’eternità.

Rolling Stones
È lo stesso tempo che separa il suo disco d’esordio da John Wesley Harding. Quante pelli Dylan aveva già cambiato tra 1962 e 1967? Tra 2002 e 2007, Dylan sembra congelato. E invece si stava dando parecchio da fare: nel 2004 pubblica il primo e per ora unico volume della suona biografia, Chronicles I. Nello stesso periodo assiste (per la verità in modo abbastanza distante) alla lavorazione del documentario di Scorsese, No Direction Home; nel frattempo i negozi di dischi vengono riforniti regolarmente di nuove uscite della sua Bootleg Series. Sono insomma anni in cui Dylan sta lavorando molto sul suo passato: lo corregge, in certi casi lo stravolge, inserisce dettagli che mai ci saremmo aspettati… ad esempio scopriamo con Chronicles che a lui i grandi standard jazz sono sempre piaciuti, e che quando nel 1970 tutti lo aspettavano sulle barricate, lui andava con Sara a sentire un concerto di Sinatra Jr. Ma non è sempre stato così con lui? Quando passò al rock, non si premurò di informarci che aveva sempre sognato di suonare il rock? E il country? Non era la musica che aveva sempre sognato di fare prima di riuscirci con Nashville Skyline? Dylan è sempre fedele al suo passato, che però può modificare quando e come vuole.

Dylan qualche anno (giorno) dopo.
Accanto a questa incessante opera di revisionismo storico, c’è una vita quotidiana fatta soprattutto di concerti: più o meno ottanta all’anno, in Europa, Asia e soprattutto America. Forse Dylan ha avuto un’idea migliore della mia: quando ha capito che fare un disco all’anno non avrebbe fermato il tempo, ha deciso di svegliarsi ogni mattina in un albergo diverso. Magari il Tour Infinito è il suo modo di fermare l’istante. Che dire: beato lui. In albergo, tra una data e l’altra, trova anche il tempo di registrare il suo “Theme Time Radio Hour”, un programma radiofonico che comincerà nel 2006 e andrà avanti fino al 2009. Un’ora di trasmissione, una dozzina di vecchie canzoni collegate dallo stesso argomento, e tra un pezzo e l’altro la voce di Dylan che si atteggia a vecchio dj notturno – quel caldo timbro sussurrato delle vecchie FM.

Charlton Heston, Bob Dylan e Lauren Bacall premiati dal presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e sua moglie Hillary alla Casa Bianca
(JAMAL WILSON/AFP/Getty Images)
Forse la cristallizzazione di cui parliamo prima dipende proprio dal modo in cui Dylan ha cominciato a gestire la sua vita: non ci sono più fratture, soluzioni di continuità, crisi e ritorni. La sua stessa voce, che in tanti brani dei due dischi precedenti sembrava ingaggiare una lotta contro le tonsille, ora gli esce senza più apparente fatica. E i musicisti? Li cambia un po’ per volta, come pezzi di una barca che non cambia fisionomia: per esempio in Modern Times non ci sono più Charlie Sexton alla chitarra e Augie Meyers alla tastiera, che pure sembravano così importanti per il sound di “Love and Theft” – però la sezione ritmica è la stessa. Il motivo per cui Modern Times forse nel 2006 ci sembrò meno interessante del precedente, è che non aggiungeva quasi nulla, e non sorprendeva più: infili il cd, premi play, senti gli strumenti che è come se si accordassero, e sai già che stanno per intonare un rockabilly felpato. Infatti comincia una specie di Johnny B. Goode per la terza età, Thunder on the Mountain, con un testo un po’ apocalittico, un po’ sapienziale, un po’ fatti suoi che Dylan comunque sa raccontare senza annoiarti, che è il massimo che ti puoi aspettare da un sessantenne, no?
Stavo pensando ad Alicia Keys, non riuscivo a smettere di piangere
Quando è nata a Hell’s Kitchen, io vivevo un po’ più a sud.
Mi domando dove potrebbe essere adesso Alicia Keys:
L’ho cercata persino in mezzo al Tennessee.

Alicia Keys
Alicia Keys è nata nel… – maledetto Dylan, non avrei mai dovuto controllare – dicevo che Alicia Keys è classe 1981. Quarant’anni giusti di differenza. Ovviamente i giornalisti gliene chiesero subito conto: lui non si ricordava nemmeno quando l’avesse incontrata, sicuramente a un Grammy (la Keys ne ha vinti due o tre più di Dylan). “L’ho vista e mi sono detto: non c’è niente in quella ragazza che non mi piace”. Vuoi vedere che da qualche parte dentro quel rudere c’è ancora il ragazzino che dedicò Tarantula ad Aretha Franklin? Se proprio vogliamo trovare una differenza, Dylan coi testi di Modern Times si espone più del solito. In Time Out of Mind sembrava legato alle passioni terrene soltanto da un filo doppio di rimpianto; in “Love and Theft” si nascondeva dietro maschere e specchi distorti: anche quando sembrava deluso o arrabbiato, tradiva un sorriso. Ora, a 61 anni suonati Dylan sembra aver perso la voglia di truccarsi: sì, a volte si innamora, a volte si incazza, a volte beve ancora, a volte, mah, vorrebbe… armare un esercito di orfani?
Armerò un esercito di figli di puttana;
li andrò a recrutare negli orfanotrofi.
Sono stato a Sant’Herman e ho fatto i miei voti,
ho succhiato il latte di un migliaio di vacche.
(Sant’Herman è il monaco ortodosso che portò il vangelo in Alaska). Anche al termine di Thunder sai cosa aspettarti: un lento, magari un po’ jazzato. Parte infatti Spirit on the Water, sette minuti di uno swing che somiglia a tutti gli swing del mondo e a nessuno – sul serio, chi è che li suona così alla buona, una specie di garage-swing? chi li scrive così lunghi e sconsolati, infilandoci tutta la malinconia disadorna del blues? “Vorrei andare su in paradiso con te, ma non succederà, perché ho ucciso un uomo qua sotto”. Di chi sta parlando? Ed ecco che riparte il rock – Rollin’ and Tumblin’ è uno di quei brani che tutti suonano (Muddy Waters tra gli altri) e nessuno sa esattamente chi lo ha inventato – figurati se Dylan ha tempo da perdere a cercare l’autore. Sul libretto c’è scritto soltanto: tutti i testi e le musiche di Bob Dylan. Ed è di nuovo il momento del lento. Ma When the Deal Goes Down è un po’ più ovattata del solito e ci fa intravedere una direzione: dallo swing fatto-in-casa di “Love and Theft”, Dylan sta proseguendo a passo sempre più rallentato.

Però, sul serio, perché continuare con le foto di vecchioni quando posso inserire foto di Alicia Keys.
Verso dove? Forse nel 2006 non ci era ancora chiaro, mentre oggi è fin troppo facile: verso i crooner, i cantanti confidenziali. Verso Bublé, Bennett, Sinatra. In Chronicles ci aveva pure avvertito: è musica che avrei sempre voluto fare. Nel 1970, quando tentò Blue Moon, la gente era convinta che stesse scherzando. Ma Self Portrait forse doveva intitolarsi proprio Blue Moon. Ok, a questo punto ci aspettiamo un blues – con Some Day Baby Dylan vinse un altro Grammy per la “migliore performance solista rock”. Chi si accorse subito che in realtà si trattava di una cover di Troubles No More di Muddy Waters, in realtà conosceva soltanto parte della storia: anche Waters aveva ripreso un blues rancoroso degli anni Trenta che si chiamava proprio Some Day Baby. Dylan risistema il testo ma non lo edulcora; lo canta con garbo perché ormai è troppo vecchio per sputare frasi con veemenza, ma in questo modo lo rende un più inquietante. Ho cercato di essere amichevole, di essere gentile; ora ti porterò via da casa come io fui portato via dalla mia. Un giorno, baby, non ti dovrai più preoccupare di me. Bene. È l’ora dello swing.
Ma a questo punto – e siamo già a metà disco – arriva la prima sorpresa. Forse l’unica. E non sono sicuro che sia una buona sorpresa. Anche stavolta sono sufficienti i pochi secondi di introduzione strumentale per capire cosa sta per succedere: Dylan ha deciso di ritentare la progressione Pachelbel. Ci aveva provato un’altra volta, in Street Legal, e ne era risultato il brano più Kitsch di tutti i suoi anni Settanta. Ma almeno era una specie di canzone d’amore. Stavolta invece Dylan non solo ha intenzione di rivisitare la progressione barocca più adoperata nel pop, ma vuole cantarci sopra un “workingman blues”: vuole rivendicare le umiliazioni della classe operaia, con quel nobile impulso all’impegno sociale che riaffiora in lui più o meno ogni vent’anni – non lo avvistavamo più dai tempi di Union Sundown (1985): e come in Union Sundown, improvvisamente il linguaggio diventa didascalico, pane al pane e vino al vino.
Nebbia al tramonto che scende in città
luce di stelle alle rive del fiume…
Il potere d’acquisto del proletariato è crollato,
il denaro è sempre più debole.
I luoghi che amo sono un dolce ricordo,
ora siamo su un nuovo sentiero.
Dicono che i salari bassi sono necessari
per competere con lo straniero.
Le mie armi crudeli sono sulla mensola [strumenti di lavoro? o è davvero uno di quegli operai del midwest con la carabina appesa al muro?],
vieni a sederti sulle mie ginocchia:
voglio più bene a te che a me stesso,
come tu stesso puoi vedere.
Sto ascoltando le rotaie d’acciaio vibrare
ho gli occhi bene serrati.
Me ne sto qui, tentando di allontanare la fame
che si fa strada verso lo stomaco.
Troviamoci di sotto, non restare indietro,
portami i miei stivali e le scarpe.
Puoi ritirarti o dare il meglio che puoi in prima linea
cantando un pezzo di questo blues operaio.
Sospendo il giudizio. È commovente, è terribilmente ingenuo, è cantato su una progressione che secondo me sta a Dylan come l’olio all’aranciata (ditemi se a fine strofa non vi viene da attaccare col ritornello di A te di Jovanotti). Dopo Workingman troviamo il tentativo più estremo, in questo disco, di comporre uno standard per cantanti confidenziali: Behind the Horizon ha quel testo tipicamente mellifluo e inconsistente che serve soltanto a vellicarci le orecchie mentre balliamo un lento o mandiamo giù uno scotch doppio. Ma proprio mentre cominci a pensare che sia una delusione, questo Modern Times, arriva del tutto inaspettato il brano del decennio, Nettie Moore. Arriva in sordina, con un quattro quarti martellante e la chitarra che arpeggia un tema finalmente inedito. Ma la musica è più minimale del solito, serve solo a evidenziare la struttura metrica (anche quella del tutto originale). Di che parla, Nettie Moore? Di tutto e di niente. Come in gran parte dei brani di “Love and Theft“, ogni strofa è un bozzetto efficace ma autoconcluso, una storiella a sé, con protagonisti diversi e una morale non sempre evidente. Ad ascoltarla tutta cercando un significato, si ha la stessa impressione di vertigine che può dare la lettura dei libri sapienziali della Bibbia, le raccolte di proverbi: tanta saggezza sparsa un po’ qua e un po’ là, in sentenze che a volte potrebbero contraddirsi.
The world of research has gone berserk – Too much paperwork
Albert’s in the graveyard, Frankie’s raising hell
I’m beginning to believe what the scriptures tell
I’m going where the Southern crosses the Yellow Dog
Get away from these demagogues
And these bad luck women stick like glue
It’s either one or the other or neither of the two
She says, “look out daddy, don’t want you to tear your pants.
You can get wrecked in this dance.”
They say whiskey will kill ya, but I don’t think it will
I’m riding with you to the top of the hill
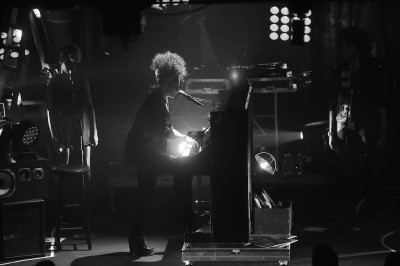 Ogni tre strofe parte il ritornello, in cui si parla d’amore e di rimpianto, ma forse è solo un modo di cambiare argomento, come in Brownsville Girl. E come in Brownsville Girl a Dylan basta un ritornello per lasciarci un ricordo indelebile.
Ogni tre strofe parte il ritornello, in cui si parla d’amore e di rimpianto, ma forse è solo un modo di cambiare argomento, come in Brownsville Girl. E come in Brownsville Girl a Dylan basta un ritornello per lasciarci un ricordo indelebile.
I loved you then and ever shall, but there’s no one here that’s left to tell.
The world has gone black before my eyes.
A questo punto cominciamo un po’ a sentirci lontani da casa – dov’è il blues, la specialità del locale? Dylan prontamente ci serve The Levee’s Gonna Break, l’ennesimo diluvio annunciato. Anche stavolta, forse non c’era bisogno di aggiungere strofe fino a totalizzare quasi sei minuti: eppure nelle interviste del periodo Dylan sostiene di aver finalmente imparato la misura, afferma non aver messo niente più del necessario. Sarà, io dopo tre minuti skippo e arrivo a Ain’t Talking, l’ultimo brano, un austero blues in minore in cui un Dylan viandante osserva la tragica condizione umana e forse mette per iscritto la crisi della sua fede religiosa.
Stavo facendo la mia passeggiata nel mistico giardino,
in un caldo giorno d’estate, nell’afa del prato.
Mi scusi, signora, le chiedo perdono,
ma non c’è nessuno qui, il giardiniere se n’è andato.
“Non sto chiacchierando, sto solo camminando”, dice nel ritornello, ed è il suo solito paradosso: si atteggia a uomo laconico, ma il suo mestiere sono le parole e ne ha per altri otto minuti. È almeno la terza volta che un suo disco si conclude con una passeggiata (dopo I and I e Highlands).
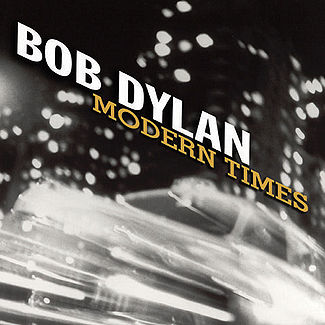
La copertina, posso dirlo? È nauseabonda. Non riesco a fissarla a lungo.
Rimane da aggiungere una cosa tutt’altro che secondaria, ovvero che con Modern Times Dylan tornò al numero delle classifiche USA. Non gli succedeva dai tempi di Desire – il suo disco numero 16: Modern Times era il 32. In realtà Modern Times non vendette molto di più di “Love and Theft” (entrambi ottennero il disco di platino, ovvero un milione di copie vendute negli USA). Desire aveva venduto almeno il doppio. Non era Dylan che stava crescendo: era la classifica che anno dopo anno si faceva sempre più stretta. Il mercato si stava contraendo, e per qualche tempo gli anziani divennero il target più ambito: non sapevano scaricare gli mp3 e avevano ancora qualche soldino da spendere in cd. Alla fine erano ancora i cari vecchi babyboomers: gente che in cielo riconosceva più facilmente l’astro cadente che le meteore degli anni Zero – in quel periodo del resto i nuovi divi rock avevano un decadimento sorprendente: spesso col secondo disco vendevano la metà del primo (Strokes, Artic Monkeys, Franz Ferdinand). Stava tutto rallentando, ma Dylan rallentava più lentamente di tanti altri: fu così che nel 2006 lo ritrovammo in testa alla gara, l’artista più anziano della storia a trovarsi in quella posizione. Chissà cosa avrà pensato.
Magari anche niente. A 65 anni avete presente come corrono le giornate? non fai in tempo a preparare la colazione che è ora di mettersi a letto.
(Gli altri pezzi: 1962: Bob Dylan, Live at the Gaslight 1962, 1963: The Freewheelin’ Bob Dylan, Brandeis University 1963, Live at Carnegie Hall 1963, 1964: The Times They Are A-Changin’, The Witmark Demos, Another Side of Bob Dylan, Concert at Philharmonic Hall, 1965: Bringing It All Back Home, No Direction Home, Highway 61 Revisited, 1966: The Cutting Edge 1965-1966, Blonde On Blonde, Live 1966 “The Royal Albert Hall Concert”, The Real Royal Albert Hall 1966 Concert, 1967: The Basement Tapes, John Wesley Harding, 1969: Nashville Skyline, 1970: Self Portrait, Dylan, New Morning, Another Self Portrait, 1971: Greatest Hits II, 1973: Pat Garrett and Billy the Kid, 1974: Planet Waves, Before the Flood, 1975: Blood on the Tracks, Desire, The Rolling Thunder Revue, 1976: Hard Rain, 1978: Street-Legal, At Budokan, 1979: Slow Train Coming, 1980: Saved, 1981: Shot of Love, 1983: Infidels, 1984: Real Live, 1985: Empire Burlesque, Biograph, 1986: Knocked Out Loaded, 1987: Down in the Groove, Dylan and the Dead, 1988: The Traveling Wilburys Vol. 1, 1989: Oh Mercy, 1990: Under the Red Sky, Traveling Wilburys Vol. 3, 1991: The Bootleg Series Vol 1-3 (Rare and Unreleased), 1992: Good As I Been to You, 1993: World Gone Wrong, 1994: MTV Unplugged, 1997: Time Out of Mind, 2001: “Love and Theft”, 2006: Modern Times, 2008: Tell Tale Signs..)





