Hanno ucciso Kennedy; è stato anche Bob Dylan?
The Times They Are A-Changin’ (1964).
(L’album precedente: Live At Carnegie Hall
Il successivo: The Witmark Demos)
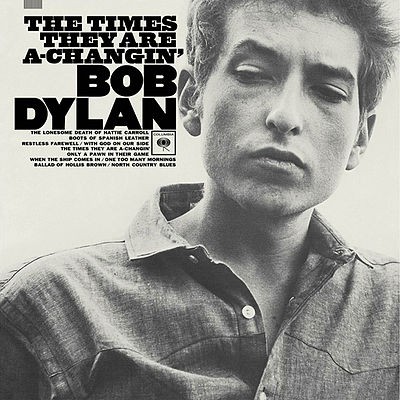
Quando William Zantzinger irruppe nell’Emerson Hotel era passata da un po’ la mezzanotte dell’otto febbraio. A voi sarebbe sembrato ridicolo, un ventenne con un bastone giocattolo da un quarto di dollaro, col quale già al ristorante aveva scimmiottato Fred Astaire e bastonato qualche cameriere. Ma era figlio di un piantatore di tabacco, era a Baltimora per spassarsela e non c’era modo di fermarlo. Si aggirava nella hall ubriaco e continuava a prendere i neri per birilli. Colpì un facchino, poi un’inserviente. La prima cameriera che chiamò “negra” scappò in lacrime. La moglie, che cercava di calmarlo, finì al tappeto. Zantzinger si ritrovò al banco del bar dove lavorava quella sera la povera Hattie Carroll. 51 anni, madre di otto figli (alcuni dicono dieci). Dammi un bourbon, negra.
“Subito signore”.
Lo stava ancora versando quando Zantzinger cominciò a colpirla sulla schiena e in testa. Sbrigati brutta nera figlia di puttana. Hattie continuò a servirlo e poi si ritirò in cucina, mentre Zantzinger ricominciava a tirar calci alla moglie. Hattie si sentiva svenire, lo disse ai colleghi: mi sento male, quell’uomo mi ha così tanto turbato (“that man has upset me so“). Morì in ospedale otto ore dopo: emorragia cerebrale. Era ipertesa, forse non lo sapeva.
Ma voi che filosofate sulle disgrazie, e criticate tutte le paure, tenete ancora a posto i fazzoletti. Questo non è il momento delle lacrime.
Il tredici dicembre dello stesso anno (ma è stato un anno lungo e pazzesco, i Beatles hanno fatto due dischi, Kennedy è stato ammazzato) il giovane promettente folksinger Bob Dylan irrompe a una cena di gala dove qualcuno (non ha neanche capito chi) ha intenzione di premiarlo. È ubriaco e nervoso perché tutti portano lo smoking. Si era portato degli amici per farsi coraggio, ma non li hanno fatti entrare, non erano vestiti abbastanza bene. Quando gli passano il microfono, lui sa che non può cantare. Deve fare un discorso, ringraziare per il premio. È questo che lo rende nervoso? Parte a ruota libera, a volte funziona; quella sera no. Se la prende coi commensali, scherza sulla loro età e le loro calvizie, si dichiara orgoglioso di essere giovane (“ci ho messo molti anni a diventarlo“). Dice che accetta il premio ma che non lo accetta; afferma con forza che non esistono più né Sinistra né Destra (“solo Su e Giù“); spiega che ha molti amici “negroes” ma che non gli piacciono le uniformi, di nessun tipo. A proposito di amici, spiega che anche Phillip Luce è uno dei suoi e che vuole ritirare il premio anche per lui. Luce è un membro del Progressive Labour Party, una scheggia maoista fuoriuscita dal partito comunista americano. In quei mesi organizza viaggi studio a Cuba (in seguito ammetterà di aver trafficato armi e organizzato covi sovversivi a Harlem). Dylan forse non se ne rende conto, ma sta parlando a una cena di autofinanziamento del movimento per i diritti civili. Sta dicendo a dei liberal rispettabili – gente che dopo il dessert dovrebbe metter mano al portafoglio – di rassegnarsi alla pensione, e che non c’è niente di strano se la gente vuole andare a Cuba. Non gli resta che tirar fuori un bastone e cominciare a menar colpi a caso. O può far di peggio?
Pochi secondi dopo, il disastro sociale che è Bob Dylan decide di spiegare che lui si sente un po’ come Oswald, il cecchino di fede comunista che aveva freddato Kennedy a Dallas (una pedina dei cubani?) “Ho visto qualcosa di lui in me stesso”, farfuglia. “Non pensavo che saremmo arrivati a questo punto, ma… devo avere il coraggio di ammettere di aver sentito le cose che lui sentiva… beh non al punto da sparare”. Dall’attentato non era passato neanche un mese, nessuno aveva smesso di pensarci. Qualcuno comincia a fischiare, lui invoca la Costituzione, il diritto di parola e ringrazia per il premio anche a nome di quelli che vanno a Cuba. “O Dio“, scriverà in seguito in una lettera di scuse, “cosa avrei dato per non essere lì” (qualcuno ancora si domanda come mai a Dylan non piacciano le premiazioni?)
Qualche anno fa successe una cosa del genere a Cannes. Lars Von Trier, all’apice della sua carriera, di fronte a un plotone di giornalisti, circondato da Charlotte Gainsbourg e Kirsten Dunst, cominciò a spiegare che per anni aveva pensato di essere ebreo, ma adesso era diverso, adesso un po’ capiva Hitler, come doveva essersi sentito “seduto nel suo bunker, alla fine…” Fu cacciato dal festival del cinema. Era stato un altro esperimento? Aveva voluto testare la tolleranza di uno dei circoli culturali più progressisti del mondo? O era stato punito da un superego capriccioso che gli rimproverava il successo mondano, che da sempre cerca di sabotarlo? (“Feci uscire tutto quello che avevo in testa e dissi: sii onesto, Dylan, sii solo onesto“).
William Zanzinger, che a 24 anni
possedeva 200 ettari di piantagione di tabacco;
e genitori facoltosi che lo proteggevano,
e amici altolocati nello Stato del Maryland,
si fece arrestare scrollando le spalle.
Imprecava e scherniva, e mostrava la lingua,
e fu fuori su cauzione, in pochi minuti.
Ma tenete ancora a posto i fazzoletti.
Questo non è il momento delle lacrime.
Quando assesta il primo colpo di bastone alla sua reputazione di cantante di protesta, Dylan ha un un disco pronto. Uscirà in gennaio. Sarà il suo disco più politico: i tempi stanno per cambiare. Niente più buffonate, niente talking, appena due canzoni d’amore, ma tristi, asciutte, rassegnate. Niente cover, tutti testi originali. Anche le musiche, tutte di Bob Dylan – o almeno così sarà scritto in copertina, e chi non sarà d’accordo se ne farà una ragione. Sarà il disco definitivo per il folk di protesta: nessuno potrà più farne uno migliore. Sarà il suo disco più impegnato: ma, ecco, cos’è l’impegno per Dylan? Come funziona, a cosa serve? A suscitare indignazione per la morte solitaria della cameriera Hattie Carroll, per l’assassino dell’attivista Medgar Evans, per la povertà che spinge Hollis Brown a uccidere i suoi figli, per i minatori disoccupati di North Country Blues, vittime precoci della globalizzazione? (“Dicono che è molto meno caro giù in Sudamerica, dove i minatori lavorano quasi per niente“). O serve a capire gli assassini, a sentirsi nei panni di Hollis Brown, di Zantzinger, di Oswald? Bisogna entrare nelle persone, cercare di capirle da dentro, o non sarà meglio osservarle da lontano, a una distanza prudente? Dylan il problema se lo è posto. È da anni che ci lavora.
Una cosa che a questa altezza ha già scartato senza rimpianti è la satira. Lo abbiamo visto cimentarcisi con Talkin’ John Birch Paranoid Blues, un brano in cui aveva creduto così tanto da cercare di proporlo in diretta televisiva. Se in seguito gli avvocati della Columbia gli avevano impedito di inciderlo nel secondo disco, ora le cose erano davvero cambiate. Blowin’ in the Wind era stata una bomba, The Freewhelin’ aveva venduto bene, Dylan stava diventando importante e nessuno gli impediva di cambiare qualche riga del testo e inserirlo nel nuovo disco. Non ci pensa nemmeno. In John Birch aveva preso di mira l’uomo comune del Midwest; aveva descritto le sue paure come paranoie, ridicole ossessioni di un ignorante. Ma Dylan è un uomo del Midwest. È lì che si è formato, è quel mondo che gli interessa recuperare. Le sue radici individuali, rimosse nei primi dischi, riaffiorano finalmente in North Country Blues. La paura di morire in un olocausto nucleare – o soffocato in un rifugio antiatomico – Dylan la conosce per esperienza diretta: era la stessa che le maestre gli avevano infuso a scuola durante le lezioni e le prove di evacuazione. Il razzismo non è un problema astratto, un virus esotico isolato nel Sud del Paese: Dylan lo ha sperimentato a Hibbing, Minnesota, quando ancora si chiamava Robert Zimmerman (“A Hibbing, i finlandesi odiavano i boemi, i boemi odiavano i finlandesi e praticamente tutti odiavano gli ebrei”). Per ridere di tutto questo dovrebbe ridere di sé stesso. Ma se ride di sé stesso, chi lo prenderà più sul serio? Dylan rideva degli anticomunisti, finché un comunista non ha sparato al Presidente. Dovrebbe fingere che non è successo, che le cose a questo punto non cambiano?
My name it is nothin’,
My age it means less.
The country I come from
is called the Midwest…
Un’altra possibilità rapidamente scartata è la canzone indignata: quella che punta il dito contro un male del mondo, più o meno specifico. Anche qui non mancano esempi di precoci tentativi: una delle sue prime canzoni, The Death of Emmett Till, era il racconto indignato di un altro fatto di cronaca, la storia vera di due buzzurri razzisti che avevano ammazzato un bambino afroamericano e l’avevano fatta franca, sulle note di House of the Rising Sun. È un pezzo efficace per quanto ingenuo (ma non lo sono tutti i pezzi di protesta? Non lo sono tutti i pezzi folk?) Dylan avrebbe potuto cantarlo a Washington senza imbarazzi. Invece se ne è sempre vergognato. Non tanto dell’ingenuità dei versi, quanto di aver pensato di poter scrivere una canzone del genere. Dalla morte di Emmett Till a quella di Hattie Carroll il passo sembra breve. Ma qualcosa è successo. Qualcosa che non ti aspetteresti da un folksinger con robuste radici nel tessuto culturale americano. Dylan ha scoperto Bertolt Brecht.
(“Hai letto molte cose di Brecht?”
“No, però l’ho letto”).
Dylan è un autodidatta, in molti sensi. Il modo con cui si confronta con la cultura, in cui impara le cose è del tutto particolare, pre-moderno in un certo senso. In Chronicles dà l’impressione di poter afferrare i concetti soltanto quando qualcuno glieli riduce alla forma orale. Può essere un amico o un tizio incontrato per caso durante una gita in motocicletta: un matto o un profeta. Quando a vent’anni comincia a farsi delle domande sulla Guerra Civile, trova indispensabile chiedere un parere a Van Ronk – il quale non fa che ribadire un’ovvietà da sussidiario. Dylan era perfettamente in grado di leggere un sussidiario, ma aveva bisogno di sentirsi dire certe cose da un Van Ronk. Dylan in realtà legge più di quanto sembri, ma anche quando si tuffa nella libreria del suo padrone di casa, descrive la sua esperienza come un incontro con scrittori in carne e ossa: Balzac sembra un suo amico, beve litri di caffè, perde un dente e si domanda: “cosa significa?” (“Balzac is hilarious“).
Hattie Carroll, che era cameriera in cucina,
con 51 anni e dieci bambini,
che serviva portate e gettava immondizie
e che in vita non sedette mai a capotavola
e che non rivolgeva mai parola ai clienti,
e che raccoglieva gli avanzi dai tavoli,
e su un altro piano svuotava i portacenere,
fu uccisa da un colpo inferto da un bastone
che girando nell’aria piombò in quella stanza,
determinato a uccidere ogni gentilezza,
e non aveva mai fatto niente a Zanzinger!
Ma voi che filosofate di disgrazie, e criticate tutte le paure, tenete ancora a posto i fazzoletti. Questo non è il momento delle lacrime.
Quanto all’incontro con Brecht, esso non passa nemmeno dalla pagina scritta: Dylan ascolta Jenny dei pirati in un teatro di Christopher Street, mentre aspetta Suze Rotolo che lavora dietro le quinte. Forse non c’è modo peggiore di accostarsi al teatro epico brechtiano, quello che a uno spettatore disincantato non dovrebbe offrire allo spettatore “suggestioni”, ma “argomenti”. Il Dylan ventenne è lo spettatore meno brechtiano che si possa immaginare. Quando nel buio della sala ascolta la storia della Fregata Nera, “tutta vele e cannoni”, che arriva in città per raderla al suolo e salvare una sola persona, la suggestione è potentissima, gli argomenti scompaiono. È il ricordo dell’infanzia a Duluth, Minnesota, porto internazionale sul Lago Superiore, dove le navi andavano e venivano in continuazione e “l’intenso fischio delle sirene ti prendeva per il collo e ti toglieva il senno… sembrava sempre annunciare qualcosa di grande”.
 Jenny dei pirati è una canzone bastarda. Brecht l’aveva scritta pensando a Polly, la capricciosa figlia del boss dei mendicanti nell’opera da tre soldi, come una infantile fantasia d’onnipotenza: un giorno al porto arriverà una nave di pirati ai miei ordini, e taglieranno la testa a chi voglio io. Quando per esigenze di allestimento la canzone passa a Lotte Lenya, che interpretava Jenny, prostituta sfiorita e degradata a sguattera, le stesse parole mutano di significato: al capriccio subentra la rabbia e l’ansia di riscatto. Trent’anni dopo, in un altro continente, Jenny conservava ancora la rabbia necessaria a diventare un inno di protesta: nello stesso 1964 e nella stessa città Nina Simone ne registrerà una straordinaria versione dal vivo. Mentre la canta Nina non sembra lasciare nessun dubbio: farà tagliare la testa a tutte quelle teste bianche che applaudono inconsapevoli. Dylan non è interessato a eseguirla: cerca invece di decostruirla. Vuole capire perché ha un effetto così potente su di lui. “La aprii e la smontai. Erano la forma, le associazioni indotte dal verso libero, la struttura e la noncuranza per le risapute certezze melodiche a renderla quella faccenda seria che era, affilata come una lama”. Dylan probabilmente non ha mai letto gli scritti teorici di Brecht. Il modo in cui arriva a cogliere qualcosa del metodo brechtiano è il reverse engineering.
Jenny dei pirati è una canzone bastarda. Brecht l’aveva scritta pensando a Polly, la capricciosa figlia del boss dei mendicanti nell’opera da tre soldi, come una infantile fantasia d’onnipotenza: un giorno al porto arriverà una nave di pirati ai miei ordini, e taglieranno la testa a chi voglio io. Quando per esigenze di allestimento la canzone passa a Lotte Lenya, che interpretava Jenny, prostituta sfiorita e degradata a sguattera, le stesse parole mutano di significato: al capriccio subentra la rabbia e l’ansia di riscatto. Trent’anni dopo, in un altro continente, Jenny conservava ancora la rabbia necessaria a diventare un inno di protesta: nello stesso 1964 e nella stessa città Nina Simone ne registrerà una straordinaria versione dal vivo. Mentre la canta Nina non sembra lasciare nessun dubbio: farà tagliare la testa a tutte quelle teste bianche che applaudono inconsapevoli. Dylan non è interessato a eseguirla: cerca invece di decostruirla. Vuole capire perché ha un effetto così potente su di lui. “La aprii e la smontai. Erano la forma, le associazioni indotte dal verso libero, la struttura e la noncuranza per le risapute certezze melodiche a renderla quella faccenda seria che era, affilata come una lama”. Dylan probabilmente non ha mai letto gli scritti teorici di Brecht. Il modo in cui arriva a cogliere qualcosa del metodo brechtiano è il reverse engineering.
Il risultato più superficiale è When the Ship Comes In, che da Jenny riprende solo il contenuto. Anche la lugubre Hollis Brown ha un tema in comune con una celebre ballata di Brecht, Dell’infanticida Maria Farrar. Più in profondità, il metodo epico è alla base di una delle canzoni anti-guerra meno indignate mai scritte, With God On Our Side. Come si fa a scrivere una canzone contro la guerra senza ribadire stancamente che la guerra è brutta? Si dà la parola a chi in guerra ci va, ci è sempre andato e continuerà ad andarci. Per orgoglio o per inerzia, o perché davvero è convinto che Dio sia dalla sua parte. Non si tratta più di sbeffeggiare un nemico, come in John Birch, o di additarlo all’odio degli spettatori, come in Masters of War. Non c’è nemmeno più un nemico: c’è una vittima coi suoi argomenti, da offrire a un pubblico che non deve provare emozioni o suggestioni, ma tirare conclusioni. Forse Dylan non aveva nemmeno in mente Madre Coraggio, ma il risultato è analogo. Così come in Who Killed Davey Moore, il pezzo davvero più simile a un rap che Dylan ha provato a incidere, la storia della morte sul ring di un pugile professionista narrata da tutti i testimoni che negano di avere responsabilità: l’arbitro, il pubblico, il manager, lo scommettitore, l’avversario: nessuno sostiene di averlo ucciso. Il giudizio spetta all’ascoltatore. Davey Moore sarà scartata dalla scaletta finale – più tardi la inciderà Pete Seeger. E arriviamo a Hattie Carroll, il penultimo brano del disco.
A Zantzinger – che il mattino seguente non ricordava più di aver bastonato membri del personale – una corte del Maryland aveva comminato una multa di 500 dollari e sei mesi nella cella di una prigione di contea. Se gli avessero dato un solo giorno di più, avrebbe dovuto scontarli in una prigione di Stato piena di detenuti neri. Così invece avrebbe svernato al caldo e sarebbe stato a casa in tempo per il raccolto.
Senonché – vedi tu il caso alle volte – il giorno in cui la giuria emise la sentenza era il 28 agosto del 1963, il giorno della marcia su Washington. Il giorno in cui forse Dylan capì di non aver ancora la canzone giusta da cantare davanti a quel pubblico, e Hattie Carroll diventò una martire dei diritti civili. Abbiamo visto come dopo l’autocensura censura di John Birch, Dylan avesse prudentemente smesso di indicare obiettivi per nome e cognome. Ma Zantzinger stavolta non sarà risparmiato (e passerà il resto della sua vita bollato da una canzone). Dylan non è più il cantastorie ingenuo dei tempi di Emmett Till, ma non sta nemmeno cercando di farla molto più complicata. Sta consegnando ai suoi perplessi ascoltatori uno strano monumento, un disco di protesta senza rivendicazioni, un disco politico senza slogan. In una realtà parallela alla morte di Kennedy è scoppiata la rivoluzione, Dylan è scomparso da qualche parte durante la controffensiva invernale dei Grandi Laghi, e i brani di The Times They Are A-Changin’ sono letti e studiati in tutte le scuole come esempi perfetti del neorealismo socialista americano: parole che denunciano ma non giudicano, che espongono ma non concludono. In questa nostra realtà le cose hanno preso una piega diversa: il teatro epico brechtiano è una curiosità che si studia nei dipartimenti di letteratura ed estetica, Dylan è diventato una rockstar e oggi forse è impossibile prendere sul serio il disco che pubblicò quando faceva finta di essere serio. Lo stesso autore cominciava a sentirsi a disagio con questo personaggio austero e smunto che sulla copertina sembra reduce da millenni di lotte e umiliazioni. Si faceva vedere in giro ubriaco, sragionava, si autodenunciava: Oswald sono anch’io.
Anche le esecuzioni tradiscono un disagio. Dylan che nel primo disco brandiva il plettro ai cento all’ora; che ai tempi di Freewheelin’ eseguiva Masters of War con la spietatezza di un metronomo, in certi momenti di The Times They Are A-changin’ sembra non sapere più in che tempo dovrebbe suonare. La chitarra di Only a Pawn oscilla per tre minuti senza decidersi, è il valzer più ubriaco mai inciso. Quello di Restless Farwell è la negazione dell’accompagnamento ritmico: mentre canta Dylan smonta gli accordi, arpeggiandoli senza criterio; li accenna come se volesse soltanto un vago sottofondo inquieto; sembra una prova incisa all’ultimo momento e invece è l’unico risultato di un’intera sessione di lavoro.
Nell’aula di udienza, il giudice batté il martello, per mostrare che tutto era giusto e le corti all’altezza del compito; e che le leggi del codice sono uguali per tutti; e che anche i potenti sono trattati allo stesso modo – una volta che la polizia li ha trovati e arrestati – e che la scala della legge non ha né cima né fondo. Così fissò in viso la persona che aveva ucciso senza motivo, per il capriccio di un momento. E parlò nella sua toga, con tono profondo e distinto; e con severità comminò, per punizione e rieducazione, a William Zanzinger sei mesi di cella.
Ma voi che filosofate sulle disgrazie, e criticate tutte le paure: prendete pure il fazzoletto, e seppellitelo nelle vostre facce: perché adesso sì, adesso è il tempo delle lacrime.
(Gli altri pezzi: 1962: Bob Dylan, Live at the Gaslight 1962, 1963: The Freewheelin’ Bob Dylan, Brandeis University 1963, Live at Carnegie Hall 1963, 1964: The Times They Are A-Changin’, The Witmark Demos, Another Side of Bob Dylan, Concert at Philharmonic Hall, 1965: Bringing It All Back Home, No Direction Home, Highway 61 Revisited, 1966: The Cutting Edge…)




