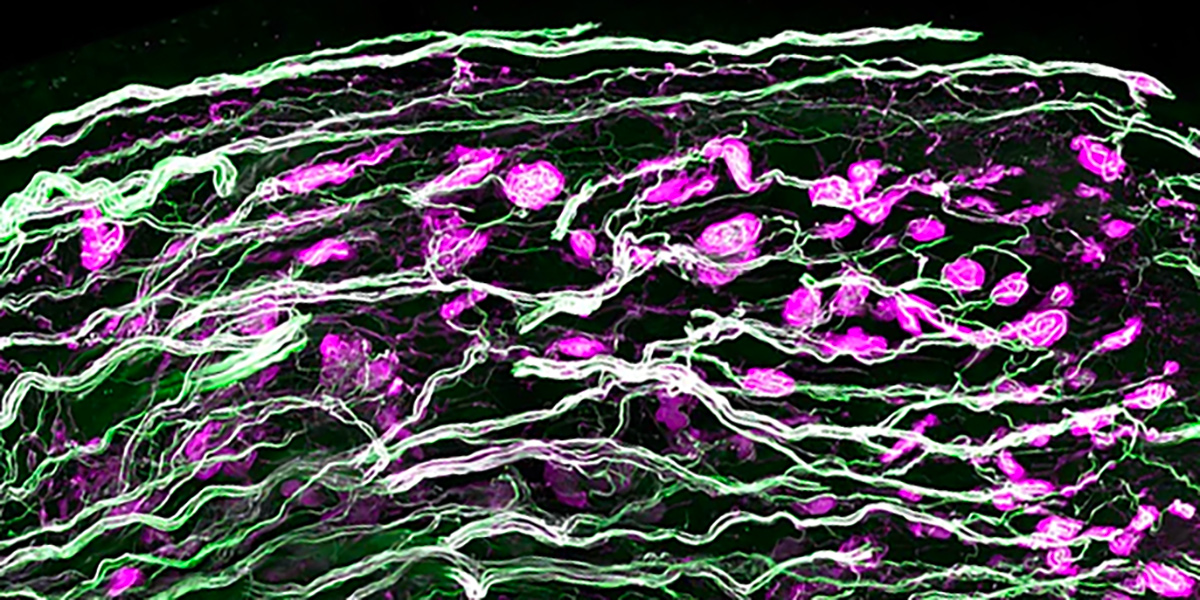Più font per tutti
Piccola storia della tipografia e questioni linguistiche: "i font" o "le font"?
di Antonio Dini
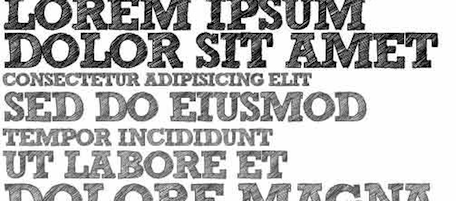
Per secoli i caratteri di stampa sono stati la tecnologia più importante del mondo editoriale, la cui conoscenza e il gusto nell’adoperarli erano riservati a pochi esperti artigiani. Oggi, che tutti in teoria possiamo essere oltre che scrittori anche tipografi ed editori di noi stessi, in realtà non ne conosciamo neanche l’abc.
Un tempo, dopo la calligrafia, anche la stampa era diventata un’arte. È iniziato tutto con la stampa moderna. Prima grazie ai coreani nel 1234 e poi grazie a Johann Gutenberg nel 1455, che ha creato la stampa basata su singole lettere mobili (“caratteri”) allineate su righe e rimovibili a seconda della bisogna, è finita l’era della scrittura a mano o delle stampe ed è cominciata quella della stampa moderna. Il cambiamento è merito di una singola innovazione: il carattere mobile in metallo.
In pratica: si organizzava su un telaio la pagina, riga per riga, con i caratteri fusi con una lega di antimonio, piombo e stagno, e poi si stampavano (“tiravano”) le copie della singola pagina con una sorta di pressa a vite, come quelle usate per schiacciare l’uva e produrre il vino. Poi, si ripeteva l’operazione con la pagina successiva.
Il segreto dei primi tipografi era la bellezza dei caratteri di stampa utilizzati: lo stile (normale, corsivo, grassetto, forte etc) e la dimensione (otto, nove, dieci punti tipografici o più). Ognuno veniva studiato, disegnato e fuso da altri artigiani, su richiesta e in quantità limitate.
Le singole fusioni dei caratteri che componevano un set completo (in cui erano necessarie un certo numero di ripetizioni di ciascuna vocale e consonante) erano raccolte in valigette chiamate “polizze”. Il termine deriva da un uso settoriale del termine “polizza” (in italiano la polizza è una scrittura privata con l’obbligo di pagamento di una data somma o di consegna di una data quantità di un bene). In tipografia con polizza s’intendeva la famiglia di un carattere (glifo) e l’elenco del quantitativo di caratteri e segni tipografici di misure e stili diversi da ordinare alla fonderia per avere il set tipografico completo. In pratica, si ordinava una polizza di Helvetica, per esempio, composta da alcune centinaia di lettere diverse, con dimensioni e stili diversi, a seconda delle bisogne.
In francese si dice – e si continua a dire – “police d’écriture” per indicare il set di caratteri (glyphes) di una stessa famiglia tipografica, cioè lo stesso “tipo di caratteri”.
Gli americani hanno subito fatto confusione. Una polizza tipografica in inglese si chiama “typeface”, ma oggi viene spesso confusa con “font” (il particolare insieme di caratteri di una stessa dimensione e stile), per un prestito linguistico dal francese medioevale: “fonte” inteso come “un qualcosa che è stato fuso” (dal latino “fundere” ). Nelle tipografie di una volta, diciamo fino a venticinque-trent’anni fa, si parlava delle “polizze” e poi delle singole “fonti”, molto spesso al femminile (“la fonte”), come vedremo poi.
C’è un altro e più pressante problema da spiegare, infatti. Come mai in italiano corrente non si parla di “polizze” se non tra i pochi tipografi sopravvissuti alla digitalizzazione, ma sempre di font?
La storia è semplice e c’è anche un “colpevole”, di cui però non sappiamo il nome. Un bel giorno di venticinque-trent’anni fa, infatti, un signore di cui la storia non ci ha tramandato il nome, si è trovato di fronte un problema: doveva tradurre dall’inglese le stringhe di testo per la localizzazione di un nuovo sistema operativo. E doveva farlo di corsa perché doveva essere tutto pronto entro metà 1984. Si trattava del Macintosh, il nuovo computer creato da Apple, e bisognava tradurre in italiano una serie di termini alquanto bizzarri (“File”, “Edit”, “Copy”, “Paste” e soprattutto “Font”, i set di caratteri che erano contenuti dentro una “valigetta” digitale).
Già gli informatici americani avevano fatto una scelta riduzionista e deciso che il termine corretto era “font”, non typeface, e neanche l’alternativa “fount”, anch’essa molto usata nelle tipografie d’oltreoceano. Il nostro traduttore probabilmente ignorava buona parte di questa storia e comunque decise di non decidere: il termine non si prestava facile all’orecchio di chi non lavorasse immerso nel gergo dei tipografi americani, e quindi lasciò tutto così com’era. Font divenne così font. Dopotutto, anche computer è una parola che deriva dall’inglese, pur esistendo più di un equivalente in italiano.
Il nostro uomo scelse anche di risolvere nel modo più semplice il problema (da lui ignorato) del genere della parola. Font in inglese è neutro e l’italiano solitamente introduce nella lingua i termini neutri con il maschile. Così dunque è stato a partire da fine anni Ottanta anche per font, nonostante ci fossero alcuni secoli di tradizione al femminile nelle tipografie: le font, le fonti, le polizze.
*
Il problema è stato che la rivoluzione informatica del personal computer ha creato anche la nascita del cosiddetto “desktop publishing”, proprio con il Macintosh. Per la prima volta si potevano impaginare a video i testi, addirittura fare gabbie grafiche molto complesse, preparare i documenti elettronici per la stampa che, grazie a un innovativo linguaggio chiamato PostScript, da cui poi Adobe ha costruito la sua fortuna insieme ad Apple, si potevano mandare elettronicamente in tipografia e vedere realizzati in tempi brevissimi libri, giornali, brochure.
Il Mac era il primo computer che faceva vedere quello che poi si sarebbe ottenuto in fase di stampa, il primo ad introdurre le stampanti laser pensate dai geni dello Xerox Parc, il primo a consentire di cambiare carattere in tutto il sistema e nei documenti, sia come stile che come genere e dimensione.
La parola “font” al maschile è così diventata una consuetudine per tutti, in America, Regno Unito e ovviamente Italia. I francesi distinguono invece fra “police matricielle” e “fonte de caractères” mentre per i tedeschi ci sono gli “schriftart” e gli “schriftschnitt”.
Oggi è diventato tutto digitale. Font indica indifferentemente il grafema, i glifi e la loro singola manifestazione come carattere di stampa. Da qui regna sovrana la confusione fra linguisti, studiosi di arte e tecnica tipografica, i tipografi e il resto di noi che usiamo il computer. Come orientarsi? Proviamo con una guida molto semplice.
In breve: per la tipografia il grafema è la rappresentazione concreta di un glifo a cui sono state aggiunte le caratteristiche stilistiche. Il glifo è un’unità grafica elementare, il grafema invece è un elemento del testo. Se prendiamo un glifo in particolare, di quel certo stile, dimensione, corpo etc, abbiamo un font, cioè un tipo specifico di carattere.
Facciamo un esempio. La lettera dell’alfabeto scritta è un grafema (ad esempio la “c” è un singolo grafema che corrisponde a due fonemi o suoni: la “c” e la “i” che diciamo quando pronunciamo la consonante). La lettera “C” dell’alfabeto quando viene scritta utilizzando l’Helvetica è un glifo, e quando la scriviamo usando la nostra videoscrittura con la “C” dell’Helvetica a dimensione 14 punti e corpo normale è un font, cioè un particolare carattere.
Peccato che con l’avvento del computer, delle semplificazioni (e per l’Italia anche delle traduzioni) approssimative, sia diventato tutto “font”. Invece, si potrebbe al limite parlare di “polizze” e di “famiglie di fonti” e semplificare un po’ la vita a noi comuni mortali.
Anche perché con l’arrivo dell’elettronica, sono nate intere famiglie di fonti che non sono state pensate per la stampa ma solo per essere mostrate a video. E qui cambia di nuovo tutto, perché la stampa su carta è ben diversa dalla renderizzazione a video (catodico prima, Lcd ed E-Ink poi). E questo è un fattore critico quando si passa dal consumo della carta stampata (libri e giornali) a quello dei bit via internet (Kindle e il Post, ad esempio). Vediamo meglio.
Abbiamo usato, per gli esempi fatti sinora, una delle famiglie di fonti più note: l’Helvetica. Nata negli anni Cinquanta grazie a due tra i più famosi grafici progettisti di caratteri di stampa, gli svizzeri Max Miedinger ed Eduard Hoffmann, Helvetica è diventata un classico istantaneo e la sua storia è stata persino immortalata in un film-documentario di rara bellezza, realizzato da Gary Hustwit. Helvetica è una famiglia di fonti gloriosa perché pensata per rendere al massimo nella stampa su carta e su mille altre superfici. Oggi tappezza letteralmente la nostra vita nel mondo fisico. Non è così nello spazio video del digitale.
Infatti, quando il Macintosh è sbarcato nei negozi, nel 1984, il suo sistema operativo utilizzava una famiglia di fonti studiata apposta per non essere stampata da nessuna parte: Chicago. Questa famiglia di fonti doveva infatti popolare i menu e le scritte sotto le icone dello schermo a nove pollici del primo modello. A disegnarlo era stata una grafica di New York, Susan Kare, che per inciso è anche la “madre delle icone”, dato che ha creato sia per Apple che per Microsoft i disegni delle prime generazioni di icone sulla scrivania dei computer, dal cestino alla filza per documenti, comunemente chiamata cartella.
Susan Kare per l’occasione aveva creato anche altre tre famiglie di fonti: New York, Geneva e Monaco. Negli anni della prima rivoluzione digitale si erano aggiunti altri nomi di città, come Athens, London, Los Angeles, San Francisco e lo straordinario Venice, mentre la tecnologia con la quale venivano realizzati i caratteri è cambiata lentamente ma in modo radicale: dal sistema bitmap si è passati ai caratteri vettoriali realizzati come TrueType o PostScript. Chicago è stato usato dal 1984 fino al 1997, ma ancora per qualche anno nel nuovo millennioè stato possibile trovarlo ad esempio sui display dei primi iPod.
Oggi le famiglie di fonti studiate per lo schermo e quelle studiate per la stampa si incrociano e si sovrappongono. Sulle superfici digitali dell’iPad si usano caratteri nati per dare il meglio quando vengono stampate su carta, mentre sulle rotative vengono fatte correre intere famiglie di fonti che mai avrebbero pensato un giorno di poter essere stampate.
I tipografi di un tempo non avrebbero mai fatto tanti errori da principiante.